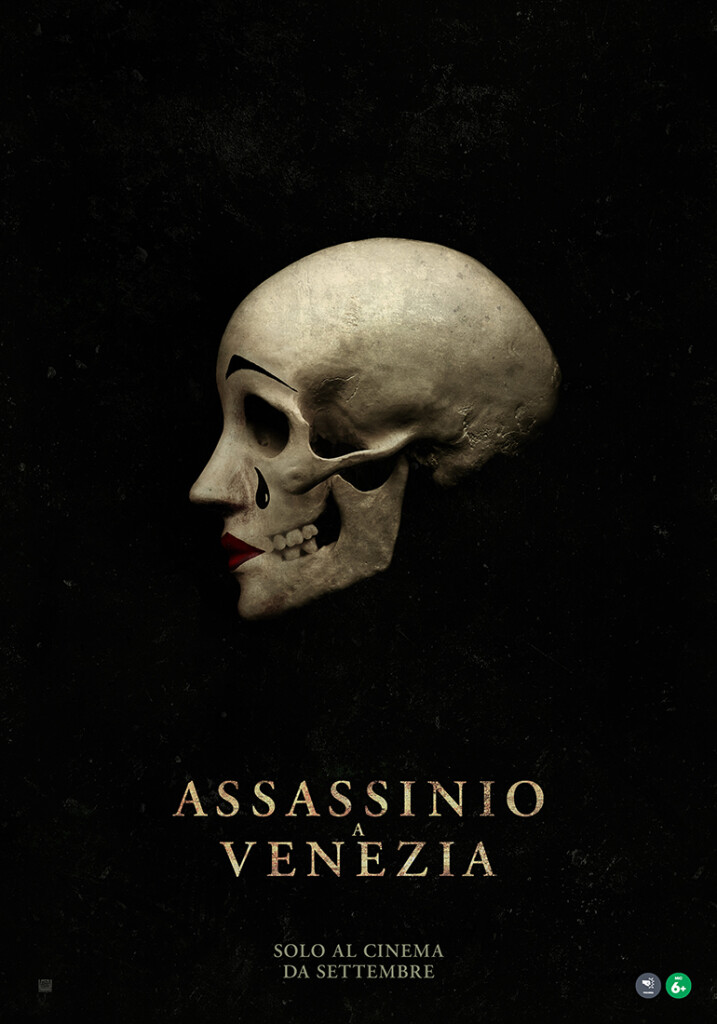IL TRADITORE, recensione

Ebbene, siete pronti per la nuova kermesse veneziana e festivaliera? Poiché, come i ben informati sanno, in extremis, no, all’ultimo minuto, Guadagnino, per ragioni diramateci e assai note, è stato sostituito con Edoardo De Angelis che, all’80.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presenterà, ovviamente, in world premiere, cioè anteprima mondiale, il suo opus intitolato Comandante con l’oramai onnipresente ma indiscutibilmente eccellente Pierfrancesco Favino. Forse il miglior attore italiano in circolazione, attualmente. Specializzatosi, infatti, vertiginosamente in performance via via in crescendo esponenzialmente perennemente, lavorando, sempre meglio, con registi d’alto profilo, insindacabilmente, Favino è, checché ne dicano i suoi odiatori, ahinoi, questi sì, tremendi e deficienti, un attore che, apportando, chirurgicamente e pian piano, migliorie significative al suo stile recitativo, soventemente ma soprattutto inizialmente con la sordina e con una voce “così così”, malgrado ne L’ultima notte di amore qua e là tentenni, nella “dizione” adattata forzatamente nella calabrese cadenza, specialmente, in tal Il detrattore, eh eh, no, Il traditore, sfodera e sfoggia una prova mastodontica, brillando di fulgida luce propria, cementandosi, con esiti da applausi a scena aperta, come si suol dire e, diciamo, in gergo, con un personaggio difficile sotto ogni punto di vista, con molte ombre, ovverosia nientepopodimeno che Tommaso Buscetta, detto Masino.
Film del 2019 di Marco Bellocchio, cineasta che, naturalmente, non necessita d’ulteriori presentazioni superflue, reduce peraltro, assai recentemente, dall’imperfetto ma decisamente ammaliante, perturbante, in gran parte estasiante, Rapito. Pellicola da me recensita appena in sala uscì che, perlomeno nella prima ora e mezza, totalmente mi rapì, deludendomi soltanto, parzialmente, aggiungo e puntualizzo precisamente ivi, verso la fine, in quanto, a mio avviso, si smarrì troppo didascalicamente in digressioni prolisse e irrilevanti ai fini dell’intreccio da Bellocchio illustratoci. Recuperato ora, tramite Netflix Italia, per l’appunto su tale piattaforma per cui, alla faccia dei romantici, più che altro anacronistici fautori della visione esclusivamente sul grande schermo, pago regolarmente e mensilmente l’abbonamento, Il traditore è un signor film da disaminare finemente e per niente da snobbare facilmente. Se non l’avete mai visto e vole(s)te conoscerne la trama in molti dettagli, recatevi qui su Wikipedia ma, ugualmente, ne ricaverete informazioni approssimative e verrete a conoscenza d’alcuni spoiler sgraditi: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_traditore_(film_2019).
Romantico in senso lato o prettamente letterale, romanza parecchio, certamente. Eppur, parimenti, affascina grandemente nella sua sottile amalgama fra il documentaristico e il neorealistico più bellocchiano. Poiché Bellocchio, al solito e ottimamente, permea la sua materia filmica di pathos raffinato, narrandoci i fatti “realmente avvenuti” attraverso i suoi immancabili topos a base d’incubi in piena notte e scene sia allucinanti che allucinatorie, improvvisamente inquietanti. Su tutte la raccapricciante e inaspettata scena, da pelle d’oca, dell’arrivo della prostituta bona e super mignotta in carcere col “fedele”, giammai veramente pentito Masino/ Buscetta/Favino che, fra le sbarre da poco ma ospitato in una camera confortevole, forse non propriamente in una suite d’albergo a 5 stelle, però allo stesso tempo corredata di buon televisore e “accessoriata” dignitosamente a misura d’uomo e non di mafioso moralmente sia onorevole che misero, dopo la telefonata registrata ma erotica con la moglie (la sexy Maria Fernanda Cândido, invero poco candida nel suo torbido character da caliente bastarda, la quale, sbattendosene di essere dai poliziotti ascoltata, si tocca totalmente ignuda e sudata, con la f… ga accaldata e, chissà, profumata), non resiste più all’astinenza della carne e il suo matrimonio presto profana, sì, lo manda a puttane, è il caso di dirlo, con la bagascia eccitata, no, succitata. E, indisturbato, barbaramente e burberamente le chiede imperiosamente di spogliarsi, scopandosela nel bel mezzo della prigione più stronza di Palermo.
Insomma, schizzandovi, no, scherzandovi sopra, appena dopo l’estradizione e l’incarcerazione, non vediamo la sua fottuta erezione (non siamo in Diavolo in corpo con annessa fellatio storica) ma assistiamo, comunque, a una serena, mostruosa trombata da “motherfucker” di “Cosa Nostra”.
Attenzione, dirimpetto a Giovanni Falcone, in una delle sue prime confessioni della sua istruttoria, Buscetta vi tiene a specificare che l’organizzazione criminale in questione si deve chiamare esattamente con la sua giustizia, no, giusta espressione. Giustappunto, Cosa Nostra, e non mafia. Per dovere di cronaca giornalistica e/o mafiosa, sulla giustezza del termine esatto, sarebbe da domandare a Francis Ford Coppola con la sua “famiglia” de Il padrino, a Martin Scorsese di Quei bravi ragazzi e perfino a Luc Besson di The Family, altresì conosciuto, anzi, da noi distribuito col titolo Cose nostre – Malavita. Con un boss di nome Don Lucchese che non è lucano, non è basilisco, forse è siculo, eh eh, è semi-analfabeta ma legge La Repubblica (incredibile!), ah ah, e De Niro che si chiama improbabilmente Giovanni Manzoni (la colpa non è di Besson, attenutosi fedelmente al libro dello scrittore Alessandro de I promessi sposi, no, di Tonino di Pietro, no, di Benacquista) e, al cineclub, riguarda sé stesso nell’appena scrittovi, poc’anzi, Goodfellas.
Non è morbosità… la mia… ma la scopata con la zoccola, prima descrittavi, è una scena fra le più emblematiche e disturbanti dell’intera opera presa in anale, no, Analyze This, no, analisi. Che riassume al meglio lo spirito ambiguo di questo film porco, no, volutamente equivoco che rivela i panni sporchi delle merde e li smerda, sputtanandoli in toto. Contemporaneamente, accusando lo Stato “impunito” e magnaccia, anzi, costituito da magna magna. Poiché Bellocchio non magnifica Buscetta ma neppur lo condanna… Lo riduce quasi a santino e dunque lo santifica, lo perdona per le sue “marachelle?”. Buscetta di tutto se ne fotté, persino del maiale Totò Riina. Qui interpretato da Nicola Calì. Da non confondere con Pippo Calò/Fabrizio Ferracane. E ne pagò le conseguenze. Morendo da solo come un cane o per colpa d’un impietoso Cancro?
Mentre il suddetto Falcone è lo stesso attore che interpreta, anzi, poi avrebbe rivestito i panni del padre disperato di Edgardo Mortara in Rapito, alias Fausto Russo Alesi. Luigi Lo Cascio, invece, qui siculo d.o.c., memore de I cento passi, è Salvatore Contorno. Sopra, ho menzionato Terapia e pallottole. Lo Cascio/Contorno, dopo essere stato momentaneamente liberato, trova un lavoro da venditore d’auto costose a mo’ del Paul Vitti/De Niro di Analyze That, vale a dire Un boss sotto stress.
Giulio Andreotti è Pippo Di Marca. Parafrasando Paolo Bonacelli in Johnny Stecchino, per cui la più grande calamità vergognosa della Sicilia è o sarebbe la siccità, ah ah, no, lo stesso suo autore-attore Roberto Benigni, Di Marca non c’assomiglia pe’ niente! E sembra più una macchietta del Bagaglino à la Pippo Franco. Scritto dallo stesso Bellocchio, su soggetto originale, con suo figlio Pier Giorgio nel piccolo ruolo di Cesare, e l’incursione nel pre-finale di Bebo Stori as avvocato Franco Coppi, Il traditore è molto didascalico, si adagia su toni melodrammatici da fiction (essendo prodotto, non a caso giuridico-penalistico, no, in modo televisivo, da Rai Cinema), in alcuni momenti e attinge, cronachisticamente, processualmente metaforicamente, a programmi appartenenti pressappoco alla collocazione temporale delle varie vicende snocciolateci, come per esempio Un giorno in pretura. Vi è anche un cammeo della bella Miriam Previati.
Il traditore è prolisso, Favino è superlativo, ha tantissimi difetti, comprese alcune sequenze girate ingiustificatamente in digitale (Bellocchio non è Michael Mann di Nemico pubblico), fotografate però superbamente da Vladan Radovic, è stato musicato egregiamente da Nicola Piovani (La vita è bella, ah, sempre Benigni di mezzo, oh oh), andava scorciato e meno retoricamente filmato. Nel suo insieme fatto di andirivieni soprattutto emozionali, inchioda dal primo all’ultimo minuto, esagera sovente e carica eccessivamente d’enfasi ma, alla fin fine, sostanzialmente, è un film importante. Forse non memorabile ma giustamente angosciante.
di Stefano Falotico
SOLO DIO PERDONA (Only God Forgives), recensione



Ebbene, anzi, orsù! Ivi sganciato da costrittivi, forsanche pedanti legami editoriali, in attesa, la settimana prossima, di vedere About My Father (poi recensendolo, mi auguro, di testata attestata con nome e cognome miei firmati), scelleratamente intitolato Papà scatenato con De Niro, memore io di essere, malgrado tutto e dopo tanta acqua, come si suol dire, sotto i ponti trascorsa, sì, passata, l’incarnazione, in passato e, ribadisco, a tutt’oggi di Hugh Grant di About a Boy, prodotto da De Niro stesso, ravvisando lo spopolare di meme e foto di Ryan Gosling di Barbie, su Facebook e altrove, decisi, in codesto oramai terminato pomeriggio del 19 luglio (leggerete questo pezzo nel dì seguente, ovvero quello presente e in corso attualmente, eh eh, di ribaltamento lessicale delle parole o solo spazio-temporale), di assistere alla visione, finalmente completata(ta), del film seguentemente da me disaminato. Anzi, scusate, prontamente rettifico per dovere di mnemoniche cronache mie da Blade Runner 2023 e non 2049, di tal Only God Forgives comprai, un paio d’anni or sono, perfino il Blu-ray ma non ne completai, giustappunto, giammai la visione. Solamente, precisamente, appena l’iniziai. Non so perché. Non ricordo bene…
Che io mi ricordi invece perfettamente, dopo il clamore succitato, no, suscitato dalla coppia artistica Nicolas Winding Refn + Gosling dell’acclamato (non da Paolo Mereghetti, però) Drive, la “combo” tornò a lavorare assieme quasi istantaneamente, ripresentandosi al Festival di Cannes, in Concorso…
A differenza di Drive (2011) che, alla kermesse cannense appena sopra nominatavi, piacque molto a pubblico e Critica, aggiudicandosi meritatamente il Prix de la mise en scène, addirittura scontentando i più che avrebbero voluto vincesse nientepopodimeno che la Palma d’oro, Solo Dio perdona (2013) fu bombardato di sonori fischi e pesantissimamente ingiuriato. Ancora adesso, il sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com, ne riporta un’assai insufficiente media molto grave e oso dire “gravosa”, ovverosia equivalente all’ingiusto 37% di pareri nettamente negativi. Sì, una media non congrua al valore del film che meritava e merita ampiamente una “votazione” maggiore ma intendiamoci, al contempo, su un altro aspetto imprescindibile… A me Refn piace abbastanza ma non appartengo alla lista di suoi estimatori incalliti e miopi che hanno il prosciutto davanti agli occhi e si lasciano troppo accecare dalle sue celebri luci stroboscopiche. Perdendo visivamente le sue immagini, no, smarrendo la loro stessa “vista” obiettiva. Solo Dio perdona dura poco, cioè a malapena un’ora e mezza, ciò non è affatto un male ma ha evidenti difetti e, specie all’inizio, è soporifero in maniera indigeribile. La prima mezz’ora, sì, “allunga” il minutaggio di questa pellicola in modo indicibile. Non è dunque un capolavoro, neppure un bel film. Eppur non è brutto come riportatovi e riportatoci. Riportandovi invece sottostante la sinossi rilasciataci da IMDb:
Julian, uno spacciatore di droga che prospera nel mondo della malavita di Bangkok, vede la sua vita complicarsi ancora di più quando la madre lo obbliga a cercare e uccidere il responsabile della recente morte del fratello.
A proposito di Mereghetti, ostinato e ottuso detrattore di Refn, in merito, ai tempi della presentazione di Only God Forgives a Cannes, nell’editoriale del Corriere della Sera, tronfiamente asserì quanto segue: «Una scelta, quella di voler ribadire a tutti i costi il proprio “messaggio”, che invece Nicolas Winding Refn cavalca con testarda protervia. Se Drive era costruito sul tentativo di ridurre il film noir ai minimi denominatori, depurandolo di ogni elemento superfluo per mostrarne solo le caratteristiche fondative, questo Only God Forgives (Solo Dio perdona) si sforza di andare oltre: lunghi primi piani muti, improvvise esplosioni di violenza e una catena di vendette incrociate a partire da una ragazzina stuprata e uccisa. Ma per vendicare l’uccisione dello stupratore, non della vittima! Così vuole la madre di due fratelli (l’assassino senza un perché e un catatonico Ryan Gosling) interpretata da una Kristin Scott Thomas agghindata come Donatella Versace (regista dixit), mentre tutti si muovono come in un acquario. Il risultato è molto più che irritante, fintamente cinefilo e naturalmente misogino. Ma soprattutto sprovvisto di senso. Oscar Wilde amava ricordare che gli armadi chiusi possono anche non nascondere niente. Winding Refn ci conferma che quell’osservazione vale anche per i film. Soprattutto per il suo».
Parafrasando il citato Wilde, il “citazionista” Mereghetti ci conferma che l’affermazione di Wilde potrebbe rispecchiare la vacuità e stolta vanità di molte sue sterili uscite fuori luogo e senza senso logico.
Ora, chiarito questo, diciamo anche che Only God Forgives vale più di quello che si dice e meno di quello che i fanatici di Refn dicono ma questo l’avevo già detto.
Ci presenta un Gosling edipico, stordito, nei panni di un personaggio coglione sin in fondo, un fratello “Tetsuo”, interpretato per pochi minuti, nell’incipit, da Tom Burke, sì, molto sessualmente dotato anche se non glielo vediamo, uno con un c… zo enorme, stando alle parole della “madre”-amante di entrambi, una Kristin Scott Thomas probabilmente incestuosa di tutti e due i figli stronzi, una Scott Thomas mai così “troia” e bella, e un villain imbattibile e impagabile che non sarà ucciso da nessuno, sarà lui a uccidere tutti perché è giusto così, gli hanno barbaramente stuprato la figlia e macellata. Allora, lui diventa un macellaio per mano di “dio”. È Chang, incarnato da un magnetico e insospettabilmente atletico Vithaya Pansringarm.
La fotografia, a cura di Larry Smith, mette i brividi, la Scott Thomas, ancora evidenziamolo, è una grande attrice e una donna maliarda dal fascino irresistibile (anche se son passati esattamente dieci anni da allora e non è più come a quei tempi), le musiche di Cliff Martinez (pre-Stranger Things e sapete perché) parimenti ipnotiche.
Refn pecca di compiacimento per la violenza, come sempre. È un suo violento orpello, metaforicamente parlando e perdonatemi per il voluto gioco di parole, più fastidioso della sua messa in scena ripiena di violence.
Cosicché, dopo la prima visione, a caldo o a freddo, fate voi, può sembrare che Refn ci abbia preso platealmente per i fondelli. Per non dire altro. E che sia stato più triviale, in alcune battute, del solito e disgustoso di un lato messo lì, “alla culo”, del peggior Tinto Brass.
Ma Solo Dio perdona rimane stranamente dentro, angoscia ed è uno sleeper spaventoso, agghiaccia, scuote, perturba, non assomiglia a niente visto prima sebbene scopiazzi mezzo Cinema orientale mischiato a quello scandinavo e statunitense, perfino nostrano ed europeo, così peraltro come molti sostengono, non del tutto a torto.



di Stefano Falotico
INDIANA JONES & il Quadrante del Destino, recensione
Ivi, sganciato da vincoli editoriali, libero come un delfino, inseguo la creatività recensoria più libera. Giocando, nel finale, di voluta demenzialità, per modo di dire, innocua. Scrivendo quindi una review tipicamente mia.
Ebbene, il sig. Harrison Ford, autodefinitosi sboccio ritardato, classe ‘42, il quale dunque compirà ottantatré primavere nell’immediato, ovvero la prossima settimana, più precisamente nel dì del 12 luglio assai venturo, qui è catapultato in una nuova avventura del professor Jones. Uno dei suoi maggiori personaggi iconici, il più rappresentativo della sua vasta, eppur a ben vedere nemmeno così prolifica, filmografica carriera attoriale. Forse, perfino il più importante a livello d’immaginario collettivo suscitato non solo nella generazione appartenente alla collocazione temporale de I predatori dell’arca perduta. In ordine cronologico, no, storico, no, per l’appunto iconico, Indiana Jones primeggia infatti, a mio discutibile avviso, al primo posto del podio fordiano, svettando fra Han Solo (Ian, nella versione italiana della saga di Guerre stellari) e il suo “androide” umanissimo, detective privato avveniristico di Blade Runner. Capolavoro immarcescibile di Ridley Scott che non fu sviluppato in un franchise ma originò l’impensato, qualche anno fa finalmente realizzato, interessante, anche se probabilmente irrisolto, di certo non irrisorio, sequel denominato… 2049, da Denis Villeneuve firmato e, ovviamente, dallo stesso director del capostipite e di Alien… patrocinato. Tornando invece a questo quinto capitolo dedicato alle peripezie del dr. Jones, dopo la tetralogia a cura di Steven Spielberg, quest’ultimo, sempre immancabilmente produttore (che furbone), consegna a James Mangold tale proseguo. Mangold, un nome che, ahinoi, a distanza oramai di quasi quattro decadi da Dolly’s Restaurant, malgrado il notevole, all’epoca sottovalutato però, Cop Land, e tante pellicole più o meno pregevoli, quali per esempio il biopic su Johnny Cash, intitolato Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line con Joaquin Phoenix, i suoi due movies dedicati a Logan, alias Wolverine con Hugh Jackman, oppure Le Mans ‘66, è inspiegabilmente un nome che non dice quasi nulla ai cosiddetti cinefili. Soprattutto dell’ultima ora. Ma cinefili di che? Se non conoscete Mangold, peraltro autore del bel remake Quel treno per Yuma, lasciate stare la settima arte e prendete una foto di Liv Tyler degli anni novanta e dell’esordio mangoldiano succitato per eccitarvi, strabuzzare gli occhi e muoverli come Pruitt Taylor Vince, ah ah.
Indiana Jones and the Dial of Destiny dura la bellezza di 154 minuti netti, abbastanza scorrevoli e godibilissimi, checché ne dicano le malelingue e, per l’appunto, gli improvvisati, pseudo-critici di oggi. Che Carmelo Bene, se fosse ancor in vita, definirebbe così come già definì quelli di allora, cioè dei becchini-monatti senz’arte né parte, eletti a giornalisti forse della loro mortuaria vita fac-simile rispetto a un’esistenza vera e propria. Il critico di ieri e di oggi, infatti, è uno zombi vivente, una specie di uomo non senziente, quindi demente. Le ridicole considerazioni di questa falange di esseri putrefatti, perciò, in merito a questo film, sono inesistenti, oso dire inconsistenti. Fragilissime ed evaporanti come neve al sole. Per quanto mi concerne, mi par invece irrilevante starvi a specificare i dettagli di tal Indiana… Sarei pleonastico e immotivatamente, giustappunto, banalmente giornalistico…
Per saperne la trama, guardate il film, altresì, per conoscere i writers della sua sceneggiatura e per venire a conoscenza di qualche curiosità e/o dettaglio tecnico, affidatevi a Wikipedia. Ne ricaverete una sommaria infarinatura da Matusalemme mausolei qual siete, cari uomini e donne privi di fantasia e soprattutto, ripeto, morti dentro da tempo immemorabile e irrecuperabile più del Graal…
https://it.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_e_il_quadrante_del_destino
Allora, avete letto tutto, analfabeti e archeologi del vostro essere delle mummie imbalsamate da Carbonio-14? Partiamo dagli attori, innanzitutto tenendo Harrison quasi per ultimo…

Phoebe Waller-Bridge è sexy? Macché, è insipida e financo poco simpatica. Comunque, se si spogliasse interamente ignuda dinanzi a me, mi darei a un’ispezione da “speleologo”. Mads Mikkelsen è un bravo attore ma non mi piace molto. Piace invece alle donne. Ca… li loro, anzi, il suo se glielo darà, no, sempre che glielo dia, se dio o lui vuole, ah ah. All’appello ci mancava solo Antonio Banderas, oramai mister prezzemolino ma, specialmente, sempre più bruttino e vecchiettino. Mentre Harrison invecchia come il buon vino? Purtroppo, no. Sembra più stagionato d’un pessimo Chianti da Hannibal versione Mikkelsen o in quella insuperabile, originale, a prescindere da Brian Cox di Manhunter, di Anthony Hopkins? Poi, diciamoci la verità, per quanto Julianne sia e fosse bella, non poté e non può competere con Jodie Foster, mentre sir Anthony girò Hannibal del già menzionato Ridley Scott soltanto per ubriacarsi, da ottimo ex alcolista redentosi (?), scolandosi, in quel di Firenze e appenino toscano limitrofo, eh eh, non solo i vini migliori, bensì anche le donne da osteria più adatte alla sua “signorilità” da Balanzone ubriacone. Ma che sto dicendo? Non perdiamoci… Il film si perde nella parte centrale ove Mangold, memore degli impresentabili inseguimenti stradali di Innocenti bugie con Tom Cruise, in tali strade, no, in questa circostanza rocambolesca e non poco grottesca, non si dimostra all’altezza dei vari Mission: Impossible… Per Harrison pare impresa improba, diciamo pure inverosimile, essere credibile nelle scene d’azione senza ringiovanimento facciale ma l’incipit di tale pellicola è superbo. Sì, non scherzo. Potrete e possiamo assistere, infatti, al “nano” Toby Jones (sì, ha lo stesso cognome di Indiana) che corre su e giù per un treno, anche sopra esso, con destrezza da controfigura di Harrison Ford del tempio maledetto… Prodigioso, oso dire, una stronzata clamorosa! Boyd Holbrook… non è quello del Predator non ca… to da nessuno e il “figlio” del personaggio di Ed Harris in Run All Night con Liam Neeson? Sì, in quest’ultima pellicola, veniva quasi subito fatto fuori. Ca… o, pensavo fosse morto! Ancora lo chiamano per “recitare?”. Non era stato invece assunto, da redivivo, alla gelateria del quartiere Lame, Belli Freschi? Naturalmente, hanno anche richiamato Karen Allen. La quale giammai si riprese dopo aver perso il suo “doppio” Jeff Bridges di Starman. Da allora, infatti, vagò e vaga da sola in casa, impazzita totalmente e vedendo, in modo allucinatorio, soprammobili volanti a mo’ di UFO di Incontri ravvicinati del terzo tipo, inoltre riguardando Poltergeist di Tobe Hooper. Ma quale Hooper! È di Spielberg con la firma del regista di Non aprite quella porta. Sì, meglio non aprire la porta di casa di Karen Allen. Oggigiorno, la sua faccia fa più paura di quella di Leatherface. The Texas Chainsaw Massacre! No, non voglio massacrare… il Quadrante del Destino, è completamente salvabile, non va stroncato o segato ma, ribadisco, con tutta onestà, dovete credermi, è molto amabile. Ah, scusate, mi son dimenticato di John Rhys-Davies. Aveva già la faccia del vecchio in… The Last Crusade, adesso riappare, no, appare più giovane, senza CGI, di quando era, fisicamente, più rimbambito del Ford odierno.
In conclusione: ne vogliamo parlare perché mai Banderas decise di parteciparvi per 10 min. scarsi? Voto 7 e, bando alle ciance e alle ipocrisie, la sgallettante Waller-Bridge se non avesse, come me, il naso lungo e non sfoderasse spesso espressioni da S. Chiumenti, ovverosia una mia ex compagna delle scuole elementari secchiona e, francamente, rimasta racchiona, sarebbe un’incontestabile figona e sensuale guagliona arrapante. Il corpo c’è tutto, il corpus recitativo assai meno e il viso fa schifo al c… o. No problem, basta un cuscino sopra. Anzi, per me il problema non sussiste. Non ho i soldi per invitarla a cena, se mai eventualmente un giorno la incontrassi al Festival di Venezia. Credo, infine, che Calista Flockhart sia stata gelosa di Phoebe durante le riprese di questo film. Perché Harrison è ancora un bell’uomo? No, perché Phoebe, pur di sistemarsi definitivamente a Hollywood, un servizietto al Matusa da sarcofago… probabilmente glielo avrebbe fatto e, chissà, glielo fece perbene…
Da cui il “filmino”, ricercato più di …The Lost Ark e del “vaso di Pandora” d’Archimede, vale a dire Indiana Jones & l’ultima trombata... in ogni senso, anche quello b. Ah ah. Il film non merita un hip–hip–urrà ma sicuramente un Eureka?
di Stefano Falotico
IL CAIMANO, recensione
Doveva essere il film più cattivo e lapidario di Nanni Moretti sulla sua ossessione maggiore dai primi anni novanta in poi, cioè Berlusconi. Invece è, se non il suo film peggiore, il più scioccamente pretenzioso, banale e inconcludente. Sebbene, a tratti, addirittura struggente.
Ebbene, come sappiamo, il cavaliere Silvio Berlusconi morì lo scorso 12 Giugno in quel dell’Ospedale San Raffaele, a Milano. Città, peraltro, ove nacque, sì, natia. Insomma, che gli diede i natali, ovvero esattamente nel giorno, per nulla nefasto per la Sinistra italiana e per i benpensante catto-borghesi moralisti, del 29 Settembre del ‘36.
Il caimano, firmato da Nanni Moretti, che si ritaglia una piccolissima apparizione (anche altro ma vi dirò poi), da lui stesso scritto, inevitabile suo punto d’approdo e compromesso fra Cinema impegnato-scanzonato con echi malinconici à la Aprile, ove divenne emblematica quella sua frase sibillina… D’Alema di’ (seconda persona singolare da non confondere con dì, cari illetterati) qualcosa, e ideologico pamphlet vagamente accusatorio anti-berlusconiano, ruffiano verso il suo pubblico forse radical–chic e i suoi irriducibili aficionados incalliti e duri a morire, è una pellicola del 2006, sopraggiunta decisamente prima di Loro per la regia di Paolo Sorrentino che, immediatamente, ivi interpreta il marito di Aidra (Margherita Buy), personaggio fittizio appartenente alle pellicole (a metà strada fra il trash più becero e pre-tarantiniani b movies nel peggio o soltanto godibilmente rozzi, volutamente naïf), celebrate dal reale Tatti Sanguineti, nell’incipit, del suo vero consorte, Bruno Bonomo (il cognome è alquanto esplicativo ed è inutile aggiungervi altro). Col quale, però, sta divorziando malgrado vivano ancora, forse per poco, assieme e coi due figli piccoli in casa di lei. Durante una panchina del pargoletto calciatore in erba o da campo sterrato, no, durante una pacchiana, anacronistica, patetica e triste serata di gala in onore di Bonomo, presieduta dal debordante, forse troppo magnificante relatore succitato (Sanguineti, critico nella vita reale e qui critico di fantasia che si chiama Beppe Savonese), una giovane ragazza, di nome Teresa (Jasmine Trinca), gli lascia un copione. Importante? Forse incentrato su Berlusconi? Certamente… Bonomo se lo prefigura, forse inconsciamente, nei suoi incubi a occhi aperti, secondo le fattezze di Elio De Capitani ma, nella pellicola diretta dall’esordiente, per il lungometraggio Il caimano, già autrice di due shorts, Teresa, sarà incarnato dal filibustiere attore fallito Marco Pulici (Michele Placido), un adoratore sfegatato di Gian Maria Volonté. O forse no? Da Moretti stesso con manie di protagonismo e idolatrie verso un farisaico comunismo-solipsismo? L’Italietta, così definita da Jerzy Sturovsky (Jerzy Stuhr), pantomimica e messa su puttanescamente e burlescamente, potremmo dire, da Silvio Berlusconi, burattinaio pinocchiesco, sta andando a farsi fottere più d’una futura Ape Regina. Sabina Began? Sarebbe, costei, venuta con Silvio, sarebbe arrivata… dopo o finse orgasmi col “cavaliere” per occupare un posto di sedere o di potere? Anche il matrimonio di Bonomo sta colando a picco, sta andando a puttane mentre il “finto” capitano di polizia della Guardia di Finanza, alias Cesari (Valerio Mastandrea), si sputtanò e vendette più di una maîtresse da villa Arcore. Bonomo e Teresa ci mettono il cuore in un mondo ove un ex Presidente del Consiglio davvero si fece il culo per avere molti deretani sodi e glutei torniti, oppure corruppe e fu corrotto dalla mafia per pararselo del tutto? Coprendo le sue vergogne e le magagne dietro barzellette imbarazzanti? Il caimano è un film paraculo, un meta-cinematografico biopic, tutto sommato sterile, che dice tutto e dice niente e, con la scusante di fare cultura e informazione, con la furbata di smascherare il premier, diviene soltanto una mezza occasione sprecata e l’ennesimo film di Moretti costruito intorno alla sua ruffianeria nei riguardi innanzitutto di sé stesso, dunque dei suoi fan e nei confronti del suo simpatizzato, sbandierato schieramento politico da uomo che dice e fa la cosa giusta, più ipocritamente (anti)politically correct di Berlusconi stesso. Ha dei momenti lirici indubbiamente poetici, si segue volentieri e financo, a tratti, risulta divertente, galoppando frequentemente su alti registri sottili e delicati. Ma, nella sua completa amalgama, si squaglia, è inconsistente, ripeto innocuo e dimenticabile presto. Non rimane affatto impresso e, in fin dei conti, risulta per l’appunto più fake del lifting di Silvio. È Cinema “cerone”, che si presenta bello e di valore ma nasconde la gelida scheletricità, perfino schematicità, d’una superba falsità che fa più paura del cammeo di Paolo Virzì ed era già più vecchio di Giuliano Montaldo all’epoca. V’è anche Anna Bonaiuto avvocatessa fottuta fra un Matteo Garrone pre-notorietà cineastica, Antonio Catania, Cecilia Dazzi, Carlo Mazzacurati, Toni Bertorelli e chi più ne ha più ne metta.




di Stefano Falotico
THE FABELMANS, recensione
Ebbene, la questione Spielberg ritorna puntuale. A scadenze regolari? No, appena un suo nuovo film esce. Che poi è quasi la stessa cosa. Cosicché, si ripresenta, inquietante ma interessante, un instant classic, no, una classica domanda presso i cinefili e i cosiddetti addetti ai lavori, ovvero la seguente: Steven è veramente un genio, è quello d’un tempo o, addirittura, non è mai stato nessuno e perfino le sue opere più celebrate son invero, riviste e giudicate col senno di poi, delle simpatiche sciocchezzuole e delle pellicole, ai tempi della lor uscita, sopravvalutate in modo spropositato e ai confini della realtà, oltre ogni immaginazione più irreale? Esistono ed esisteranno sempre, anche quando avverrà, comunque sia tristemente, la dipartita di Spielberg, per l’appunto, gli spielberghiani inossidabili ed eterni, ridenti, non redenti, sì, irredimibili dei più irriducibili. Ovvero coloro legati all’idea, chissà se giusta o sbagliata, secondo cui il Cinema non ha e non deve avere una funzione maieutica, potremmo dire financo propedeutica e/o istruttiva, sebbene da Schindler’s List in poi, con le prove generali anteriori de Il colore viola, Spielberg stesso non è più il portavoce dell’aforisma: la settima arte deve far sognare.
Ciò dobbiamo, senza dubbio, subito puntualizzare. Aggiungendo inoltre una frase forse non propriamente simpatica ma apodittica e onestamente veritiera: Spielberg è rincoglionito. Così come, ahinoi, accade alla maggior parte della gente dalla settantina in poi. Tralasciando, ovviamente, i giovani vecchi che adorano Munich, considerandolo un capolavoro quando invero è un mattone tremendo, peraltro poco emozionante e dalla durata indigeribile. Come direbbe un boomer di Bologna… roba da spappolare i maroni.
Roba, dico invece io, solo per fanatiche di Daniel Craig prima maniera ed Eric Bana figo per finte fanatiche di Cristo come la ragazza fintamente educanda di tale The Fabelmans. Quasi unanimemente, The Fabelmans è stato reputato un gran bel film. Diciamo che ha dei momenti stupendi alternati a banalità sconcertanti e menate scopiazzate dallo stesso zemeckesiano Ritorno al futuro (ma guarda un po’) con l’immancabile totem della cultura WASP per eccellenza: il romanticissimo, angosciante, temuto eppur idealizzato, tremendo ballo della scuola. Brian De Palma, amico di Spielberg, a tal proposito, ci regalò la Spacek di Carrie, il pappa & ciccia di Steven, alias Francis Ford Coppola, Peggy Sue Got Married, John Travolta fu bullo nell’appena succitato, “sottotitolato” in italiano, lo sguardo di Satana, e poi il mitico tamarro Danny Zuko di Grease. Danny Zuko, personaggio per cui la prima scelta fu Henry Winkler/Fonzie/Arthur Fonzarelli di Happy Days. E ho detto tutto. In Italia, avemmo anche Antonello Venditti e Giorgio Faletti professore in Notte prima degli esami. Che c’entra? Attualmente, i collegiali, no, non solo i liceali italiani, stanno sostenendo il temibile Esame di Maturità. O hanno già finito? Mah. Fabrizio Bracconeri, Bruno Sacchi de I ragazzi della 3ª C, perse venti chili per lo stress degli orali e, dopo essere stato trattato alla pari d’una merda dagli insegnanti, soprattutto dal bastardino, partenopeo docente di italiano (incarnato da Antonio Allocca, cioè Tonino, ah ah) e dai suoi compagni di classe, finita l’interrogazione, trascorse un’intera settimana ad evacuarne sulla tazza del cesso il peso devastante. Pesante, parola odiata da Christopher Lloyd/Doc di Back to the Future. Parola invece amatissima da Michael J. Fox di Voglia di vincere, no, Marty McFly. The Fabelmans non è pesante come Amistad e non fa cagare ma non è nemmeno il capolavoro che molti pensano sia. Il personaggio di Seth Rogen è un viscido, per di più è comprensibile immediatamente che ha una relazione nascosta con quello di Michelle Williams, mentre il padre di “Spielberg” sapeva tutto? Jeannie Berlin/Haddash Fabelman aveva già capito… che, come si suol dire, brutta com’è, poteva giocoforza sol interpretare il ruolo dell’avvocatessa cazzuta, ma inculata, in The Night Of. Judd Hirsch non è giovane come Emile Hirsch ma forse, dopo il liceo, il suo personaggio voleva ribellarsi ai dettami scolastici e famigliari, per vivere à la Easy Rider, specialmente Into the Wild. Cosicché diede la caccia ai nazisti come in This Must Be the Place, aiutando il glaciale pagliaccio Cheyenne/Sean Penn a trovare il maiale, forse Ralph Fiennes di Schindler’s List giammai morto e divenuto una mummia come lo stesso Penn, però non del film di Paolo Sorrentino appena sopra scrittovi, bensì di Licorice Pizza. Ivi, capace di “sfoderarci” una performance più imbalsamata di Tutankhamun.
Spielberg girò Jurassic Park, tratto da un celeberrimo romanzo di Michael Crichton, mentre Yul Brinner fu il protagonista de Il mondo dei robot, scritto e diretto dal writer… che ve lo (ri)dico a fare?
Brinner non fu Tutankhamun in The Mummy, no, ne I dieci comandamenti di Cecil B. De Mille, bensì Ramesse, ma, a differenza del protagonista, all’epoca bambino di The Fabelmans, che vede Il più grande spettacolo del mondo con mamma e papà, quando per la prima volta assistetti alla visione di The Ten Commandments, programmata alla televisione, ancor prima della pubertà, compresi che mia nonna s’eccitava dinanzi a mr. Ben-Hur… Charlton Heston, mentre mio nonno tradì il comandamento Non desiderare la donna d’altri appena vide apparire, dinanzi ai suoi occhi, Anne Baxter/Nefertari. E, col pensiero, se la scopò. Io andai in bagno a fare la popò. Siamo sicuri… solo questa? C… zo, non è possibile. Avrò avuto solo 7 anni ma quella faraona me la sarei cucinata assieme ad altre patate al forno.

Io, i miei genitori e i miei nonni materni guardammo, tutti insieme appassionatamente, I dieci comandamenti dopo una luculliana cena a base di polli allo spiedo. Cioè tutte le persone che, non solo all’epoca, bensì a tutt’oggi, adorano i peplum. Io odio pure i “sandaloni” delle donne più belle, detesto le scarpe aperte con tanto di piedi femminili mostrati in bella vista e annessa puzza indigesta. Fra l’altro, rimanga fra noi, cari feticisti, Uma Thurman di Pulp Fiction & Kill Bill, le girls di Death Proof e Margaret Qualley di C’era una volta a… Hollywood hanno dei feet più disgustosi di Stuntman Mike/Kurt Russell.
Gabriel LaBelle è “Spielberg” in The Fabelmans. Ma non sarà mai un bell’uomo come Indiana Jones/Harrison Ford, non sarà mai un genio come John Ford e come Lynch che fa Ford. O forse sì. Che significato ha questa recensione? Forse nessuno. E che valore ha ancora il Cinema in un mondo che ha perduto la “purezza” dei nostri nonni? È possibile, oggigiorno, sognare ed essere romantici come Spielberg e, tutto sommato, rimanere fedeli a dei valori importanti come quel “Fantozzi” geniale di Paul Dano, in un mondo ove un trentenne medio non ha mai visto Sentieri selvaggi e L’uomo che uccise Liberty Valance? E che non vede un futuro davanti a sé ma solo i didietro di quelle su Instagram? Certo, poiché parafrasando Lynch/Ford: When the horizon’s at the bottom, it’s interesting. When the horizon’s at the top, it’s interesting. When the horizon’s in the middle, it’s boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office!

Se non capite questo, non potete capire questa recensione. Se non capi(s)te The Fabelmans non importa. È bello ma è sinceramente il film d’un director oramai senile, morto artisticamente parlando. Il quale, in tutta franchezza, non crede, or come ora, neppure alla magia di E.T. Spielberg è diventato, infatti, spiacevole doverlo ammettere, Dustin Hoffman di Hook – Capitan Uncino che vuole auto-convincersi di essere ancora capace di emozionarsi ed emozionarci come ai tempi de Lo squalo e d’Incontri ravvicinati del terzo tipo. Lo ringraz(iam)o per tutto ma sarebbe anche arrivato il momento di lasciare posto a un suo erede. Non posso essere io, mi chiamo Stefano e non Steven, non sono Stephen King e penso che, stasera, continuerò a recitare l’audiolibro a venire di questo: https://www.amazon.it/commissario-Fal%C3%B2-macabra-indagine-personale-ebook/dp/B0C948W5ZD
Ho quasi 44 anni, quindi non ho niente da perdere. Forse, neppure da guadagnarvi. Sì, e allora? La linea d’orizzonte può stare sotto o sopra, mai in mezzo. Ricordate.

di Stefano Falotico