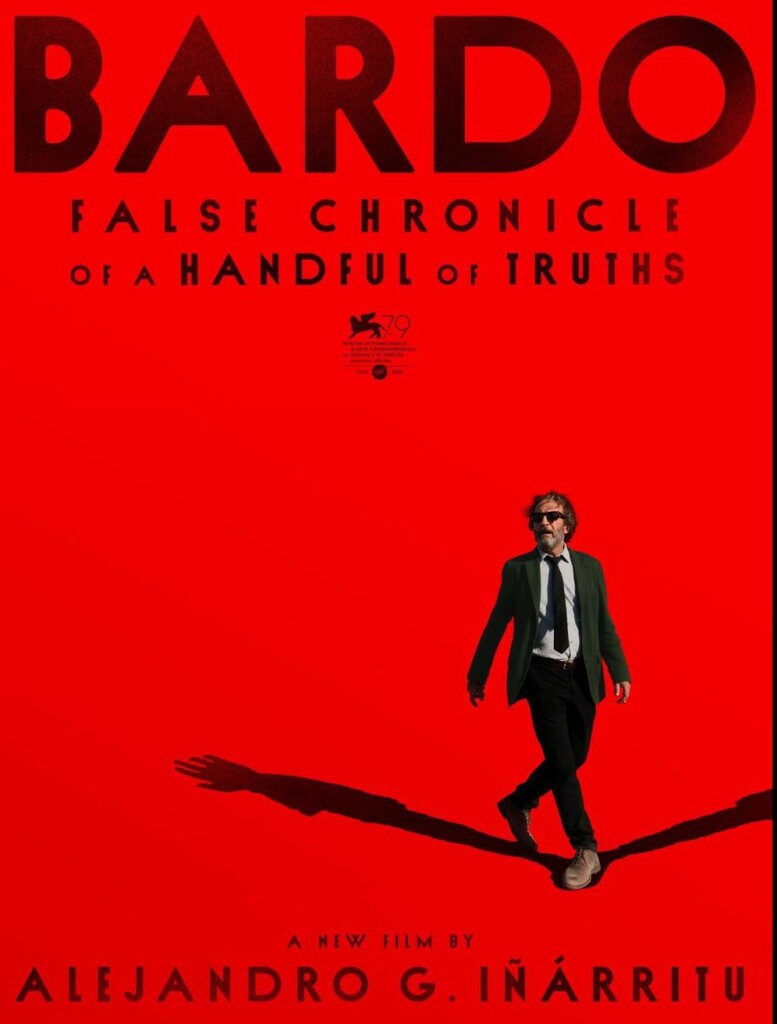WASH ME IN THE RIVER (Savage Salvation), recensione
Ebbene, oggi recensiamo il film Wash Me in the River, dal 28 dicembre scorso disponibile in streaming per gli abbonati ad Amazon Prime.

Wash Me in the River coincide perfettamente all’esatto titolo designato originariamente quando il film fu in lavorazione e, invece, per l’home video statunitense divenuto poi stranamente Savage Salvation. Wash Me in the River, non tradotto per la distribuzione italiana in quanto è un titolo, per l’appunto, “intraducibile” e metaforico che letteralmente significa sciacquami nel fiume. Lo potremmo delineare, diciamo, sinteticamente attraverso l’espressione battezzami in quanto, nella pellicola in questione, si narra, in forma d’azione puramente adrenalinica, emozionalmente dinamitarda e furibonda, una storia a suo modo cristologica, lacrimosa e al contempo rabbiosa, partita sulla base d’una patita, ingiusta dannazione e poi evoluta e deflagrata in esplosiva e spirituale, più che altro, vendicativa redenzione avvenuta in maniera di certo non mistica eppur catartica e perciò depurativa. Una vicenda torbida ove, una volta puniti i cattivi gravemente peccaminosi e ripristinato dunque il subito torto criminoso, mediante un’abluzione e un battistero, sì, con una nuova fonte battesimale sui generis, si giunge e ci si ricongiunge, figurativamente ed esistenzialmente parlando, alla salvazione e alla pace interiore. Ecco altresì spiegato il titolo originale per la versione d’oltreoceano, cioè per gli States.
Pellicola della netta e veloce, scorrevole durata di un’ora e quarantuno minuti corposi, Wash Me in the River rappresenta la seconda prova registica di Randall Emmett (Escape Plan) dopo il suo esordio dietro la macchina da presa del 2021, ovvero Midnight in the Switchgrass con Bruce Willis e Megan Fox.
Emmett, classe ‘71, stacanovista produttore infermabile dei più svariati film, per molto tempo assai prolifico nel finanziare e congegnare b movies e pellicole forse spettacolari, efficaci a livello di gustoso entertainment scoppiettante, non pretenziose eppur sicuramente non eccelse, datosi però ultimamente, parallelamente e finanziariamente, a progetti più importanti cinematograficamente e a più ampia portata qualitativa, quali, per esempio, Silence & The Irishman di Martin Scorsese.
Difatti, a proposito di The Irishman, ivi ritrova due degli interpreti di quest’ultima, celebrata pellicola scorsesiana, vale a dire Jack Huston e Robert De Niro. Se De Niro, in The Irishman, fu però l’assoluto protagonista e Huston incarnò solamente e per pochissimi minuti un ruolo decisamente secondario, in Wash Me in the River succede diametralmente l’opposto ma non ugualmente proporzionale a livello di minutaggio in scena. Qui De Niro, pur non essendo l’attore principale, interpreta una parte rilevante e primaria ai fini dell’intreccio raccontatoci.
Su sceneggiatura originale firmata da Adam Taylor Barker e Chris Siverston, eccone la trama, trascrittavi letteralmente dalla concisa sinossi espressa su IMDb: Un tossicodipendente da oppiacei in via di guarigione cerca vendetta sugli spacciatori responsabili della vendita della droga che ha provocato la morte della sua fidanzata.
Se la volessimo particolareggiare e fornirvene ulteriori dettagli senza commettere spoiler che ve ne sciuperebbero la visione, in Wash Me in the River, nei primi tre quarti d’ora, assistiamo alla romanticissima storia d’amore fra i due reietti Shelby John (Huston) e la diafana e candida Ruby (Willa Fitzgerald). I quali, con notevoli sforzi, essendo entrambi precipitati nel pericoloso e debilitante tunnel della droga, sono però decisi volenterosamente a sposarsi, sforzandosi coraggiosamente di superare la loro atavica tossicodipendenza malsana.
Accade però, fatalmente, una tragedia e Ruby muore di overdose. Il tutto, anzi, il lutto non è stato totalmente casuale? Al che, Shelby, accecato dalla rabbia, in forma giustizialista à la Rambo ante litteram, sfreccerà infermabile, sulla sua moto, per le strade desolate e malfamate dell’Ohio alla ricerca dei colpevoli in una sarabanda d’uccisioni e sparatorie senza esclusione di colpi, all’insegna della sua revenge “biblica” anche se certamente non epica ma ancor più autodistruttiva?
Nel frattempo, lo sceriffo Church (un De Niro non svogliato ma bravo con qualche guizzo grintoso, ciononostante, inevitabilmente stanco e appesantito), disilluso e affranto perennemente dal non essere stato in grado, a sua volta, di salvare in passato la vita del figlio, tenterà di far sì che Shelby possa placare la sua ira omicida prima che per quest’ultimo sia troppo tardi redimersi.
Chi è, peraltro, il sulfureo “prete” Peter (John Malkovich)?
Film che ha avuto vari cambiamenti di casting (prima della scelta definitiva di Jack Huston, infatti, erano stati opzionati Machine Gun Kelly e Taylor Kitsch, i quali rispettivamente diedero forfait) e una tribolazione organizzativa, essendosi svolte le brevi ma complicate riprese in pieno secondo lockdown dovuto alla pandemia), Wash Me in The River, parte come un sentimentale e smielato romance a tratti perfino commovente e ingenuamente sincero, trasformandosi quindi in un battagliero film d’azione fuori tempo massimo in senso tout–court. Infatti, per la sua rozza e tamarra eppur frenetica cifra stilistica marcatamente demodé e anacronistica da filmetto senz’infamia e senza lode, assomiglia tantissimo a un prodotto tipicamente usa e getta da anni novanta. In tale sua assoluta sincerità da guilty pleasure completamente incoerente e inesistente sul versante autoriale, consiste paradossalmente la sua potente mediocrità disarmante e stupenda.
Perciò, se preso come strepitosa assurdità romanticheggiante e inizialmente, ripetiamo, addirittura struggente e financo poetica, tramutata man mano in pellicola di bassa lega ingiustificatamente ed esageratamente reazionaria, potrà piacervi da matti, persino toccarvi il cuore per gran parte della sua durata.
La fotografia di Eric Koertz è scialba e inutilmente estetizzante nei momenti melanconici, le musiche di Philip Klein sono retoriche, sebbene gli altrui e numerosi pezzi country inanellati lungo il film risultino funzionali ed amalgamati alle immagini con buon ritmo emozionale, Jack Huston funziona più come futuro sposo tormentato ma al contempo molto innamorato, anziché come novello paladino della “polizia fai da te” che compirà una strage, De Niro, in un paio di scene, è convincente ma sprecato, Malkovich gigioneggia incontrollabilmente nel pre-finale, sfoderando una recitazione di maniera da mettere i brividi in senso, purtroppo, spregiativo e inguardabile.
Ci dispiace che De Niro e Malkovich ebbero, stavolta, la possibilità di recitare per la prima volta assieme ma qui non condividono, ahinoi, nessuna scena. Infine, per essere sbrigativi, Wash Me in the River è un film oggettivamente bruttino e insalvabile nel suo complesso, altro che Savage Salvation, ma talmente carino e immensamente triste nel suo incipit strappalacrime e infinitamente toccante, che griderebbe vendetta… sostanzialmente non promuoverlo sfrenatamente.
Nel cast, Dale Dickey e Swen Temmel.

di Stefano Falotico
GLASS ONION – KNIVES OUT, recensione
Ebbene, oggi recensiamo lo spassoso, esilarante e assai intelligente, perfettamente congegnato, anche se forse non del tutto riuscito, Glass Onion – Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mystery), scritto e diretto dal sempre più valente e sorprendente Rian Johnson (Looper, Star Wars – Gli ultimi Jedi).

Il quale, dopo il successo del capitolo originario, ovvero il capostipite e naturalmente antecedente Cena con delitto- Knives Out, ritorna, metaforicamente parlando, sulle tracce del suo inventato e ben fantasiosamente partorito investigatore privato, à la Hercule Poirot a sua volta figlio della penna dell’imbattibile Agatha Christie, Benoit Blanc (uno smagliante Daniel Craig già candidato come miglior attore protagonista nella categoria Comedy/Musical agli imminenti Golden Globes), assoldando per tale suo “sequel” sui generis, un parterre de rois delle cosiddette grandi occasioni, cioè un cast variegato e strabiliante in cui svetta, primeggiante, la new entry del sempre da noi gradito Edward Norton (Motherless Brooklyn) e un’inedita, mai così sensuale e caliente, peperina Kate Hudson al massimo della sua insospettata carica piccante, travolgente e magnetica. Con Glass Onion – Knives Out, Johnson, da buongustaio oramai affinatosi dell’arte non culinaria, bensì appartenente alla celluloide più succosa, allestisce una succulenta e, ripetiamo, sia divertente che sagace, saporita pietanza cinematografica squisita e veramente da leccarsi i baffi, servendoci caldamente un piatto appagante il nostro palato cinefilo, offrendo a noi, commensali del Cinema non insipido, un arguto giallo mordace, avvincente e scoppiettante, ripieno di colpi di scena gustosi e spiazzanti, sebbene eccessivi, così come spiegheremo più avanti, finemente intriso di tocchi e “gourmet” da chef registico di prima classe e da dieci e lode insindacabile. Forse sì forse no?
Trama, morbidamente diluitaci come un delicato soufflé che, anziché afflosciarsi, col trascorrere dei minuti emozionanti e pregni di suspense brillante, equivalenti per l’esattezza a due ore e venti minuti netti (tale infatti è la complessiva, scorrevolissima durata di Glass Onion), carbura fervidamente e bellamente riscalda, in crescendo spasmodico e vertiginoso, la nostra curiosità via via più affamata e poi appagata… anche se non del tutto.

La vicenda è ambientata nel 2020, ovvero al massimo zenit, sì, al culmine della mondiale pandemia del Covid-19. Al che, il nababbo Miles Bron (Norton), a capo della proficua e altamente remunerativa Alpha Industries, in quel di Glass Onion, cioè un pittoresco ed esotico isolotto del mar Egeo, invita, presso la sua lussuosa e labirintica magione, una nutrita ed eterogenea, ottimamente assortita combriccola composta dai suoi migliori amici di lunga data, ognuno dei quali, adesso, svolge rispettivamente lavori finanziariamente cospicui ma fra loro diversi. Singolarmente, non staremo a enumerarveli e a specificarli perché non ce ne pare la sede opportuna. Bron serve loro un’inattesa sorpresa maliarda e appetitosa, cioè ha coordinato una sfarzosa, al contempo sottilmente maliziosa, chissà se giocosa, cena con delitto sfiziosa… Anche meravigliosa?
Al che, all’improvviso, senz’invito, fa la sua entrata in scena il detective Blanc (Craig) che vuole vedervi chiaro e andar oltre le apparenze di quello che, a prima vista, potrebbe sembrare un innocente diletto-delitto orchestrato, giustappunto, dall’incolpevole e goliardico Bron. Perché Blanc è giunto sul luogo? Trattasi di pura coincidenza imponderabile, di fatuità casuale e innocua oppure un membro della compagnia, ad insaputa di Bron, per tendergli a sua volta, da burlone e buontempone, un tranello bernesco e uno sberleffo cattivello, desiderava rovinargli il piano furbesco?
Indovina indovinello, come andrà a finire in questo duello fra Blanc & Bron, chi la spunterà in tale Cluedo cinematograficamente forse non tanto farsesco così come invece, inizialmente, apparve candidamente?
Acclamato dalla Critica, tanto d’aver già totalizzato la superba media dell’81% di pareri estremamente positivi presso il sito aggregatore metacritic.com, in effetti Glass Onion vale ampiamente le lodi ricevute e il prezzo della visione, al cinema tramite Lucky Red o in streaming su Netflix?
In quanto è davvero un film godibile e da mandar giù in un sol boccone, sapientemente magistrale nella messa in scena, ripetiamo, ricolma e pienamente infarcita di trovate geniali e prelibate? Oppure qua e là pecca di troppa carne al fuoco? Deflagrando in un minestrone insapore?
Attori perfetti, malgrado talvolta vadano a briglia sciolta sopra le righe, un Craig impeccabile ma non appieno carismatico e un Norton, dietro il cui personaggio aleggia sapidamente, in forma parodica, la “maschera” sbertucciata di Elon Musk, una Hudson/Birdie Jay da urlo a cui però l’ancora più erotica e assai discinta, disinibita Madelyn Cline/Whiksey ruba la scena, Jessica Henwick/Peg, Janelle Monáe/Cassandra Andi Brand, Jackie Hoffman, Noah Segan, Leslie Odom Jr./Lionel Toussaint, Kathryn Hahn/Claire Debella, un Dave Bautista/Duke Cody, sotto ogni punto di vista, in grande spolvero. Con l’aggiunta di cammei, invero un po’ inutili, di Ethan Hawke (irriconoscibile con gli occhiali da sole), Hugh Grant, della compianta Angela Lansbury, la campionessa Serena Williams, Natasha Lyonne e Kareem Abdul-Jabbar.
Glass Onion scorre che è una delizia e, dopo un incipit probabilmente inverosimile, compresi alcuni assunti logisticamente improponibili, se decidiamo di salirvi metaforicamente a bordo, possiamo goderne il viaggio e gli ingredienti del piatto servitoci… Su tale versante, in modo egregio, funziona al netto delle sue evidenti difettosità che, sottostante, evidenzieremo. Infatti…
Glass Onion esagera nei colpi, diciamo, di (s)cena, affastellando con sfrenatezza mal dosata un finale dopo l’altro in una sarabanda ridondante, giustappunto, per dirla come gli americani, di turning points, a lungo andare, stomachevoli e indigesti per lo spettatore smaliziato e sensibile che, almeno sino a mezz’ora dalla definitiva fine, era già sazio e non può quindi obiettivamente gradire tale sovrabbondanza di “portate” propinateci a dismisura infinita.
Glass Onion, inoltre, vorrebbe essere un Dieci piccoli indiani contemporaneo, anzi, postmoderno ma si dimostra, in molti punti, artefatto e, rimarchiamolo, ripetitivo.
Infine, funziona scialbamente come metafora anticapitalistica, invero retorica e scontata, sui nuovi e antipatici ricchi rampanti, chiamati qui disgregatori, figli non tanto dell’edonismo post-reaganiano ma più vicini all’era Trump. Proponendoci una soluzione dell’enigma indagatorio, sì, soddisfacente, altresì una fasulla morale buonista e consolatoria sul jeu de massacre dei cinici arrivisti e falsissimi amici che, onestamente, alle soglie del 2023 è aria fritta, roba trita e ritrita, ipocrita e già mal digerita.
Abbiamo citato gli attori coi rispettivi personaggi da loro incarnati ma, nel mosaico, manca un pezzo, ovvero un nome. Quello di Helen.
Guardate Glass Onion e saprete chi è, eh eh.
di Stefano Falotico
CHINATOWN, recensione
Ebbene oggi, per il nostro appuntamento, ci auguriamo gradito, coi consueti Racconti di Cinema, disamineremo Chinatown, film magnifico del ‘74, firmato da un ispirato, così come soventemente accade, Roman Polański (La nona porta, L’uomo nell’ombra).
Candidato a undici premi Oscar, fra cui Miglior Film e Regia, Chinatown ne vinse soltanto uno, andato alla migliore sceneggiatura originale, scritta da Robert Towne (Frantic, Mission: Impossible).
Opus della durata corposa e consistente, giammai noiosa, bensì avvincente e inquietante di due ore e dieci minuti netti, Chinatown è un mystery thriller d’alta scuola sofisticata e, al contempo, un pregiato noir d’annata che profuma, leggiadramente, di beltà sconfinata e cinematografico sapore vintage veramente speciale. È, quindi, un imprescindibile classico della Settima Arte non solamente appartenente ai gloriosi anni settanta hollywoodiani. Peraltro, rappresenta a tutt’oggi l’ultimo film in assoluto diretto da Roman Polański in terra statunitense prima del suo “esilio” e confino in Europa per le ragioni che noi tutti sappiamo…
Senza perderci in superflui panegirici e descrizioni della trama inutilmente particolareggiate, estraendo testualmente la sinossi di Chinatown da IMDb e ivi letteralmente trascrivendola esattamente, eccone, nelle righe immediatamente seguenti, la perfetta e assai concisa sintesi saliente che non si perde, giustappunto, in chiacchiere inutili…
Un detective privato assunto per raccogliere prove di un adulterio si trova coinvolto in una spirale di violenza, corruzione e morte.

Il detective si chiama Jake Gittes (Jack Nicholson), detto J.J. S’inoltra, se non controvoglia, perlomeno giocoforza in un’imprevista spirale viziosa di torbidi inganni e scabrose macchinazioni che forse hanno del raccapricciante, giungendo a verità all’apparenza insospettabili e moralmente disarmanti, precipitando infernalmente e in modo tetramente sesquipedale in un girone dantesco e agghiacciante a base di fetide, spregevoli, meschine e losche bugiardaggini tremende e mortificanti, tristissimamente amare.
Secondo la pertinente, breve analisi riportatavi sottostante dal dizionario Morandini:
È un film profondamente chandleriano senza Chandler, dunque foscamente romantico. Chandleriano è anche l’umorismo che ne sorregge il pathos nella descrizione di un mondo corrotto non solo politicamente in cui la presenza del male – incarnato dal vegliardo capitalista J. Huston – è ossessiva e sinuosa, mostruosamente ambigua. Pur senza abbandonarsi a esercizi di nostalgica archeologia, fece scuola nel campo della rivisitazione del cinema nero.
Sotto ogni aspetto, inappuntabile e assai curato nei più minimi dettagli, Chinatown, a distanza di circa cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, avvenuta, come sopra dettovi, a metà dei seventies, rimane un capolavoro perlaceo davvero impari. Fotografato con maestria imbattibile dal veterano John A. Alonzo (Scarface), musicato maestosamente da Jerry Goldsmith, prodotto dal mitico Robert Evans, Chinatown è un’indiscussa pietra miliare del Cinema mondiale.
Ovviamente, le interpretazioni dei tre attori protagonisti, vale a dire Nicholson (Qualcosa è cambiato), Faye Dunaway (Barfly) e John Huston, sono superbe e mirabili, già da sole varrebbero il “prezzo” della visione impagabile.
Cammeo di classe dello stesso Polański e grande cast variegato in cui, oltre ai tre suddetti titani, si fan ben notare le presenze di Burt Young (Rocky, C’era una volta in America), Perry Lopez, John Hillerman e soprattutto di Diane Ladd (Cuore selvaggio).

di Stefano Falotico
L’UOMO NELL’OMBRA, recensione
Ebbene oggi, per il nostro appuntamento coi Racconti di Cinema, salteremo indietro nel tempo ma non ci spingeremo molto lontano, approdando più precisamente al recente 2010, anno dell’uscita nelle sale del film, nelle righe seguenti, da noi disaminato e preso in questione, ovvero L’uomo nell’ombra, il cui titolo originale è il ben più appropriato ed emblematico The Ghost Writer.

Firmato dall’emerito Roman Polański (La nona porta, Carnage), vincitore del premio Orso d’oro come miglior regista al Festival di Berlino dell’anno succitato ove L’uomo nell’ombra fu in kermesse e in concorso, adattato dallo stesso Polański assieme a Robert Harris (da non confondere con Thomas Harris, scrittore invece de Il silenzio degli innocenti), autore dell’originario romanzo omonimo (da noi divenuto Il ghostwriter), il film consta della durata di due ore e 8’ e nacque per strambe e fortuite coincidenze avvenute fra il director di Rosemary’s Baby e lo stesso Harris.
Dapprincipio, infatti, Polański opzionò un precedente opus letterario di Harris, ovvero Pompei, seriamente intenzionato a trasporlo cinematograficamente. Doveva trattarsi di un kolossal dal budget assai cospicuo ma a causa d’imponderabili, contravvenuti contrattempi, all’ultimo momento il progetto saltò, così che Polański “ripiegò”, giustappunto, su tale adattamento, contrattando piacevolmente il tutto con Harris che, di buon grado, accettò di lavorarvi in sede di sceneggiatura, apportandone il suo notevole e personale contributo importante.
Trama:


Un giovane e ambizioso ghostwriter piacente, carismatico e di belle speranze (un eccellente Ewan McGregor in stato di grazia recitativa), dopo un’accurata selezione, viene assunto da una rinomata equipe editoriale, londinese come lui e diretta da Sidney Kroll (Timothy Hutton, Secret Window), per redigere, anzi, per meglio dire, al fine di rivedere, ricongegnare e correggere un manoscritto concernente l’autobiografia del Primo Ministro della Gran Bretagna attualmente in carica di nome Adam Lang (un ambiguo e forse luciferino Pierce Brosnan).
S’invola quindi alla volta dell’incontaminata e poco abitata, perennemente flagellata da un clima atmosferico piovigginoso e freddo, plumbea e sepolcrale, realmente esistente eppur quasi sperduta isola Martha’s Vineyard, al largo della costa del Massachusetts. Ivi, risiede l’avveniristica, accessoriata e tecnologica, al contempo spettrale e misteriosa magione di proprietà dell’editore del futuro biopic riguardante Lang.
Questa villa lussuosa, d’aspetto avveniristico, labirintica e arredata in modo avanguardistico, ripiena di corridoi lugubri e adornata da quadri impressionisti, è or abitata dai collaboratori di Lang, a capo dell’avvenente ed elegante segretaria tuttofare Amelia Bly (Kim Cattrall), sovente bazzicata dallo stesso Lang che se ne reca per incontrare e aggiornare il suo uomo “ombra” e per rivedere la sua conturbante, misteriosa e altezzosa, nevrotica consorte Ruth (Olivia Williams nella più intensa e perturbante, maliziosa performance della sua sottovalutata carriera invero mirabile).
Lang è stato accusato di crimini di guerra, in quanto imputato d’aver permesso efferate torture a dei possibili terroristi per mano della CIA. A cui, forse, è nascostamente e viscidamente ammanicato? Prima dell’assunzione del suo scrittore fantasma, un altro ghostwriter, morto in circostanze sospette, forse assassinato in maniera complottistica, era stato incaricato di allestire il biopic inerente la vita, professionale e non, di Lang.
Inoltre, chi si cela dietro l’equivoca, apparentemente integerrima ed esimia, identità del ricco professore, insospettabile Paul Emmett (Tom Wilkinson)?

Teso, compatto, viscerale, palpitante, girato magistralmente e con sapido, infallibile gusto torbido e fascinosamente malsano per le atmosfere pregne di suspense ad altissimo tasso inquietante, dallo specialista del thrilling per eccellenza, ça va sans dire, il nostro amatissimo Roman, sorretto da un torreggiante e magnetico McGregor, splendidamente fotografato da un ispirato Pawel Edelman (Ray, L’ufficiale e la spia), sontuosamente musicato da un altrettanto perfetto Alexandre Desplat (Il discorso del re, La forma dell’acqua), L’uomo nell’ombra, malgrado qualche inevitabile e comprensibile, microscopico buco narrativo e talune incongruenze forse carenti in quanto a verosimiglianza, è un’opera di rara pregevolezza e di sofisticata scuola cineastica davvero formidabile e mozzafiato.
Impaurisce, fa rabbrividire, emoziona, è incalzante, coinvolge con finezza e appassiona vigorosamente dall’inizio alla fine.
Nel cast, piccole parti per un giovanissimo Jon Bernthal (The Punisher) per Jim Belushi e una fulminea, strepitosa apparizione dell’indimenticabile Eli Wallach (La notte e la città, Il buono, il brutto, il cattivo).
L’uomo nell’ombra, probabilmente, non è un capolavoro e, qua e là, pecca di veniale manierismo. Ma, a distanza di oltre dieci anni dal suo debutto, rimane un grande film memorabile.



di Stefano Falotico
PINOCCHIO, recensione bugiarda?

Guillermo del Toro’s Pinocchio – (Clocklwise) Spazzatura (voiced by Cate Blanchett), Gepetto (voiced by David Bradley), and Pinocchio (voiced by Gregory Mann). Cr: Netflix © 2022
Ebbene, questa non sarà una review convenzionale e allineata a didattici, pseudo-formativi e istruttivi canoni stilistici adatti a un mood editoriale da stampa giornalistica che spesso si (s)vende al peggior fetente, no, al miglior offerente affinché, in modo bieco e losco, gli uomini “rusco” ne possano ricavare un vantaggio promozionale di opportunistico endorsement fariseo da “manini”, alias imbrogli & sotterfugi dei prezzolati più marchettari e comprabili. Questo Pinocchio di Benito Mussolini, no, Benicio Del Toro, no, Guillermo(ne) del Toro, acclamato quasi unanimemente dai nerd, cioè dai cosiddetti ominidi-ominicchi della giungla alla Mowgli, no, nerd sinonimo di Mogwai, vale a dire i futuri Gremlins che, dopo una vita di patiti bullismi e delusioni a non finire, hanno “rintracciato”, no, trovato in del Toro il guru spirituale (stessa cosa dicasi per i fan di di Hayao Miyazaki, dei fumetti anche à la Dylan Dog e non di Anna Falchi di Dellamorte Dellamore) delle loro tragiche sconfitte esistenziali in quanto Guillermo compiace bellamente e furbescamente il loro falsissimo “comunismo” da sfigati mai visti e frustrati ribelli fake che si spacciano (per) compagni ma, al massimo, frequentano solo uno schermo impolverato del PC, dicevo… non perdiamoci in teatrini da burattini e da piccolini… Costoro, ignobili impostori e cialtroni-ciarlatani dei più esecrandi, sono gli stessi che venerano, osannano, oserei dire idolatrano Tim Burton e davvero pensano che Nightmare Before Christmas sia stato diretto da tale regista in carne e ossa che, invero, soltanto s’avvalse dell’animazione creata da altri e poi “appioppata” a lui in maniera scarsamente meritocratica. Ora, dobbiamo essere obiettivi, realisti, veritieri e giudicare oggettivamente questa favola deltoriana che è retorica come non mai, intrisa di dolciastra melassa da schienare e affliggere anche il più accanito “aficionado” degli esami del sangue perennemente sballati a causa del continuo e incurabile, altissimo tasso di trigliceridi, lipidi e colesterolo a mille.
Leggo post e recensioni che acclamano a spada tratta questo Pinocchio in maniera (inde)fessa, leggo di gente che si è strappata i capelli, sperticandolo di lodi entusiastiche come se avesse visto la Madonna genuflessasi, in segno di sottomissione giudeo-cristiana, dinanzi al Maligno per una scioccante rilettura biblica ed evangelica da pelle d’oca. Roba da scomunica immediata e da matti di Castiglione delle Stiviere.
Una roba più ipocrita del più grande bordello del mondo che è a due passi dal Vaticano…
Ivi, del Toro, snaturando completamente e senza vergogna il testo originario di Carlo Collodi, con totale, impavido e incosciente, oserei dire imberbe storicismo, no, stoicismo degno di Jay Baruchel di Million Dollar Baby, riesce giustappunto a stupefare un pubblico di suoi fedelissimi adepti irriducibili, anzi, per meglio dire, a coglionare i suoi followers più ottusi senz’alcuna contezza di sé stessi e della parola Cinema. Totalizzando una media recensoria immane presso i maggiori siti aggregatori oramai in mano a ragazzini più rimbambiti di Geppetto. E aggiudicandosi già svariate, immeritate nominations ai Golden Globes e via dicendo. Per il 25 dicembre o adesso, cari miopi e ciechi da Santa Lucia, cari Lucignolo dei poveri da Paese dei Balocchi, miei boys non adatti a ciucciare le bocce di Sabrina Salerno, bensì col ciuccio in bocca e molto ciuchini, regalatevi anche Avatar: The Way of Water e, mi raccomando, terminate il terzetto da Giochi Preziosi, guardando e sconfinatamente ammirando, tanto per “castrare” la vostra crescita stagnante imperterritamente in zona prenatale, perfino, per filo e per segno, la nuova “fiera delle illusioni” di Steven Spielberg col suo penoso e puerile The Fabelmans. Ci sarà, d’altronde, un motivo se Spielberg definì questo Pinocchio pura poesia. Nevvero? D’altro canto, questi qua, dei baccalà, sono gli stessi che, per anni, glorificarono l’hobbit Peter Jackson e veramente pensarono che Cate Blanchett (doppiatrice qui di Spazzatura) fosse la Fata Turchina, no, solamente l’asessuata e angelicata Galadriel de Il signore degli anelli. Accorgendosi tardivamente che la sua Katharine Hepburn di The Aviator era già più figa di quella realmente esistita e prendendo quindi, con molto ritardo, le cosce, no, coscienza che la sua Lilith Ritter di Nightmare Alley, per l’appunto, fu talmente gnocca da far sì che Bradley Cooper dimenticasse Toni Collette. Quest’ultima, in tale film appena eccitante, no, succitato, mai così sexy e caliente.
Cate Blanchett, con ogni probabilità, vincerà il suo secondo Oscar per la sua magnifica performance in Tár. Film nel quale indossa solo tailleur da Tilda Swinton/Orlando e, pur spogliandosi solo ripresa da lontano e per pochissimi secondi, è più arrapante della donna misteriosa di Eyes Wide Shut per cui prestò la voce. Eyes Wide Shut con Todd Field, regista di Tár. E ho detto tutto… Fidelio…
Chiarito ciò, molti nerd, i quali già son impazziti per questo Pinocchio, utilizzano Hellboy/Ron Perlman (doppiatore del Podestà) come avatar nei loro profili social ma, dal vivo, sinceramente son lontani anni luce dal risultare belli come Ewan McGregor (doppiatore di Sebastian il Grillo). Poveretti, sono in piena zona Trainspotting… avranno rimpianti da Big Fish?
Trama, copia-incollata da Wikipedia: Geppetto, un vedovo falegname che vive nella grigia Italia fascista, ancora soffre per la perdita del figlio Carlo a seguito di un bombardamento durante la Grande Guerra. Una sera, ubriaco, abbatte un albero vicino alla tomba del figlio e da quel legno, costruisce (ancora sbronzo) una marionetta dagli imperfetti lineamenti e il lungo naso, che chiama Pinocchio. Una fata, accorgendosi che l’anima di Carlo si è reincarnata nell’albero, dona vita alla marionetta e istruisce il grillo che viveva al suo interno, Sebastian, di fare da guida a Pinocchio. Geppetto è sorpreso di ritrovarsi un nuovo figlio a carico, ma Pinocchio nota nel creatore una certa malinconia nello stare rimpiazzando Carlo, così parte in giro per il mondo per imparare ad essere un figlio migliore per il suo genitore.[1]
Guillermo fa storcere il naso ai puristi? Può essere. Elmina Il Gatto & La Volpe, addirittura Mangiaf(u)oco, rimpiazzandoli in un unico stronzone, ovvero col/il colonnello Hans Landa di Bastardi senza gloria, no, col Conte Volpe/Christoph Waltz. Povero Waltz, passato dal villain nazista par excellence a bozzetto della Morte in Rifkin’s Festival e ora ridottosi a fare la macchietta e la marionetta live action(izzata), qui usata a mo’ di figurina più caricaturale del Duce/Dolce. Guillermo trasforma Pinocchio in un manifesto politico fuori luogo a scopo capziosamente pedagogico pagato da Netflix, pensando di criticare, così facendo banalmente, ogni forma di nazi-fascismo e generando, partorendo, in maniera più volpesca di The Fox, un Bignami da liceo magistrale contro ogni war sporca e sciovinista. Che solipsista! Al che, dovrebbe, a questo punto, venire davvero in Italia e iscriversi all’università Mercatorum. Per comprendere che, dopo il diploma ottenuto col CEPU, le future psicologhe e, chissà, prossime Giorgia Meloni, sono ex tamarre cresciute a pane, pene, urla da stadio, “imboccate”, fra un bovaro, un troglodita e un amante delle zoticone, da un educatore che lavora come assistente sociale al C.S.M. È lo stesso, semmai, sposato a una frigida femminista più racchia di Rosy Bindi e di certo non attraente come la rossa Adrienne Corri di Arancia meccanica. Ah, la domanda spontanea che mi sono sempre posto davanti a ogni versione di Pinocchio è la seguente: Geppetto, il quale è notevolmente âgée, ebbe un figlio morto, sostituito poi da quello di legno, che fu adottivo oppure fu ottenuto con l’inseminazione in vitro di un figo come Hugh Grant di About a Boy, quest’ultimo in vacanza “premio”, fra una Liz Hurley e una Divine Brown, alla pari dei “carabinieri” con pettinatura fascista e “gendarmi” meridionali adoratori di The Wall dei Pink Floyd, dediti d’estate, però al turismo sessuale in Thailandia o in Scandinavia? Cosa ne sa del Toro delle chiese… italiane, ha mai visto il Duomo di Prato frequentato dalla mia compianta Nonna Margherita, emigrata al Nord e sposata a un vero Carlo, salvatosi dal fascismo, combattendo la Seconda Guerra Mondiale e svolgendo lo stesso lavoro di Sean Connery in The Untouchables al fine di permettere a mia madre e a mia zia di frequentare la rinascimentale Firenze? Firenze, patria dello Stivalone, no, dello Stilnovo, la Toscana, la regione di Dante Alighieri, Livorno, la città di Modigliani, Firenze, ove lavorò Petrarca, no, lo psichiatra Petracca della scuola di Cassano.
Capolavoro? Ora, non scherziamo, non intendo recitare la parte del moralista, dunque del Grillo Parlante.
Dobbiamo essere fintamente neorealisti come del Toro che non conosce, forse, Roberto Rossellini e volete raccontarvi bugie per non ammettere che siete Leslie Nielsen de L’aereo più pazzo del mondo?
di Stefano Falotico
IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, recensione
Ebbene oggi, per il nostro immancabile e consueto, ci auguriamo apprezzato, appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo lo splendido e perlaceo Il texano dagli occhi di ghiaccio, il cui titolo originale è l’assai più emblematico e meno generico The Outlaw Josey Wales, mirabile opus del ‘76 firmato dal grande Clint Eastwood (Lo straniero senza nome, Gli spietati), qui anche protagonista assoluto di tale capolavoro western dalle sottili venature crepuscolari, pregno di roboanti e furenti atmosfere spettralmente glaciali e ferocemente potenti.

Accolto favorevolmente dalla Critica ai tempi della sua uscita nelle sale, avvenuta oramai poco meno di cinquant’anni or sono, Il texano dagli occhi di ghiaccio totalizza, a tutt’oggi, su metacritic.com, ovvero l’internazionale sito aggregatore di medie recensorie più famoso al mondo, una lusinghiera percentuale del 69% di opinioni positive, ed è un film della consistente e avvincente durata notevole di due ore e quindici minuti netti e ipnotici, sceneggiato da Sonia Chernus & Philip Kaufman che, dal libro omonimo ad opera di Forrest Carter, poi divenuto Gone in Texas, trassero l’adattamento cinematografico con finezza sofisticata d’alta scuola, in fase di scrittura, accorta e precisa. Limando alcune parti presenti nel romanzo originario e concedendosi molte licenze poetiche assai affascinanti al fine di personalizzarlo, anzi, per meglio dire, affinché potesse naturalmente essere subito inquadrato e accordato a un’ottica consona allo sguardo eastwoodiano, all’epoca già consolidato e ascritto, a sua volta, all’interno d’un cineastico percorso molto coerente e puntuale. Eastwood, da par suo, v’aggiunse i suoi riconoscibilissimi tocchi raffinati, permeandolo e intarsiandolo, diciamo, cucendolo perfettamente a misura della sua cifra stilistica e della sua statura registica che già qui, ribadiamo, era rappresentativa dei suoi accertati e ben saldi stilemi unici e profondamente peculiari. Anche se, a onore del vero e per dovere di cronaca, inizialmente il film doveva essere diretto dal succitato Kaufman. Anzi, volutamente ci correggiamo ancora. Le riprese iniziarono sotto la direzione di Kaufman (La banda di Jesse James, Sol levante) ma, a causa dei continui diverbi e delle cosiddette irrisolvibili e non conciliabili differenze di vedute fra Eastwood e Kaufman, alla fine, col beneplacito della Warner Bros., Eastwood ne prese il comando.

Trama: Siamo in piena guerra di Secessione. Josey Wales (Eastwood) è un roccioso uomo che vive nel Missouri e fa l’agricoltore nel suo ranch. Vive con moglie e prole, cioè suo figlio. Pur essendo riuscito a non andare in battaglia, viene avvinghiato dentro una pericolosa spirale forse mortale… Per lui o per gli altri, cioè i nemici e gli efferati uccisori dei suoi affetti più cari? Sì, perché la sua famiglia, nell’incipit, prima dei titoli di testa, venne barbaramente massacrata, cosicché Josey si vendicherà, divenendo amico, lungo il suo tortuoso viaggio, perfino di redenzione e in cerca della sua pace interiore, d’un indiano Cherokee (Chief Dan George). E non vi diciamo altro per non sciuparvi le sorprese e i colpi di scena micidiali di cui è ricolmo Il texano dagli occhi di ghiaccio. Sottolineando però quanto segue…
Fotografato splendidamente da un ex habitué del Cinema di Eastwood, il compianto Bruce Surtees, prodotto dallo stesso Eastwood tramite la sua Malpaso, su inappuntabili scenografie d’impatto dell’accoppiata Tambi Larsen e Charles Pierce, su belle musiche di Jerry Fielding, Il texano dagli occhi di ghiaccio è un’opera, oltre che storicamente inappuntabile, cresciuta col tempo vertiginosamente, così come accaduto per molti film di Eastwood e continua a stupirci e a magnetizzarci per via, innanzitutto, dell’enorme potere carismatico di Eastwood interprete che, in tale occasione, sfodera un ghigno truce da pelle d’oca e buca lo schermo in ogni inquadratura in virtù del suo fascino virile impressionante, destreggiandosi inoltre in una regia secca e senza fronzoli, bilanciata ottimamente e oscillante chirurgicamente fra momenti di robusto pathos emotivo e attimi melanconici di straordinaria poesia cristallina. Un film formalmente nitido e di gran vigore.

Il texano dagli occhi di ghiaccio riesce a essere sia struggente che avvincente e a profumare fulgidamente, dal primo all’ultimo minuto, di purissimo western come se ne facevano un tempo e, parimenti al vino pregiato e d’annata, più stagiona e meno invecchia, migliorando a ogni visione e col passare degli anni, stagliandosi e stampandosi maggiormente nella memoria in modo ipnotico. Insomma, un capolavoro.
Nel ricco ed eterogeneo cast, Bill McKinney, John Vernon, Sam Bottoms (L’ultimo spettacolo), Joyce Jameson, Will Sampson, Woodrow Pafrey e una giovanissima e bellissima Sondra Locke. Eastwood e la Locke si conobbero su questo set, fra loro immediatamente scattò la scintilla amorosa e, come sappiamo, per molti anni furono compagni sia nella vita professionale che, soprattutto, in quella reale e giustappunto sentimentale.
Particolarità che forse sfuggirà ai più: come detto, Josey Wales è del Missouri, quindi il titolo italiano è assolutamente fuori luogo, è il caso di dirlo, sebbene Wales si rechi in Texas nel corso del film. Forse è questa la meta della risoluzione dei conti finale?
di Stefano Falotico
LO STRANIERO SENZA NOME, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo Lo straniero senza nome (High Plains Drifter), diretto e interpretato nientepopodimeno che da Clint Eastwood.
Opus n.2 all’interno del mirabolante e versatile excursus cineastico di Eastwood in versione director, pellicola assai sottovalutata all’epoca, cioè ai tempi della sua uscita, avvenuta nel ‘73, Lo straniero senza nome, della durata netta di centosette minuti corposi e sanguigni, è invero un film capitale e decisamente importante, oltre che qualitativamente rilevante e, se volessimo utilizzare una tipica espressione del gergo critico, “seminale”, prestandosi fra l’altro a notevoli chiavi di lettura delle più disparate e affascinanti.
Attualmente, riscontra un lusinghiero e più che soddisfacente 69% di opinioni positive sul sito aggregatore di medie recensorie denominato metacritic.com. A testimonianza giusta del suo valore, aggiungiamo noi. Ma, come poc’anzi accennatovi, Lo straniero senza nome si rivelò un mezzo flop al botteghino e scontentò gran parte dell’intellighenzia, forse non pronta ad accogliere favorevolmente tale inaspettato western glaciale e atipico, perciò non poco lo equivocò, prendendo una terribile cantonata.
Sceneggiato da Ernest Tidyman & Dean Riesner, eccone succintamente la trama:
Un pistolero, chiamato The Stranger, giunge a cavallo nella cittadina di Lago e, in virtù, potremmo dire, del suo fascino carismatico, forse d’ancestrale matrice divinatoria, dopo la sua prodigiosa e repentina, sensazionale uccisione di alcuni sgherri, assurge a paladino del luogo, assumendosi l’onere, il compito e al contempo il privilegio, dallo sceriffo e dai suoi abitanti assegnatogli con onore, di consegnare alla giustizia tre pericolosi manigoldi e spietati fuorilegge.
Probabilmente, malgrado alcune sorprese, riuscirà nell’impresa e poi, parimenti alla sua entrata in scena misteriosa ed enigmatica, si dileguerà fantasmaticamente, eclissandosi in maniera altrettanto ignota e celere in un imprecisato altrove ermetico, aleggiando misticamente nel suo ipnotico spettro marmoreo.
Ambiguo, irresistibile, dominato dalla presenza titanica e rocciosa d’un Clint Eastwood eccellente, contornato da un cast di prima scelta, in cui si distinguono le presenze di Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Ted Hartley, Jack Ging, Billy Curtis e Geoffrey Lewis, Lo straniero senza nome è una delle pellicole imprescindibili nel carnet filmografico di natura, diciamo, eastwoodiana, e una pietra miliare della sua vastissima, giustamente lodata e sconfinata, mirabile carriera da regista.
Spettrale, avvolto da cineree atmosfere lugubri di morte, sebbene ambientato quasi esclusivamente in ore solari, quindi con pochissime scene notturne, Lo straniero senza nome emana una forza quasi esoterica, diviene, nel corso del suo lineare eppur imperscrutabile intreccio narrativamente desueto, un western metafisico ove a contare non sono tanto le azioni e quanto avviene e mostratoci, bensì le sottilissime e perturbanti implicazioni psicologiche effettuatevi in modo quasi impercettibile. Cioè, il film, apparentemente banale, perfino assurdo nelle sue dinamiche diegetiche, lentamente ma in crescendo emozionale e subliminale, diventa una metaforica visione onirica sulla stranezza e il mistero della vita stessa.
In fondo, chi è tale “straniero?”. Da dove viene, perché è arrivato sin a Lago, perché fa quello che fa e svanisce, forse tornando nella meta imprecisata, a noi resaci sconosciuta, da cui giunse? Ma sta ritornando lì oppure chissà ove è sparito e dove sta or andando? Ciò non ci viene rivelato, non ci vengono fornite le motivazioni, spesso irrazionali, dei gesti contradditori che, a Lago, compì. Perché, per esempio, fa eleggere sindaco un nano e, allo stesso tempo, si dimostra irriverente, soventemente sgarbato, perfino manesco nei confronti del gentil sesso?
Splendida fotografia di Bruce Surtees e strepitosa scenografia, scarna ma assai efficace ed inappuntabile, di Henry Bumstead.

di Stefano Falotico
C’ERA UNA VOLTA IN MESSICO, recensione
Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento immancabile, speriamo apprezzato, coi Racconti di Cinema, disamineremo C’era una volta in Messico (Once Upon a Time in Mexico), distribuito nelle sale nel 2003 e firmato da Robert Rodriguez (Spy Kids, Machete).
Ascrivibile, in forma dizionaristica e puramente classificatoria, in forma generalista, alla cosiddetta trilogia del Mariachi, facente parte d’un terzetto insorto e generatosi per casualità all’interno dell’excursus filmografico di matrice rodrigueziana, inaugurato giustappunto dalla pellicola cult El Mariachi del ’92 con Carlos Gallardo (qui in vesti, esclusivamente, di produttore), poi trasfusosi in Antonio Banderas che ne ereditò il ruolo in salsa hollywoodiana con Desperado nell’anno 1995, C’era una volta in Messico, così come per il capostipite poc’anzi citatovi e il suo secondo episodio, è un film, oltre che diretto, scritto e prodotto dal regista di Dal tramonto all’alba e dura, scorrevolmente, un’ora e quarantadue minuti netti, sanguigni, perfino sanguinari, adrenalinici, suggestivi e corposi. Sebbene, premettiamo subito, C’era una volta in Messico non possiamo di certo definirlo un capolavoro, in quanto non è un’opus eccelso e perfetto, bensì semplicemente spassoso e, in molti punti, inventivamente divertente e, a tratti, appassionante dalla discreta amalgama che mixa, con gusto e sapida ironia, scanzonato entertainment da pastiche guascone all’action secco e violento. Alternando momenti leggeri d’ilarità ad altri più orientati al melò più romantico eppur mai serioso né banale e/o convenzionale.
Trama:
Stavolta, il Mariachi (Banderas) è richiamato in servizio da un losco, seppur bellissimo e affascinante, misterioso agente, sotto copertura, della CIA (Johnny Depp), al fine di sabotare un complotto e l’assassinio pianificato e ordito ai danni del Presidente messicano.
In questa temeraria e assai pericolosa impresa intrepida, non priva di sorprese, sarà affiancato da due fidi scudieri (Marco Leonardi & Enrique Iglesias), alla pari di lui, chitarristi di pregio.
Secondo le testuali parole del dizionario Morandini, dal quale trarremo, sottostante, un breve estratto… 
Rodriguez dice che il progetto è nato dal suo amore per Sergio Leone e dagli incoraggiamenti dell’amico Q. Tarantino. L’omaggio al grande maestro del western lo apprezziamo e sull’amicizia non si discute. Ma lui l’ha scritto, prodotto, diretto, fotografato e montato, e ne ha fatto uno scoppiettante, frenetico, chiassoso, furibondo mix di azione, western, pulp, hard boiled, all’insegna di un Kitsch sfrenato e di effetti speciali in alta definizione. La cosa migliore: J. Depp, irresistibile quando uccide un cuoco che ha cucinato l’arrosto di maiale che non gli piace, memorabile quando si aggira con gli occhi che grondano sangue, moderno Tiresia cinico e bellissimo. Gli altri sono solo nomi prestigiosi per figurine di un innocuo videogioco.
Concordiamo appieno col sintetico ma preciso giudizio citatovi e da Morandini espresso, però citando (perdonateci per la voluta ripetizione e il gioco di parole), perlomeno, il carisma e la bravura d’un Willem Dafoe e di un Mickey Rourke, entrambi villain, in grande spolvero e magnetici.
Puerile, sciocco, volontariamente esagerato e mai pretenzioso, con un bell’incipit ridondante e un finale romantico decisamente roboante, C’era una volta in Messico, qualche volta, annoia, sovente gira a vuoto ma si lascia vedere con piacere, intrattenendo al contempo con molti spunti simpatici e guizzi registici d’alta scuola e collaudata maestria.
Insomma, il regista di Sin City non volle realizzare un film indimenticabile né paragonarsi a Leone. Bensì, ispiratosene, desiderò soltanto creare un burlesco e scoppiettante fumettone, ripieno di citazioni e forti echi cinematografici, da mandar giù in un sol boccone senza troppa presunzione.
Ovviamente, ritorna la sensualissima Salma Hayek e assistiamo alla folgorante new entry di Eva Mendes.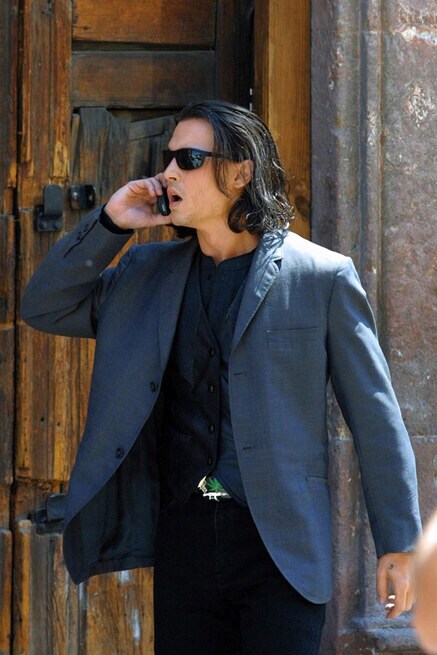





di Stefano Falotico