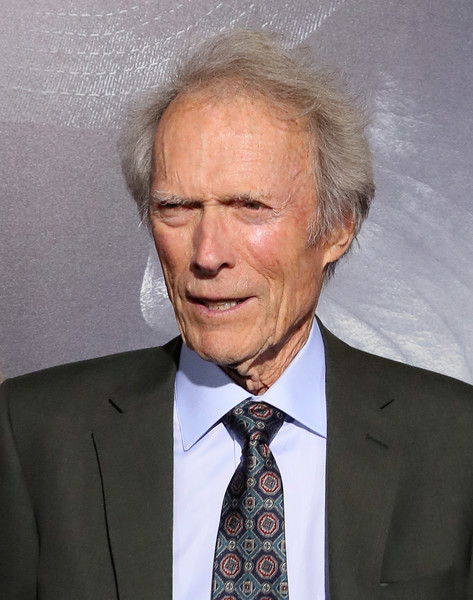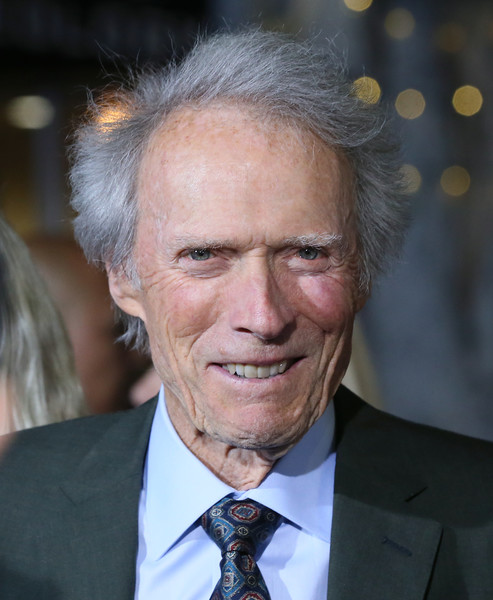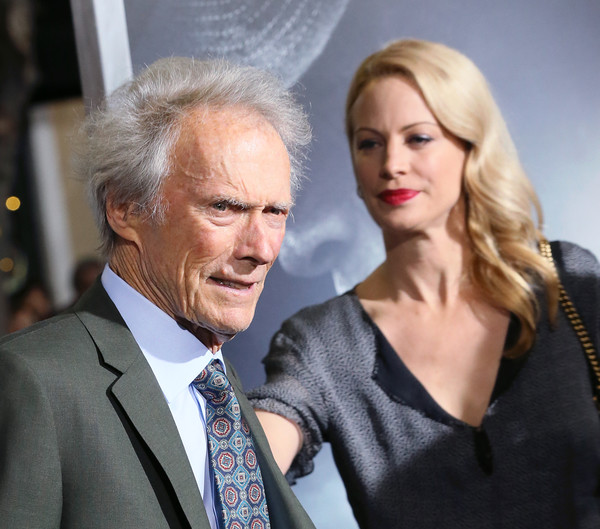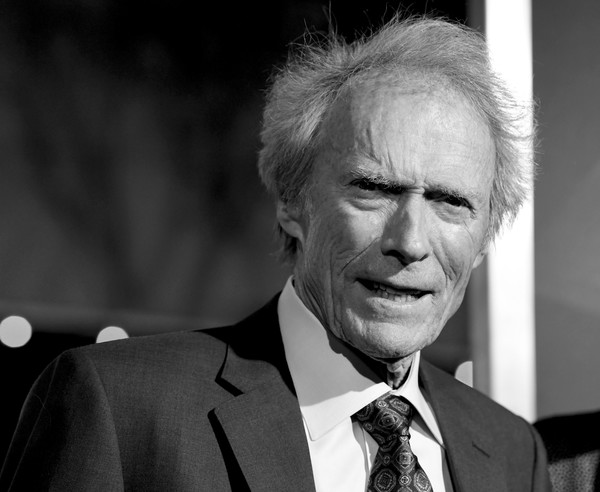Racconti di Cinema – Mio cugino Vincenzo con Joe Pesci e Marisa Tomei
Oggi recensiamo un piccolo cult degli anni novanta, ovvero il divertentissimo Mio cugino Vincenzo (My Cousin Vinny), commedia del 1992 della durata esatta di due ore nette.
Scritta da Dale Launer e diretta da Jonathan Lynn.
Mio cugino Vincenzo è un film dalla trama piuttosto esile, un film deboluccio dal punto di vista prettamente cinematografico ma che, sin dalla sua uscita, è stato molto apprezzato dalla Critica, crescendo negli anni e diventando, come detto, una pellicola di culto, soprattutto fra gli estimatori di Joe Pesci, qui in una delle sue prove più istrioniche, un one man show assolutamente irresistibile, una performance burlona sorretta dalla sua incontenibile, ruspante verve contagiosamente spassosa. Tale, nella sua buffonesca e grottesca spacconaggine interpretativa, da suscitare un’immediata simpatia e ilarità à gogo.

MY COUSIN VINNY, Mitchell Whitfield (far left), Ralph Macchio (second from left), Joe Pesci (third from left), Marisa Tomei (far right), 1992. ©20th Century Fox
La trama è essenzialmente questa…
Due giovani, anzi, come direbbe il personaggio incarnato da Joe Pesci, due giovini (plurale di giovine, ah ah), Billy Gambini e Stanley Rothenstein, rispettivamente Ralph Macchio (Per vincere domani – The Karate Kid) e Mitchell Whitfield, sono in viaggio verso l’Alabama. Sostano alla drogheria di una stazione di benzina ove fregano una scatoletta di tonno. Alla loro uscita dal negozio, vengono subito inseguiti dalla polizia. E accusati non di furto, bensì di omicidio.
Vengono immediatamente fermati e trascinati in carcere. Si è trattato indubbiamente di un equivoco giudiziario. Sì, loro hanno rubato una scatoletta di tonno ma non hanno ammazzato nessuno. A commettere l’assassinio son stati dei malviventi… Che micidiale fraintendimento.
In seguito a un’altra serie d’incredibili qui pro quo, i giovani ingenuamente si dichiarano colpevoli. A quel punto, i due comprendono che saranno processati, rischiando addirittura la pena capitale. E non hanno i soldi per potersi permettere un avvocato che possa sbrogliar loro l’intricata matassa e scagionarli dalla falsa, tremenda accusa.
Al che, a Billy sovviene che suo cugino Vincenzo (Pesci, appunto) è un avvocato ed essendo uno di famiglia può prestar loro la giusta difesa in forma totalmente gratuita.
Vincenzo accorre istantaneamente al loro “capezzale” ma è un avvocato senz’alcuna esperienza processuale, da pochissimo peraltro iscritto all’albo. Eppure, con ammirevole incoscienza sfacciata e ridicola goffaggine spregiudicata si lancia in questa missione impossibile ai limiti dell’inverosimile più assurdo.
Spiazzando l’inflessibile giudice Chamberlain Haller (Fred Gwynne), il quale è perennemente sospettoso nei suoi riguardi e continuamente lo redarguisce, lo sgrida e condanna innumerevoli volte per vilipendio alla corte.
Nonostante ciò, Vincenzo, notevolmente sostenuto e aiutato dalla sua determinata, coraggiosa e scafata compagna Mona Lisa Vito (una brillante, esuberante e fatalona Marisa Tomei), riesce a far assolvere il nipote e il suo amico, vincendo la causa malgrado abbia un po’ imbrogliato il giudice in merito alle reali, comprovate referenze della sua discutibile e non acclarata carriera misteriosa di avvocato. A prescindere da questo venale sotterfugio, la giustizia, anche se in maniera canzonatoria e burlesca, ha imprevedibilmente trionfato.
Un film che incassò benissimo, Mio cugino Vincenzo è da ricordare anche perché ha permesso a Marisa Tomei di vincere, sorprendentemente, il suo unico Oscar (eh sì) come miglior attrice non protagonista, sconfiggendo addirittura le veterane e più accreditate Judy Davis di Mariti e mogli, Joan Plowright di Un incantevole aprile, Miranda Richardson de Il danno e Vanessa Redgrave di Casa Howard. Pensate… queste quattro attrici, probabilmente più meritevoli della Tomei, sono ancora lì a mordersi le mani e a chiedersi come sia stato possibile aver perso la bramata, agognata statuetta. Innalzata invece dalla bella e sexy ma, all’epoca ancora poco famosa, Marisa.
E infatti, nonostante la Tomei sia ottimamente in parte e assai raggiante, è a tutt’oggi uno dei premi Oscar più controversi e leggermente incomprensibili che l’Academy abbia mai assegnato.
Mio cugino Vincenzo è un filmetto, ovviamente, ma attenzione: la fotografia è firmata da Peter Deming, lo splendido direttore di luci, fra gli altri, di David Lynch (Mulholland Drive, Strade Perdute, Twin Peaks: il ritorno).
Pure questo ha dell’allucinante. E in effetti non è che la fotografia di Deming sia poi granché. Anzi, il taglio dato alle immagini è esattamente quello di un b movie tipico dei nineties, da veloce consumo, un po’ grossolano e sciatto.
Come detto, gran merito della riuscita del film, che si segue benissimo e molto volentieri, è dovuto alla travolgente prova di Pesci, nei panni appunto dell’impresentabile avvocaticchio Vincenzo, un nanerottolo sprovveduto in materia giuridica ma immensamente carismatico.
E i suoi faccia a faccia con l’integerrimo e severissimo giudice, i duetti tragicomici fra loro due sono, assieme alla sua interpretazione mattacchiona, uno dei punti di forza di questa leggera e godibilissima commedia degli equivoci.

MY COUSIN VINNY, Joe Pesci, Marisa Tomei, 1992, TM and Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.”
di Stefano Falotico
True Detective 3, recensione dei primi due episodi
Ebbene, c’era grande attesa per il ritorno di una delle serie antologiche più amate degli ultimi anni, ovvero True Detective. Dopo la fastosa e irripetibile grandezza della prima stagione che, appunto, generò la true detective mania ed elesse in gloria il suo ardito creatore Nic Pizzolatto, elevandolo subito a genio incontestabile per aver dato vita, con la sua sceneggiatura nichilistica e profondamente dark, a ipnotiche atmosfere rarefatte di suadente potenza emozionale, dopo la consacrazione del suo straordinario protagonista, Matthew Conaughey che, con la sua eccezionale incarnazione dell’oramai leggendario Rust Cohle, visse un insuperabile anno mirabile, in concomitanza peraltro con la sua vittoria dell’Oscar per Dallas Buyers Club, dopo la parzialmente deludente, forse fiacca e monotona stagione due con Colin Farrell e Vince Vaughn, eravamo tutti indubbiamente molto curiosi di assistere alle nuove, spericolate prodezze appunto partorite dalla fervida mente del suo poc’anzi menzionato “anfitrione” Pizzolatto, qui al suo terzo banco di prova.
Ecco, è ancora assai prematuro, in attesa che pian piano la HBO a puntuale scadenza settimanale rilasci gli altri episodi, poter avanzare giudizi entusiastici in merito a questo True Detective 3.
Quello che possiamo certamente affermare, dopo aver visto soltanto i primi due episodi, è che Pizzolatto, ottimamente servito dalla consueta regia malinconicamente plumbea, notturna e pallidamente ombrosa di Jeremy Saulnier (Hold the Dark), ci ha già riportato indietro con la memoria alla prima, succitata, acclamata stagione. Stagione forse non priva di difetti ma, come detto, fenomenica e probabilmente anche fenomenale.
True Detective 1 era un cupissimo noir ambientato nelle paludi della Louisiana. Sorretto, ripetiamolo, dalla performance travolgente d’un McConaughey in stato grazia, ottimamente affiancato da un altrettanto bravissimo Woody Harrelson, servito dalla regia fluidamente portentosa di un Cary Fukunaga parimenti ispirato, innestato sull’indagine di misteriosi, macabri omicidi perpetrati ai danni di giovanissime innocenze da parte di una micidiale setta satanica. E, nella superba mistura fascinosissima d’una detection intrecciata all’imponderabile natura sovrannaturale, magneticamente torbida e spettrale della vicenda, al di là di qualche trascurabile grossolanità, come già rimarcato, rimarrà indiscutibilmente una pietra miliare della televisione migliore. E della tv che, al suo zenit, si fa grande Cinema.
La stagione due invece, forse però criticata oltremodo, è stata un hard–boiled decisamente claustrofobico e ripetitivo a cui non giovarono affatto i continui cambi di registro e di regie. E, per via della sua sin troppo scontata linearità e a causa della sua ambientazione metropolitana sicuramente affascinante ma povera di respiro, deluse non poco le aspettative.
Qui, Pizzolatto, torna a un setting più selvaggio. Siamo nell’altopiano di Ozark e, infatti, alla fine dell’episodio uno echeggia la voce rocciosamente, magicamente melanconica e ruvidamente cristallina di Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) firmata da Mickey Newbury, reminiscente dell’incendiario Bruce Springsteen (il suo album Nebraska docet), e veniamo immersi tra gli anfratti montagnosi, desolati e boschivi d’una sperduta cittadina anonima.
Un bel giorno, anzi, sarebbe più appropriato dire, in una serata apparentemente tranquilla, un padre di famiglia divorziato, un po’ scalognato e teneramente abbandonato a sé stesso, Tom Purcell (Scoot McNairy), si mette alla ricerca dei suoi due figli piccoli, fratello e sorella. Che si erano allontanati per fare un giro in bicicletta, gli avevano promesso che avrebbero rincasato per le cinque e mezza de pomeriggio e invece, a tarda notte, ancora non si sono fatti vivi e paiono essersi sperduti nella foresta. Eclissatisi nella luna piena di un day indimenticabile oramai tramontato nel buio più maledettamente stellato. Al calar tenebroso dello stesso giorno, 7 Novembre del 1980, in cui è morto il mitico Steve McQueen.
Due investigatori del posto, in pattuglia a perlustrare la zona, il granitico e ieratico Wayne Hays (Mahershala Ali) e lo sbruffone Roland West (Stephen Dorff), vengono avvertiti della scomparsa dei due bambini e subito cominciano a indagare in merito alla scioccante sparizione.
Dopo qualche interrogatorio, molti dubbi e alcune conoscenze forse centrali per la loro stessa esistenza, scoprono la verità. O meglio, Wayne Hays decide di volerci immediatamente vedere chiaro e, in tutta intrepida solitudine, inizia istintivamente a seguire una pista personale, inoltrandosi nel bosco. Dopo uno spaurito, tremante e al contempo incalzante suo peregrinare nella boscaglia, scopre il cadavere del bambino scomparso, incagliato in un giaciglio fra le rocce. Non però quello della sorella, della quale invece non c’è traccia.
Sottolineiamolo, è ancora prestissimo per potersi sbilanciare ma sin ad ora True Detective 3 funziona parecchio. Anche se è una “copia” della stagione 1. Tra flashback, inquadrature sui volti in macchina dei due detective e interviste per tentare di elucubrare, anatomizzare e ricomporre in analessi e flashforward lo scandirsi degli eventi trascorsi e futuri.
La prima mezz’ora del primo episodio, inoltre, avvolta dalla calda fotografia di Germain McMicking, ricorda non poco le suggestioni atmosferiche del fincheriano Zodiac.
Strepitoso Ali. Qualche dubbio invece su Dorff, bellissima, ça va sans dire, Carmen Ejogo.
Ma siamo soltanto all’inizio. Vedremo se True Detective 3 manterrà le valide premesse e promesse.
di Stefano Falotico
The First con Sean Penn, recensione
Recensiamo una delle serie televisive evento dell’anno, approdata in esclusiva il 18 Dicembre su TIMvision e distribuita internazionalmente da Hulu, ovvero The First, col due volte premio Oscar Sean Penn, qui alla sua prima, vera prova per la tv e anche alla sua prima performance recitativa dopo qualche anno sabbatico, i suoi mille flirt e le sue discutibili incursioni con El Chapo.
The First è un drama–science fiction che consta di 8 episodi di circa quarantacinque minuti l’uno, creata dalla fervida mente di Beau Willimon, lo sceneggiatore di House of Cards, Le idi di Marzo e dell’imminente Maria regina di Scozia.
I primi due episodi di The First si avvalgono della regia dell’acclamata Agnieszka Holland (Poeti dall’inferno) che qui, dopo tante sue regie impegnate a tematica neorealistica, si cimenta con un genere a lei tutto nuovo, la fantascienza. Anche se dobbiamo essere fin dapprincipio molto chiari.
Le vicende di The First si svolgono, sì, nel futuro, esattamente nell’anno 2030 e seguiamo le intrepide, arrischiate manovre di un team di scienziati per approntare il primo viaggio su Marte, ma la storia è comunque umanisticamente assai agganciata alle realissime, veritiere, intime emozioni dei suoi protagonisti.
Sì, The First si concentra sui conflitti di coscienza dell’astronauta Tom Hagerty (Sean Penn) e, in particolar modo, sui suoi drammi personali. In primis, sulla sua vita privata decisamente complicata. Hagerty ha una figlia adolescente problematica e tossicodipendente (Anna Jacoby-Heron) e non si dà pace in merito al suicidio dell’ex bella moglie Diane (Melissa George).
E, dopo i primi due episodi, diretti proprio dalla Holland, nei quali noi spettatori siamo stati immersi nell’atmosfera avveniristica di un futuro alquanto prossimo, la trama prende una piega inaspettata e, anziché continuare a svilupparsi lungo un arco narrativo a base (il caso di dirlo) d’ingegneri spaziali ed esplorazioni del firmamento galattico, diciamo, si addentra nelle psico-tragedie individuali dei vari personaggi. Diventando una sorta di malickiana indagine nell’anima tormentata di un’umanità che forse sogna interstellari viaggi marziani per sopperire alle sue debolezze. Come se la chimera di un mondo migliore possa alleviare il mal di vivere metafisico su questo nostro Pianeta, ove siamo meteore vaganti nella perpetua afflizione delle nostre paure abissali e delle esistenziali incognite irrisolte.
Ed è forse questo radicale cambio di registro e d’impostazione diegetica ad aver in parte sciupato una storia che probabilmente doveva seguire maggiormente e più linearmente lo spunto intrigante di partenza e invece, in maniera predicatoria, è stata non poco appesantita con pedanti, superflui, a volte sofistici pistolotti palingenetici e moralmente filosofici. Avremmo preferito, sinceramente, una semplice storia su uomini addestrati per compiere il primo viaggio sul pianeta Rosso. Senza venir distratti da irrilevanti, stoppose parentesi intellettualoidi.
Nayasha McElhone, nei panni della temeraria e cinica coordinatrice della missione, Laz Ingram, è comunque perfetta e sempre affascinante.
E Sean Penn, rughe vistose e capelli tinti permettendo, fa come al solito il suo buon lavoro. Anche se, onestamente, sono davvero troppe le gratuite scene in cui si esibisce a petto nudo e mostra, parimenti a The Gunman, il suo taurino fisico dai bicipiti pompati. Tanto che ci viene il dubbio che sia stato lo stesso Sean, per puro esibizionismo, a richiedere insistentemente che molte di queste suddette, anzi, “sudate” scene, in cui corre semi-ignudo per strada, venissero girate esclusivamente affinché potesse sfoderare vanitosamente il suo corpo modellato e scultoreo. E, per lunga parte di questa spesso soporifera serie televisiva, l’attore premio Oscar di Mystic River e Milk si trascina con aria stanca e un viso sciupatissimo, ai limiti della paresi facciale. Permetteteci questa battuta. Tanti (a)steroidi smaccatamente malati di protagonismo plateale. E The First, nonostante le molte intuizioni piacevoli e appassionanti, rimane freddamente sospeso nel suo cervellotico, visivo, asettico onanismo mai pienamente emozionale.
The First resta, a prescindere da ciò, una buona serie che si segue perfino con piacere ma era lecito chiedere di più.
Metaforicamente parlando, volevamo che, come un missile, questo prodotto, sconclusionato e confuso, volasse molto più alto.
di Stefano Falotico
Kenneth Branagh è William Shakespeare perché è il più grande: Dio è nato, Dio è morto, evviva i dannati
Sono davvero pochissimi gli attori e i registi che stimo.
Col passare del tempo, i miei gusti cinematografici si stanno sempre maggiormente raffinando e sono meno ruffiani nei confronti di me stesso. Che, con lucidità spaventosa, si guarda perennemente allo specchio e non rinnega i suoi timori, le sue ansie giammai sopite, vaga oggi fantasmatico e domani acquiescente in questo spettrale orrore ch’è la vita umana, soprattutto quella occidentale. Indaffarata com’è a rivaleggiare, a vivere di tribali competizioni bastarde, a recidere le coscienze che si son dissociate dal pensar comune di massa.
E le ricatta, le soffoca, le reprime e le castiga con abominevoli mostruosità figlie appunto del falsissimo, osceno retroterra culturale di cui è imbevuta la nostra società. Improntata a idolatrie effimere, a gioie frivole, al culto ostinato della perfezione estetica e fisica, al vivandar di burrosi culi, innalzata a monumento putrido delle vostre anime da tempo immemorabile corrotte, prostituite, plastificate, indirizzate a un finto benessere che io vi dico non vi ha reso felici ma soltanto delle maschere annacquate nella mortifera contentezza vacua della vostra esistenziale immondizia abissale.
Sconcertato sempre di più, passeggio al mattino, in questo mattino plumbeo in cui rimescolo le mie angosce lunatiche e, da strampalato pagliaccio scombiccherato, nuoto tra la folla di un bar, sorseggiando lo zucchero delle vostre vanità ributtanti.
Sì, Shakespeare è stato il cantore per antonomasia della tragedia della condizione umana. E anch’io, parimenti a Kenneth Branagh, penso che sia il più grande.
Dostoevskij, enorme, ma sostanzialmente era un solipsista, ripiegato sulle sue afflizioni a vergarle in prose sanguinarie del suo agghiacciante disagio di sentirsi maledettamente vivo e saggio. Inquieto e dunque inquietante, ombelicale nel farsi autoritratti letterari a elevazione e sublimazione, forse inutile, del suo esser già un morto vivente, un ectoplasma illuminato da una sana pazzia catartica.
Charles Dickens, uno scrittore pauperista, principe delle marginalità, delle storie ove i protagonisti sono degli orfani, dei diseredati, dei giganti in un mondo di nani piccolo-borghesi. Ma anche lui, così come Dostoevskij, era autoreferenzialmente ossessionato dalle solite, stantie, deprimenti tematiche.
William Shakespeare invece, pur rimanendo estremamente coerente con la sua radicale, lapidaria visione del mondo, era una sorta di dio spirituale, un inglese sul Monte Sinai a decretare il suo brutale, schietto decalogo.
Ad avvertirci che siamo tutti figli di un inferno in terra, un inferno porco. E, quando pensiamo, illusi, beoti, rimbambiti da troppe chimere, di essere arrivati alla vetta, ecco che ci piomba addosso una devastante tegola che ci flagella.
Un’inaspettata o forse annunciata tragedia. E William scriveva con classe impari, nessuna parola nei suoi testi è fuori posto, vivificato com’era il suo animo da un’ascesi contemplativa di natura mistica, da uomo che, coltivando insalata nell’orto, non sentiva la necessità, perciò immotivata e a lui appunto non connaturata, di vivere una cosiddetta frustrante vita normale sbagliata. O solo, come i più, sbadigliata…
E osservava, si struggeva nelle storie da lui inventate, romanzando e magnificando l’amore, forgiando di strepitosa energia il suo cuore nello strofinarlo dolce e poi amarissimo in vicende contorte, inzuppandole d’intrighi di corte.
Un genio. E, come quasi tutti i geni, un povero Cristo sebbene fosse ricco. Un esimio drammaturgo insuperabile, un indagatore delle bugie e un sapido detective delle nefandezze umane, dunque disumane.
Io, nella mia vita, ho avuto molti attori preferiti. Sapete tutti che il mio idolo è stato, per tantissimo tempo infinito, Robert De Niro. Ma non poco mi ha deluso questo Bob. Che ora, a prescindere da The Irishman, annaspa solamente nella patetica e parodistica celebrazione del suo inossidabile mito.
Molti attori, per quanto ammirati, imitati, osannati, a mio avviso son soltanto delle puttane. Dei mercenari che prestano le loro bellezze ove a lor più conviene e svendono i loro talenti, veri o presunti che siano, di qua e di là senz’alcuna linea direzionale. In alcuni film sono magnifici, come Matthew McConaughey, in altri, come lo stesso McConaughey, fanno schifo al cazzo.
Branagh, invece, per quanto non tutti i suoi film possano dirsi riusciti, per quanto alcuni di essi siano calligrafici e leziosi, per quanto sia un egomaniaco, un narcisista insopprimibile, è un grandissimo.
E mi piace scherzare su questa sua mimesi nei panni di Shakespeare in All Is True perché il suo look mi ricorda tanto la faccia dal naso oblungo di Ben Kingsley. Ah ah.
Nella mia vita, amici carissimi, ne ho viste tantissime.
Ragazzi grandiosamente belli, sanissimi, con tante stupende virtù, caduti in depressione. Immalinconiti da una società cinica e ladra. E allora ecco che li sbattono a curarsi.
Sì, a sorbirsi tristemente farmaci repressivi, a cuccarsi contenzioni fisiche, a esser distrutti nella, vivaddio, squillante sessualità abbacinante, troppo aggressivamente ruspante che viene reputata dai cretini qualcosa di rivoltante. Mortificati in deludentissimi percorsi angarianti la loro speciale personalità ribalda.
Oh, padri, madri, non portate mai un figlio da questi pazzi curatori dell’anima, da questi “strizza-uccelli”.
Lasciate invece che le loro meravigliose diversità si coagulino alla bellezza del creato, lasciate pure che si arrabbino, che soffrano, che siano forti, intrepidi, timidissimi o romantici ai limiti della scemenza più caramellosa. E poi dilapidino le loro stesse bellezze in gioviali, affabilissime demenze godibilissime.
Perché è vita, questa è la vita, non si può anestetizzare la vita, imbrigliandola in qualche vetusta, oscurantistica, sciocca patologia scriteriata.
E voi, uomini e donne che vi credete adulti! Ma qual è la vostra vita? Oggi è domenica, è aperto il Mercatone Uno, tu, donna, vai matta per l’IKEA e quel bagno pulisci e ripulisci per renderlo splendente quando, dopo tre minuti, tornerai a inzozzare il water con la cagata tua incarnata tanto fetente.
Un lavoretto per coprirvi di una filistea dignità sociale. E poi tanti scheletri nell’armadio, tanti sorrisi ipocriti, tanti giochini, tante invidie, tanti odi, tante balle.
E, fra un balletto, un nuovo vestitino, una partitina alla tv, una mangiatona, una statuina nella mangiatoia, un apprezzamento bavoso a un’altra troietta, una pisciatina e una scopatella, oh, evviva la vita che è una merda ma val la pena dir ch’è bella. Perché guai a dir il contrario. Potresti esser emarginato, offeso, insultato.
Quante illusioni, oh, scemi, vi eravate creati. E la batosta arrivò per tutti. Per me e anche per i “grandi”.
La vita è una tragedia. Dovevate impararlo subito. Non piangete sul latte versato, sull’altare rubato. Sulla cattiveria ora vostra ritornatavi.
E questo è quanto.
Anzi no. Tutti i film di Branagh sono shakespeariani. Anche Thor lo è. E pure il suo Hercule Poirot altri non è che un uomo che s’immerge nell’orrore delle bassezze dei miserabili.
E, in Frankenstein di Mary Shelley, si respira grande vita. Quando la madre di Frankenstein muore di parto, sono rimasto scioccato.
È allora che Frankenstein impazzisce.
E diventa il più pazzo di tutti, il più grande.
Vuole sfidare Dio e Dio nella sua anima è invero già morto.
di Stefano Falotico
Run All Night – Una notte per sopravvivere di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson e Ed Harris
Ebbene, oggi recensisco Run All Night – Una notte per sopravvivere dello spagnolo, oramai trapiantato a Hollywood, Jaume Collet-Serra. Film che segna la sua terza collaborazione con Liam Neeson, prima della quarta, L’uomo sul treno.
Su sceneggiatura originale di Brad Ingelsby, Collet-Serra, è il caso di dirlo, allestisce un film della durata serrata di quasi due ore piene di adrenalina e interminabili colpi di scena, servendosi del corpo massiccio e del viso sempre più spigoloso di Neeson e della faccia di pietra, da morto vivente, dello straordinario Ed Harris, il quale nei duetti con lo stesso Neeson (bellissimo quello, lancinante e sofferentissimo, alla tavola calda) ruba a quest’ultimo puntualmente la scena, sfoderando un magnetismo espressivo degno del suo indimenticabile volto scavato da macilento filibustiere del grande schermo. E qui, nonostante non sia il protagonista, sfruttando appieno tutto il suo mortifero sguardo acquoso, imprime al suo personaggio una caratura quasi biblica.
Stando all’enciclopedia libera Wikipedia, la trama è questa:
Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose mettendo Michael a confronto con Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire. Shawn è anche il capo di Jimmy e suo amico fraterno: entrambi appartengono ad una generazione entrata nel crimine più per mancanza di alternative che per scelta, entrambi sono legati ad un codice d’onore che la generazione dei loro figli ignora o disconosce.
Aggiungo io, in seguito a un rocambolesco misfatto, Danny (Boyd Holbrook) si mette nei guai.
Shawn (Harris), per risolvere il casino scatenato da suo figlio Danny, contatta il suo inseparabile amico Conlon (Neeson), un uomo che oramai, a parte Shawn, non ha più amici e si trascina stancamente da ubriaco marcio in una città livida e funerea nella quale, meditabondo e angosciato dal suo irrimediabile passato di crimini e violenze, vaga perduto come un clown sardonicamente rattrappito dalla sua inguaribile amarezza esistenziale. Un lupo solitario prosciugato nell’anima, incupitosi nella perdizione dei suoi irreversibili, infimi peccati infiniti da irlandese bugiardo.
Conlon accorre a sua volta a casa di suo figlio Michael (Joel Kinnaman) con cui non scorre affatto buon sangue. Danny, da scavezzacollo irrecuperabile, fa irruzione in casa di Michael e sta per ucciderlo quando, tutt’a un tratto, Conlon lo trafigge mortalmente con una pistolettata fatale.
A questo punto, Conlon diventa l’assassino del figlio del suo unico e migliore amico, Shawn. Shawn vuole vendicarsi e, in una notte buia come la pece, stropicciata da fugaci lampi nel cielo sanguinosamente tetro, senza un attimo di tregua dà la caccia a Conlon e a suo figlio. Assolda anche un sicario spietatissimo e apparentemente infallibile, una sorta di lugubre, taciturno Terminator vestito da impiegato, il monolitico e statuario colosso Andrew Price (Common). Nel mezzo di questa sfida infernale, abbiamo anche l’infermabile, luciferino detective John Harding (Vincent D’Onofrio).
Che dire? Un thriller d’annata, sorretto da un Neeson sempre più macho action che continua nella sua nuova linea attoriale da giustiziere feroce afflitto da logoranti e inestirpabili complessi di colpa, un duro irredento alla Io vi troverò, il cui personaggio pare una variazione di quello da lui interpretato ne La preda perfetta. Altro film imperdibile. Nonostante la psicologia dei personaggi sia un po’ tagliata con l’accetta e il film abbondi di molte stereotipie manichee, si lascia guardare volentierissimo grazie all’impartitovi ritmo frenetico di una vicenda, come detto, spericolatamente inzuppata di suspense ottimamente calibrata e magistralmente diretta da un Collet-Serra assai ispirato.
La cui furiosa ed energica regia, tecnicamente ineccepibile, tocca sublimi picchi vertiginosi e funambolici in strepitosi voli d’angelo della macchina da presa, molto suggestivi, sebbene avvalsisi di una finissima, e comunque mai invadente, computer graphics meticolosamente tagliente.
Il film è una specie di Guerrieri della notte in veste di poliziesco-western metropolitano, un Die Hard sui generis scandito da un’irruenza cinetica, contrappuntato da un’azione caotica, scintillante e turbolenta, modellato sul grintoso Neeson e soprattutto languidamente, ipnoticamente illuminato dal mortuario e malinconicissimo Ed Harris.
Un film, a mio avviso, parecchio sottovalutato dalla Critica all’epoca. Non un capolavoro ma un prodotto di genere decisamente superiore alla media. Che tiene incollati alla sedia, o poltroncina se preferite, per tutti i suoi dinamitardi centoquattordici minuti vigorosamente emozionanti.
Ripeto, i personaggi sono leggermente plastificati e assistiamo al solito, alquanto banale, scontro fra buoni contro cattivi ma Collet-Serra, pur non lesinando in alcuni patinati estetismi di maniera e non imprimendo quasi mai la sufficiente forza introspettiva alla storia da lui filmata, sa eccome il fatto suo e ci regala perfino alcuni momenti davvero affascinanti ove mischia aziona purissima e mozzafiato inseguimenti al cardiopalma a buone riflessioni etiche, dosando la sua estetica stilistica, appunto, scuramente brusca e radente, ad audaci virtuosismi dalla robusta costruzione sanamente spettacolare.
Da vedere.
La sola, vera nota negativa è forse Joel Kinnaman, non adatto in questo caso alla parte del fragile ragazzo spaesato ma coraggioso.
Perché pare più che altro un dannato belloccio molto imbambolato e anonimamente sciupato.
Cammeo non accreditato del mitico Nick Nolte.
di Stefano Falotico
The Witch, recensione
Ebbene sì, recensiamo il film fenomeno del 2015, ovvero The Witch. Horror sui generis, opera prima di Robert Eggers, premiato come miglior regista al Sundance Film Festival, una pellicola acclamata un po’ ovunque in maniera unanime.
Ecco, è davvero il grande film di cui tutti parlano o, rivisto con maggiore e più profonda oculatezza, è decisamente sopravvalutato?
A mio avviso, e non me ne vogliate, sebbene mi attirerò le ire e le antipatie di coloro che, se leggeranno questa mia recensione, rimarranno certamente, fermamente convinti che The Witch sia oramai un’opera assolutamente indelebile del patrimonio cinematografico contemporaneo, permettetemi di avanzare qualche lecito dubbio riguardo la sua vera nomea di cult inderogabile.
Secondo il mio parere, The Witch non è un capolavoro. No. È tutt’al più un buon horror non del tutto originale, certamente anticonvenzionale che, però, nella sua poetica sfacciatamente demodé, nel suo stile ricercatamente, forzatamente naturalistico, nel suo esibito, insistito, oserei dire addirittura disturbante aver attinto compiaciutamente dalle atmosfere rarefatte e austere alla Dreyer e nell’averle dunque pressoché modernamente, puristicamente riprodotte in modo alquanto fedele, nel suo conclamato, spudoratissimo desiderio pretenzioso di voler riecheggiare i rigorosi fasti bergmaniani e, anche in tal caso, nell’averne introiettato e ricreato gli stilemi con sfrontata filologia emulativa, è perciò un film privo di una sua intrinseca, schietta originalità.
Come se Eggers, superbamente ispirandosi a modelli così inviolabilmente alti, copiandoli alla lettera seppur reinventandoli, peccando dunque di madornale immodestia, avesse già puntato a sacramentare il valore intoccabile della sua opera con la prosopopea tipica di chi, nell’ostentare tanto sfoggio visivo, è invero già caduto nella trappola di un insopportabile narcisismo da primo della classe.
Anno 1630, New England. William (Ralph Ineson) è un maniaco religioso che, a causa proprio del suo fondamentalismo cristiano da invasato, autarchico, dogmatico interprete sin troppo orgogliosamente ortodosso della parola di Dio, viene emarginato e bandito dalla comunità puritana con la quale prima viveva e ora si è eremiticamente rifugiato a vivere ai margini di una foresta spettrale, in compagnia soltanto di sua moglie e dei suoi cinque figli minorenni.
Un bel giorno, Samuel, il bambino più piccolo di questa famiglia, appena neonato, misteriosamente scompare.
A portarselo via è stata forse la strega che abita nel bosco.
Da questo sciagurato evento, un senso di mortale paura funerea comincia ad aleggiare e serpeggiare nei cuori via via più terrorizzati, angosciati, mostruosamente incupiti, affranti e persi di William e della sua famiglia.
Come se l’ombra minacciosa del diavolo, lentamente, in maniera subdolamente strisciante, si fosse infiltrata nelle loro anime, avvelenandole nella fin ad allora incontaminata, angelica purezza, estinguendole, infrangendole con la ferina crudeltà del suo peccaminoso, infimo, eternamente averle ammorbate, segretamente imprigionate nell’orrore macabramente più cupido e le avesse inghiottite nella tetra, ingorda, cannibalistica perversità del suo sinistro maleficio.
Poco meno di un mese di riprese per questa storia di discesa negli inferi della follia.
Sicuramente pretenzioso, ripeto. Affastella molti temi interessanti come i primi turbamenti dell’adolescenza, l’incesto e perfino l’esorcismo, senza mai svilupparne nessuno in maniera coerente e continuativa.
Si perde per strada, si sfalda, si regge quasi esclusivamente sulla fotografia plumbea e rugginosa di Jarin Blaschke, sulla forza espressiva del ruvido Ralph Ineson e sul viso di porcellana della bella
.
Approdando a un finale fiacco e assai ridicolo che pare un semi-rifacimento di Suspiria in un notturno falò di streghe nude che lievitano in cielo e paiono più che altro delle ragazze “imputtanite” e impazzite.
Spoiler…
E infine la strega tanto temuta, apparsaci di sbieco nell’unica scena veramente terrificante della prima mezz’ora e poi per un altro breve attimo reincarnatasi nelle fattezze sexy della giovane modella Sarah Stephens, dov’è andata a finire? L’aspettavamo con ansia, era lei l’attrattiva principale di un film sulla carta molto intrigante che però, come detto, non sa che direzione pigliare e si sbriciola nel corso della sua sola ora e mezza di durata. La strega doveva essere il clou di questa sorta di giallo psicologico anacronistico, storico e bucolico, e invece Eggers non ce l’ha mostrata. Dannazione!
Mah, un forte mah.
Abbastanza incomprensibile tutto il clamore che ha suscitato.
di Stefano Falotico
Roma di Alfonso Cuarón, recensione
Ebbene, vincitore del Leone d’oro alla 75.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, da venerdì scorso, 14 Dicembre 2018, è disponibile, dopo il suo brevissimo passaggio anche nelle sale, il tanto incensato e magnificato Roma di Alfonso Cuarón.
Quasi unanimemente definito il film più bello dell’anno, un capolavoro irrinunciabile.
Ecco, non voglio certo essere io a smentire l’intellighenzia della Critica che così bello l’ha giudicato in modo assolutamente, uniformemente concorde.
Secondo me, Roma non è affatto un capolavoro. Un ottimo film, ovviamente, ma non vi ho visto nulla che mi abbia fatto gridare al capodopera imbattibile di cui, in questi giorni, chiunque si riempie la bocca.
Roma è un perpetuo, insistito, ammirevole fellinismo (e ogni riferimento all’omonimo film di Federico Fellini, appunto, non è affatto casuale) privo di vero pathos, un egregio, finissimo lavoro del factotum Alfonso Cuarón, per l’occasione anche direttore della fotografia e montatore oltre che produttore, sceneggiatore e via dicendo, a mio avviso però sterile e anemico dal punto di vista visceralmente emozionale.
No, non è blasfemia la mia, affatto, è pura, personale, disinteressata obiettività.
Roma mi ha visivamente contagiato e ammaliato, son rimasto estaticamente ipnotizzato nel guardarlo, contemplandone la sua perfezione stilistica, l’uso spericolato, fluido, leggiadro, morbidissimo della lieve macchina da presa nel suo scroscio danzante fra lucidissimi, quasi patinati fotogrammi cesellati con sontuosa, avvolgente cura seducente per ogni dettaglio incantevole.
Ma ripeto, a livello prettamente emotivo, l’ho trovata una pellicola invero assai povera d’idee, noiosa, soporifera, congestionata dal limite, abbastanza evidente e innegabile, che il buon, scaltro Cuarón abbia voluto, programmaticamente, ideare e confezionare Roma al solo fine, lodevole quanto al contempo desolante ed egomaniaco, di realizzare un film da premi e riconoscimenti.
La classica opera, apparentemente intoccabile, inattaccabile, talmente intrappolata dalla rilucenza della sua potenza incantatrice, da lasciarmi inappagato.
Roma è il tipico esempio di film immediatamente sopravvalutato dai falsi intenditori di Cinema. Che, fatalmente sedotti, appunto, dal suo involucro tanto maliardo e cupidamente accattivante, hanno perso poi di vista l’essenza stessa del concetto profondo di Arte.
Perché Roma non è un film artisticamente elevato. È semmai, e non è mai un complimento, un film altamente arty. È cioè un film tanto esteticamente raffinato che potrebbe indurre molte persone, com’è infatti puntualmente avvenuto, a scambiarlo per qualcosa di più di ciò che invero è.
Roma non è un grande film. È un film malato di piacevole estetismo. Non è estetizzante alla maniera, alle volte insopportabile, che ne so di un Sorrentino, ma per certi versi, in questo grondante, suo sfacciato ed esibito, luccicante flusso d’immagini formalmente impeccabili, lindamente nitidissime, rimane purtroppo un evanescente, infecondo film che nasconde, dietro l’adescante stratagemma dl porsi come un adorabile oggetto ludicamente meraviglioso a vedersi, un’inconsistenza pressoché lampante.
La storia è semplicissima…
Siamo nel quartiere Roma di Città del Messico. Quindi, niente a che vedere con la nostra capitale e neppure, almeno dal punto di vista dell’ambientazione, col film di Fellini. Per quanto concerne invece, come già espresso, gli stilemi e le atmosfere à la Amarcord, è felliniano in tutto.
E seguiamo (assistiti in ciò, ribadiamolo, dalla mobilissima cinepresa svolazzante ed energicamente ondeggiante di Alfonso Cuarón) la vita di tutti i giorni di una famiglia borghese ma, in particolar modo, il nostro regista si addentra nel punto di vista, quasi lo spia ed enuclea, della loro domestica, la mixteca Cleo (Yalitza Aparicio).
La quale, durante la proiezione al cinema di Tre uomini in fuga (La grande vadrouille) con Louis de Funès, confida al suo fidanzato di avere il timore di esserne rimasta incinta. Il ragazzo, un po’ scosso dall’allarmante, inaspettata notizia, si allontana, va in bagno e lascia Cleo tutta sola…
Scopriamo poi che Cleo non si sbagliava. Dopo un’accurata visita medica, sì, le viene detto che, in effetti, non ha più da tempo il ciclo perché sta aspettando una bambina.
A quel punto Cleo ha paura di venir licenziata dalla sua padrona.
E fra haciende, riunioni familiari, incendi notturni nel bosco, un Capodanno di pasciuti uomini e donne annoiati che ballano sfrenatamente per dimenticare le loro frustrazioni, e l’attesa per il Corpus Christi, Roma scorre piattamente, incollandosi al volto malinconico e perduto della povera Cleo.
Con alcune reminiscenze perfino de L’infernale Quinlan.
No, Roma non è un capolavoro. E nemmeno gli si avvicina.
Non basta la classe, il fascino ammaliatore d’immagini stupende a far sì che possa essersi meritato di vincere il Leone d’oro e, con molta probabilità, ahinoi, anche il possibile Oscar.
No, avete preso un grosso abbaglio.
E dunque, ancora una volta, nonostante le sue spropositate ambizioni, Alfonso Cuarón, personalmente, è da me considerato nuovamente il regista più sovrastimato del mondo.
Sì, il suo Paradiso perduto fu davvero roba inguardabile. E parlo da fan sfegatato di De Niro. Dopo vent’anni, non cambio, mi spiace, il mio giudizio su Alfonso Cuarón. Che, dunque, reputo già come a quel tempo, al di là di ogni ragionevole dubbio e ripensamento, tuttora un regista mediocre. Forse leggermente migliore rispetto a due decadi or sono. Ma non di molto.
E che non posso annoverare, a differenza di voi, fra i maestri. Per niente.
Roma. Un bel film.
Sarebbe stato, forse, un capolavoro se avesse sin dall’inizio osato come nella magnifica, questa sì, tragica scena del parto e in quella prefinale, con la tragedia sventata dall’incolpevole, commovente Cleo.
Qui il film realmente si alza in cielo e poeticamente prodigioso sfiora la vetta di opera dal valore supremo, assoluto. Ma non basta la mezz’ora finale, potente, per riscattare un film sostanzialmente inerme.
Sono stato troppo lapidario? Questo sono io.
di Stefano Falotico
Racconti di Cinema – Barriere di e con Denzel Washington e Viola Davis
Oggi, a quasi due anni di distanza dalla sua limited release sugli schermi americani, recensiamo il film Barriere, da noi invece uscito il 23 Febbraio dell’anno successivo, diretto e interpretato da un eccezionale Denzel Washington.
Candidato a quattro premi Oscar: miglior film, migliore attore protagonista (Washington), miglior sceneggiatura non originale e miglior attrice non protagonista, unica candidatura per cui ha vinto la statuetta, andata a Viola Davis, Barriere è appunto tratto dall’omonimo, celeberrimo testo teatrale del drammaturgo August Wilson, premiato col Pulitzer. E già portato a Teatro dallo stesso Washington e anche da Viola Davis.
Partiamo dal titolo originale, Fences, decisamente più pertinente dell’erronea, approssimativa traduzione barriere.
Fences è semplicemente il plurale inglese di fence, ovvero il recinto, la staccionata. Chiodo fisso, è il caso di dirlo, del personaggio interpretato da Washington, Troy Maxson, un netturbino afroamericano sempre squattrinato che, dopo essersi redento dal suo turbolento passato molto difficile, si è ricostruito una vita, sposando la fedelissima moglie Rose (Davis), casalinga che provvede a servirlo e riverirlo, a preparargli la cena e che, come ogni donna nera dell’epoca, doviziosamente si occupa diligente delle faccende domestiche. Lava, stira e rassetta la modesta casa in cui assieme a Troy vive amorosamente fra mille precarietà economiche. I due hanno un figlio adolescente Cory (Jovan Adepo). E Troy, dalla sua relazione precedente, ha avuto anche Lyons (Russell Hornsby), musicista disoccupato che abita per conto suo ma che, talvolta, torna a far visita a suo padre, soprattutto per chiedergli soldi e poter così soddisfare le sue velleitarie, forse utopiche ambizioni artistiche.
Troy ha pure un fratello menomato e cerebroleso, reso tale per colpa di un esplosivo che, in guerra, gli ha danneggiato il cervello, Gabriel, affettuosamente ribattezzato Gabe (Mykelti Williamson). Gabe è matto, indifeso e Troy compassionevolmente e per puro amore fraterno tenta di proteggerlo come può per salvarlo dalle crudeltà e dalle insidie di un cinico mondo bastardo.
Troy ha infine un amico per la pelle, il suo collega di lavoro Jim Bono. Peraltro suo ex compagno di prigionia, (Stephen McKinley Henderson), un vecchio bianco omaccione che, quando Troy era carcerato, l’ha instradato alla retta via, aiutandolo moralmente a risollevarsi. Un inseparabile amico verso il quale Troy si sente profondamente riconoscente. E con cui beve appassionatamente come una spugna, affogando nell’alcol le delusioni di tutta una vita trascorsa nel rimpianto di essere stato una grande promessa del baseball estromessa dai giochi vincenti per colpa dell’incallito, ostracizzante, inestirpabile razzismo della gente bianca e a causa forse della sua vera mancanza di talento. Una vita anonima e modesta quella di Troy, da duro lavoratore che, per mantenere quel poco ch’è riuscito a conquistarsi col sudore e la fatica, dal lunedì al venerdì è costretto a svegliarsi all’alba e a sporcarsi le mani in mezzo all’olezzante, becera spazzatura.
Una vita di anomie e di certezze fallaci e bilicanti. Ma per Troy arroccarsi nella sua ferrea, disciplinata, ristretta e soffocante, angusta visione del mondo, è forse l’unica, seppur sdrucciolevole e illusoria convinzione vitale per cui riesce a dare un senso alla sua opaca esistenza da perenne emarginato e vinto. Un volitivo, triste eppur combattivo uomo affranto dalle troppe disillusioni che, tenacemente, lotta nella sua anima tormentata da resiliente caparbiamente testardo al fine, nobile quanto sciocco, di non voler sconfiggere almeno il suo intimo amor proprio. Troy, un superbo fallito cialtrone e ciarliero che cela le sue amarezze dietro una sbruffona maschera da cafone pagliaccesco. E copre le sue inesauste lacrime nella facciata di sfacciate, buffe, spericolate euforie en passant.
E sta educando il piccolo Cory alla rigida osservanza di precetti quasi militareschi da padre-padrone gerarca, preoccupato com’è che il figlio, troppo sognatore, possa venir spietatamente deluso da quei bianchi che lui odia e verso i quali nutre un inguaribile rancore atavico.
Ed ecco dunque il significato del film, quel recinto ideologico simboleggiato dalle pale di legno del cortile eretto da Troy, la figurativa palizzata dietro cui Troy si nasconde per paura di essere di nuovo infranto nell’onore e calpestato nell’orticello della sua anima. Impaurito da quella torva signora di nome Morte.
Troy, un’anima nera, assediata da continui demoni interiori che annega nell’alcolismo, nelle risate goliardiche, nelle pose clownesche da attore di una pantomima esistenziale, di una resistenza emotiva destinata, prima o poi, a franare dinanzi alla crudezza potente di una vita che non dà scampo e ti prosciuga, spezza ogni tua residua e chimerica, vana speranza, lasciandoti tramortito, sconfinatamente solo e incupito, ti spella vivo con addosso soltanto l’ombra mortifera del tuo ombroso spaventapasseri perduto, rattrappito nel tuo sdrucito, burlesco fantasma ridicolo.
Barriere è un film bellissimo. Nonostante la sua vertiginosa ma sopportabile caduta di ritmo dell’ultima mezz’ora. In cui diventa prolisso e forse esageratamente verboso. Eppur si risolleva in un finale magico e incantato.
Un film blues. Dal pacato andamento soporifero nel quale Washington, fra monologhi strepitosi e il suo magnetico volto commovente, patetico e poi al solito carismatico, istrionico volteggia straordinario, alternando momenti di solitaria disperazione infinita ad altri in cui, spassosamente, ride delle sue continue disgrazie e, nell’aneddotica delle sue tante storie ripescate dalle tenebre di un personale passato violento, instilla visceralmente al suo Troy un’aura magnificamente romantica da eterno loser dal cuore sgretolato ma giammai arresosi.
Washington, nella sua terza prova da regista, è ben conscio di girare l’adattamento teatrale di una pièce tanto famosa e la sua messa in scena, austera, rigorosissima, è quella di un regista che non vuole strafare affatto con svolazzi e iperboli stilistiche, il suo è l’ammirevole sguardo neorealistico, antico e rustico di uno che gira un onesto kammerspiel ove la macchina da presa, fermissima, si sposta lenta fra pochi, piccoli ambienti, fra interni ed esterni che si ripetono come su un palcoscenico ravvivato e carnalmente insanguinato dalle sue vivissime, funeree, umanissime facce di uomini e donne appartenenti a un mondo lontano, tanto lontano e profondo che ci pare cristallinamente toccante, emozionante, amabile, nostalgicamente importantissimo e prezioso.
Quanto mai dimenticato, eternamente, invincibilmente presente.
Barriere è forse il film più sottovalutato, almeno dalla Critica nostrana, degli ultimi dieci anni.
Signore e signori, Denzel Washington.
Battuto come Best Actor per un soffio da Casey Affleck di Manchester by the Sea agli Oscar.
Peccato. Barriere è il suo film, Barriere è un film da lui molto sentito, l’interpretazione per cui giustamente doveva diventare l’unico attore nero ad aver vinto due Academy Award come protagonista, oltre ovviamente a quello come best supporting actor per Glory.
Ciò non è avvenuto.
Sarà per la prossima volta, mitico Denzel.
Barriere, non un capolavoro ma un grande film che è stato molto apprezzato negli Stati Uniti, come infatti attestato dalle varie candidature agli Oscar e dai voti assai alti della Critica ma che, ahinoi, in Italia è stato preso molto sotto gamba.
Tant’è che Laura e Luisa Morandini, pigliando una cantonata colossale, e non sono loro due, l’hanno platealmente snobbato, limitandosi a questa definizione limitatissima: è proprio l’impianto teatrale che rende difficile la prolissa trasposizione su grande schermo fatta da Washington che parla troppo, dicendo poco, si dilunga in scene estenuanti che sembrano non finire mai, è troppo programmatico nel “messaggio” antirazzista.
Ahia, care Laura e Luisa, dovevate stare più attente.
di Stefano Falotico