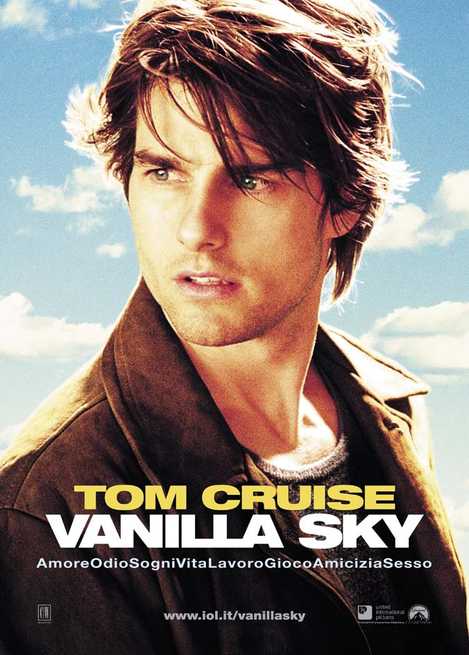JFK – Un caso ancora aperto, recensione


JFK, Kevin Costner, 1991

JFK, Joe Pesci, 1991, (c)Warner Bros

JFK, Director Oliver Stone, 1991. (c) Warner Bros


JFK, Kevin Bacon, 1991
Ebbene, oggi per il nostro consueto, ci auguriamo, apprezzato appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo JFK, sottotitolato, qui da noi, Un caso ancora aperto, opus mastodontico, spropositatamente lungo, fascinoso eppur forse irrisolto, non irrisorio, anzi, notevole ma non privo di notevoli pecche, firmato da Oliver Stone (Nixon – Gli intrighi del potere).
Pellicola, come appena dettovi, della durata assai considerevole, per l’esattezza constante di 189’, per quanto concernette o, se preferite, concernente, la versione per le sale cinematografiche, espansa addirittura a 206 minuti in director’s cut, quest’ultima disponibile esclusivamente in home video, tratta da un soggetto di Jim Garrison (il protagonista della vicenda narrataci, autore di Sulle tracce degli assassini) e di Jim Marrs, scrittore di Fuoco incrociato: Il complotto che ha ucciso Kennedy, sceneggiata, come consuetudine, dallo stesso Oliver Stone in collaborazione con Zachary Sklar, candidata a otto premi Oscar, fra cui quello, giustappunto, per il miglior adattamento, cioè per la migliore sceneggiatura non originale e per Miglior Film e Migliore Regia (Stone, quindi, non aggiudicandosi l’Academy Award, non raggiunse il terzetto di vittorie come director dopo il bis ottenuto per Platoon & Nato il quattro luglio), ne vinse solamente due, andati precisamente per la miglior fotografia, a cura di Robert Richardson (Casinò, Django Unchained), e per il miglior montaggio di Joe Hutshing e del nostro Pietro Scalia (Black Hawk Down).
Monumentale, impegnatissimo, adrenalinico e appassionante dal primo all’ultimo minuto, malgrado il suo taglio decisamente processuale apparentemente tedioso e sfiancante, finanche insistito compiaciutamente, non scevro altresì di forti cadute di tono non trascurabili e di momenti inevitabilmente prolissi e troppo didascalici, superflui e pedantemente cronachistici, JFK rimane, a prescindere dai suoi enunciativi e rimarchevoli difetti che, più avanti, maggiormente esporremo nei dettagli, a distanza di circa trent’anni dalla sua release, avvenuta a livello internazionale nel ’91, una pietra miliare del cosiddetto Cinema di denuncia e, a nostro avviso, una delle migliori opere di Oliver Stone. In quanto, a differenza di altre pellicole di Stone, probabilmente troppo pompose, filo patriottiche e scandalisticamente sensazionalistiche, pesantemente retoriche oltre la soglia dell’umana sopportabilità, sebbene qui la retorica, spesso e volentieri, parimenti esondi abbondantemente, non risulta mai veramente disturbante o stucchevole. In quanto, potremmo definire JFK una sorta di legal thriller del grande schermo, à la John Grisham in formato settima arte raffinata, sui generis d’alta scuola cineastica la cui forza emozionale consiste, principalmente, nell’essere volutamente enfatico, rabbiosamente declamatorio e polemicamente arrabbiato contro il sistema, non solo giudiziario, americano. Perciò, qui la proverbiale, spesso indigeribile retorica di Stone, ben s’appaia e non stona rispetto alla tematica da lui con cura delicata e tatto sofisticato eviscerata, maneggiata con sobrietà, perfettamente equilibrata rispetto alla potente, perfino struggente scabrosità dei fatti vergognosi da lui (d)enunciati a viva voce e con dura, corposa posizione ferrea, non rivelandosi eticamente falsa o moralistica.
Laddove, dapprima, Stone fu perennemente ambiguo e non pienamente credibile, qui invece trova la giusta amalgama, ben dosando e bilanciando i piani narrativi del racconto e della messa in scena, raccontandoci un sensazionale caso celeberrimo, ovvero quello riguardante l’uccisione di John Fitzgerald Kennedy, episodio mai davvero, neppure a tutt’oggi, appurato nei suoi moventi e in merito ai veri colpevoli complottistici dell’assassinio avvenutogli e torbidamente perpetratogli, dirigendo un film ideologicamente sincero e rigorosamente severo, radicale ed estremo.
Trama: Dopo i bei titoli di testa in B/N, nell’incipit glaciale ma toccante, assistiamo a ciò che accade, immediatamente dopo l’omicidio ai danni di John F. Kennedy, in quel di New Orleans, ove agisce il puntuale procuratore distrettuale Jim Garrison (un Kevin Costner legnoso ma bravo, con la sordina e leggermente brizzolato per invecchiarlo un po’).
Poche ore susseguenti al fattaccio, viene incriminato e arrestato Lee Harvey Oswald (un magnifico, inquietante Gary Oldman), ritenuto il responsabile del reato in questione, cioè l’unico cecchino che, secondo l’FBI, avrebbe sparato a Kennedy, appostatosi a una finestra affacciante sulle strade del corteo di Dallas del 22 novembre del 1963.
Oswald è invero un facile capro espiatorio?
Dopo i primi, burocratici e inconcludenti interrogatori, il caso viene archiviato… soltanto tre anni dopo, Garrison tornerà, in maniera assai scomoda e molto rischiosa, sul “luogo del delitto”, intraprendendo una personalissima, forse giustissima, indagine in cerca della verità, un viaggio nelle tenebre giudiziarie che, in gran parte, però non completamente, smaschererà un complotto di proporzioni ciclopiche e aberranti, ovvero una macchinazione che coinvolse non solamente i poteri forti, gli occulti apparati del sistema e la CIA, bensì persone all’apparenza insospettabili che celarono tantissimi oscuri scheletri nell’armadio veramente raccapriccianti.
In un cast strepitosamente corale ed eterogeneo, infinito come non mai, in cui svetta, diciamo capeggia e primeggia la figura importante e statuaria, incorruttibile di Garrison/Costner, sfila egregiamente un impeccabile e straordinario, irripetibile, esaltante parterre di nomi hollywoodiani da leccarsi i baffi. Nomi altisonanti fra cui uno smagliante Joe Pesci col parrucchino, il quale gigioneggia a briglia sciolta da mattatore indomabile, un eccellente Tommy Lee Jones, nominato all’Oscar come miglior attore non protagonista, un mellifluo e impagabile Donald Sutherland in un ruolo luciferino ma cruciale, Vincent D’Onofrio, Michael Rooker (Henry: Pioggia di sangue, Cliffhanger), Pruitt Taylor Vince (Identity), Jack Lemmon e Walter Matthau, qui in nessuna scena assieme, a differenza della loro celeberrima strana coppia di “svitati imbranati”, John Candy, Sissy Spacek, Frank Whaley (accreditato solo nella versione estesa), Laurie Metcalf, Kevin Bacon, Tomas Milian e, fra gli altri, anche il vero Jim Garrison in un istantaneo ruolo da comparsa.
Fotografia eccelsa e musiche di John Williams per un film titanico, seppur a tratti soporifero, soprattutto nella parte centrale che assomiglia, tranne nel segmento finale, a un giallo-detection ove Garrison, in stile ante litteram alla Eliot Ness di The Untouchables, più che apparirci come un procuratore, pare un leguleio con l’anima pura dell’investigatore privato inarrendevole e dalla stoica, coriacea morale integerrima da indagatore dei tetri e lerci imbrogli di un viscido e capzioso sistema intero che, per ammazzare Kennedy, citando testualmente le lapidarie ed emblematiche frasi pronunciategli dal messianico uomo “deus ex machina” incarnato da Sutherland, ovvero il personaggio innominato, denominato Mister X, agì a compartimenti stagni.
JFK è uno dei migliori film di Oliver Stone perché, a dispetto delle sdolcinate e forse non riuscite parentesi intimistiche legate ai duetti e ai litigi furiosi eppur amorevoli, fra Garrison/Costner e sua moglie Liz/Spacek, ruffiani e troppo accondiscendenti nei riguardi dell’ipocrita, conservatrice etica domestico-famigliare, nonostante non poco inceda ad elevare Kennedy a santino agiografico, descrivendocelo infatti unicamente come un rivoluzionario paladino pacifista e dedito ai diritti dei neri, malgrado il suo impianto prettamente documentaristico, come da noi evidenziato all’inizio, è teso e incalzante, sostenuto robustamente da una mano registica inappuntabile che sa donarvi grintoso ritmo indiscutibile.

JFK, Sissy Spacek, Kevin Costner, 1991





di Stefano Falotico
SAVAGE SALVATION (aka Wah Me in the River), Trailer
 Sheriff Church (Robert De Niro) and Detective Zeppelin strive to keep the peace in their rough town, where residents’ only two interests are the church or oxycodone. Newly engaged Shelby John (Jack Huston) and Ruby Red want a fresh start. They decide to have a family together and get clean, with the support of Peter, Ruby’s brother-in-law (John Malkovich). However, Shelby discovers his beloved Ruby dead on their porch before she could fulfill her final wish: to be baptized in the river and washed away from her past sins. Filled with fiery rage, Shelby embarks on a vengeful killing spree to right all the wrong done to Ruby by every link in the drug dealing chain. Armed with nothing but adrenaline and a nail gun, Shelby picks off dealers and junkies one by one until he gets to the top. Sheriff Church and Detective Zeppelin must race against the clock to put an end to Shelby’s vigilante justice before his fight with the crime lord Coyote (Quavo) turns the entire town into a bloodbath. CAST: Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald and Quavo DIRECTOR: Randall Emmett WRITER: Adam Taylor Barker, Chris Sivertson
Sheriff Church (Robert De Niro) and Detective Zeppelin strive to keep the peace in their rough town, where residents’ only two interests are the church or oxycodone. Newly engaged Shelby John (Jack Huston) and Ruby Red want a fresh start. They decide to have a family together and get clean, with the support of Peter, Ruby’s brother-in-law (John Malkovich). However, Shelby discovers his beloved Ruby dead on their porch before she could fulfill her final wish: to be baptized in the river and washed away from her past sins. Filled with fiery rage, Shelby embarks on a vengeful killing spree to right all the wrong done to Ruby by every link in the drug dealing chain. Armed with nothing but adrenaline and a nail gun, Shelby picks off dealers and junkies one by one until he gets to the top. Sheriff Church and Detective Zeppelin must race against the clock to put an end to Shelby’s vigilante justice before his fight with the crime lord Coyote (Quavo) turns the entire town into a bloodbath. CAST: Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald and Quavo DIRECTOR: Randall Emmett WRITER: Adam Taylor Barker, Chris Sivertson
HALLOWEEN KILLS, recensione

Velocissimamente, recensiamo il secondo capitolo della saga di David Gordon Green. Di cui, negli scorsi giorni, disaminammo approfonditamente l’ultimo chapter, chissà se poi veramente definitivo, ovvero l’ampiamente sottovalutato, invero nient’affatto disdicevole, anzi, a nostro avviso assai interessante e notevole, Halloween Ends, episodio conclusivo, naturalmente, dei sequel del capostipite di tale riesumazione, potremmo dire, greeniana dell’originario capolavoro carpenteriano, sì, firmato nel ‘78, ovviamente, da John Carpenter. Che di tale operazione n’è patrocinatore assoluto e fiero fautore, secondo noi, a ragion veduta, come si suol dire. In quanto, Gordon Green non è l’ultimo venuto ed è un regista brillantissimo, sperimentatore nato e uomo colto assai raffinato, in grado tranquillamente di spaziare in ogni genere, districandosene con impari stile amabile e perfino originale. Originale lo è anche in tal caso, anche in occasione, giustappunto, di questo suo aver ridato vita a The Shape, alias boogeyman par excellence del Cinema horror più slasher, cioè Michael Myers. Inutile e pleonastico specificarlo ma ci pare d’uopo, comunque, chiaramente enunciarlo. Simbolizzazione del male per antonomasia, dotato di ancestrali poteri semi-sovrannaturali dei più invincibili, paurosamente incredibili, finanche talvolta grottescamente ridicoli e realisticamente impossibili, Myers è altresì l’esemplificazione ed emblema apoteotico, crudelissimo, superlativo, del babau durissimo a morire, rinascente lui stesso dalle apparentemente sepolcrali ceneri del suo aver arso vivo la sua esistenza già a sei anni quando assassinò, efferatamente, (in)consciamente, sua sorella e il suo ragazzo nella sua abitazione e dimora oramai divenuta un’haunted house fantasmaticamente spettrale, la prigione mnemonica del suo trauma forse neppure tale. Poiché, ribadiamo, Myers non è diventato orrendamente e disgraziatamente, incurabilmente cattivo in seguito, così come di solito avviene per i mostri, a un episodio traumatico patitogli e ingiustamente successogli a causa di eventi funesti e profondamente avversi, in seguito, cioè, a circostanze tristemente negative, bensì per connaturata indole terribilmente maligna, sì, innatamente insita in lui sin dai primordi dei suoi primi, erronei e orrifici battiti vitali e aberranti respiri malvagi e mefitici.
È il male intrinseco, è l’uomo nero delle favole dark infantili perché la strega vien di notte con le scarpe tutte rotte e non ti offre, nel giorno dell’Epifania, bensì della notte di Ognissanti, una calza nylon da sensuale figa inaudita, non ti strappa le mutande ma il cuore, te lo disossa e ti scarnifica dietro una maschera ove forse si cela un uomo che, nell’animo, è pelle e ossa, cioè scheletrico e arido da far paura, perversamente malato in maniera insanabile, un uomo prosciugato d’ogni amore, un uomo che, nel terzetto dei monsters coi coltelloni, quali Leatherface & Freddy Krueger, fa la sua porca figura e se la batte per il primato del podio del più porco. Del più immoralmente stronzo in modo immortale, sin dal carpenteriano, imitatissimo prototipo.
Myers spalanca le fauci, metaforicamente inghiottendo e deglutendo, no, parlando, dei suoi coltelli affilati, riperpetuando le uccisioni “copia carbone” dell’antesignano masterpiece di John che (in)generò tantissimi seguiti apocrifi e, più o meno riusciti, epigoni e vari episodi… eh già, cari degenerati dei più variegati. Sul canovaccio del primo, qui ritorna Will Patton nei panni dello sceriffo. Che sembrava morto ammazzato e invece è, a quanto pare, vivo e vegeto, assai ferito ma resuscitato.
E le scene che vediamo, di flashback citazionista la notte delle streghe di Carpenter, eh eh, or vi pongo un bel quiz, ignoranti, pressapochisti e/o squallidi neofiti, sono di repertorio o create ex novo con tanto d’aggiunta posticcia d’un Donald Pleasence, in analessi, redivivo?
Fa la new entry, nei panni d’un ex bambino cresciuto e fin troppo pasciuto e corpulento, scampato alla strage originaria di Myers, Anthony Michael Hall e qui nessuno si salva. Forse neppure il film che, se non fosse per la mano svelta e non pochi guizzi visivamente funambolici di Green, cadrebbe a pezzi in maniera insostenibile perché, se Myers, malgrado le picconate e i colpi d’ascia che riceve a man bassa, rimane sempre in piedi, se non è morto bruciato ma s’è salvato per miracolo, la violenza stavolta abbonda in modo compiaciutamente esagerato e ingiustificato.
E il film sbanda, narrativamente sanguina e la pazienza dello spettatore dissangua, terminando con una carneficina spropositata ove la figura imbattibile e, quasi superomistica, in senso raccapricciante, di Myers assume finalmente consistenza e forma paranormale delle più disumane e allucinanti, al contempo granguignolesche e tragiche, quasi ridicole.

di Stefano Falotico
HALLOWEEN di David Gordon Green, recensione


Ebbene, disincagliato da vincoli editoriali allineati a canoni standard, non schiavo di questioni SEO forse limitanti la recensoria, letteraria creatività più libera e sanamente smidollata, no, soltanto smodata, ivi son libero di sguinzagliare il fervore armonico della mia disinibita prosa infuocata, accoltellando, no, riacciuffando, ovvero, dalle memorie ripescando, anzi, sinceramente per la prima volta il sottoscritto vedendo questo film rimastomi dapprima, diciamo, ignoto, e nelle seguenti righe, naturalmente, recensendolo, ve ne parlerò nei tagli da slaher movie, no, solamente nei dettagli, eh eh. M’auguro in modo piacevole per vossignoria che spero possa apprezzare tale mia disanima, in merito, anomala e tale “faloticata” (sì, da falotico, parola che significa fantastico) sesquipedale e intelligentemente spropositata. Sì, vai di modestia, ah ah, inusitata…
David Gordon Green, a mio avviso un genio, un regista stoltamente snobbato dalla presuntuosa intellighenzia faziosa e stupidamente esigente con la puzza sotto il naso. Che, oppure ché, sì, l’ha immeritatamente morsicato e metaforicamente azzannato per il suo bel e coraggioso Halloween Ends.
Opus ultimo della sua altrettanto trilogia stoica, Halloween Ends, che resuscita il carpenteriano capostipite imbattuto e, malgrado il già battuto sentiero di seguiti apocrifi, spesso malriusciti e sovente dimenticabili, gli dona linfa vitale e lo rivitalizza con classe indubbia. Gordon Green, un regista giovane, soprattutto nell’animo, sperimentatore nato e talento adamantino che solo gli idioti ancora disdegnano e, giustappunto, in fretta liquidano a priori. Cannando spaventosamente in maniera più mostruosa del Myers, memorabile babau antieroe di tale saga, ça va sans dire, orrifica delle più immortali come Leatherface di Non aprite quella porta e Freddy Krueger di Nightmare, ih ih.
Mi persi nel labirinto della mia schizofrenia à la Michael Myers, no, persi questo film in sala e, soltanto a visione ultimata di tal appena dettovi Halloween Ends, da me ampiamente apprezzato e già da qualche giorno recensito in modo non superficiale, bensì superbamente sofisticato, recuperai, qualche ora fa (vi debbo dare anche il minuto preciso, ah ah?) il primo episodio di questo splendido franchise greeniano.
Green, regista sensibile, intelligente e colto oltremodo che spazia dal Cinema intimistico e prettamente citazionistico a quello tipicamente più del brivido senza sprezzo del pericolo. In questi giorni, peraltro, ha dato i primi ciak del suo remake dell’Esorcista. Alla faccia…
Halloween del 2018, a omaggio celebrativo del 40° anniversario dall’uscita del capolavoro omonimo e antesignano di John Carpenter. 2018, prima della pandemia, primo film, per l’appunto, di quest’imprevista, geniale e controversa trilogy dai cretini bistrattata, dalle persone accorte e profonde invece ottimamente accolta.
Trama, letteralmente estrapolata da IMDb, sì, cari bimbini col pannolino:
Laurie Strode giunge al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando quarant’anni prima è riuscita a scampare alla spaventosa carneficina messa in atto la notte di Halloween.
È sempre lei, sì, Jamie Lee Curtis, figlia d’arte, figlia di cotanto padre Tony e di Janet Leigh. Esatto, Marion Crane dell’immarcescibile, eternamente “seminale” Psyco hitchcockiano, film padre e pellicola madre forse d’ogni epigono alla Anthony Perkins/Norman Bates. E Myers lo è, eh eh.
Ecco, se oggigiorno Jamie Lee Curtis si spogliasse, a mo’ della Leigh sotto la doccia, non mi ecciterei come Arnold Schwarzenegger dinanzi al suo epico, arrapante spogliarello di True Lies. Sì, oggi Jamie è vecchiotta e onestamente non la scoperei. Tantomeno la sgozzerei. Forse, dello shampoo le offrirei e un tè caldo le verserei, riscaldandola tutta…
Detto questo, cioè tale porcata, passiamo a tale mannaia, no, passiamo ad Allyson/Andi Matichak. Sì, a lei una botta… darei senza se e senza ma. Va fottuta di brutto, forse anche con del burro.
Evviva la sincerità, perdonatemi, moralisti del ca… o, se per tale mie “uscite” voleste sbattermi… in manicomio, posso assicurarvi che tutti gli psichiatri di Bologna che seguirono il mio caso, uh uh, son adesso impazziti e sono attualmente ricoverati a vita presso i maggiori nosocomi per malati di mente, fra cui quello Maggiore… La diagnosi, inconfutabile, effettuata nei loro riguardi è questa: il Falotico è un genius assoluto, s’è bevuto tutte le folli teorie malsane di Freud & Jung soltanto col fascino dei suoi occhi neri, più neri della loro perenne notte nefasta e cupissima.
A parte gli schizz(at)i, no, gli scherzi, procediamo ora con lo “scarabocchiare” tale review, no, andiamo con l’imbrattamento sanguigno. Questo sequel di Green non soffre di nessun complesso di colpa, no, imbruttimento, anzi, abbellisce e riammoderna il lutto delle vittime di Myers, no, restaura il tutto, ridonandogli vigore e forte furore da encomio.
Lo stesso Gordon Green, dopo le critiche impietose e, come poc’anzi scrittovi e riferite, lapidarie e ingrate, avvenute nei confronti del suo ultimo (?) chapter su Myers, così s’è recentissimamente espresso, sue testuali parole:
Quando qualcuno ti offre la possibilità di costruire la casa dei tuoi sogni all’interno di un conglomerato che presenta questo titolo e questi personaggi, cerchi sempre di metterci del tuo ed è quello che io ho fatto. Per ogni critica ricevuta ci sono anche le persone che ti ringraziano per aver portato il franchise in una nuova direzione e averlo mantenuto in vita.
Sì, ringrazio Gordon Green per avermi ricordato di essere io, spesso smemorato, giammai internato, eh eh, l’autore del libro John Carpenter – Prince of Darkness, disponibile in cartaceo e digitale sulle maggiori catene librarie online.
Dopo tale mia rinascenza, no, rimembranza, detta altresì sanissima reminiscenza non illusoria, bensì veritiera, dopo questo mio opportuno tributo “involontario”, rammemor(iam)o il film preso in questione, no, maggiormente nella sua trama lo eviscero e, usando il plurale maiestatico, descriviamolo e brevemente disaminiamolo.
Quarant’anni esatti, posteriori ai macabri avvenimenti luttuosi occorsi in quel dell’immaginaria, cinematograficamente però verissima, Haddonfield, dopo che fu chiamato il pronto soccorso, Myers è recluso nel manicomio criminale di Castiglione delle Stiviere, no, al Smith’.s Grove Sanitarium. Il dottor Loomis, alias Donald Pleasence, è morto e adesso Myers è un paziente curato, per modo di dire, da parte dello psichiatra di nome Ranbir Sartain (Haluk Bilginer). Due giornalisti investigativi, non quelli di Mindhunters, eh eh, bensì Aaron Korey e Dana Haines, incarnati rispettivamente dagli attori Jefferson Hall (antipaticissimo) e Rhian Ress (non bellissima, non una sberla, una passerona e una sventola, come si suol dire, neppure simpaticissima ma carina, insomma una discreta fighettina che va benissimo per una sveltina), vanno a trovare Myers. Che attende, in serata, di essere trasferito in un altro carcere da camic(i)e di forza… Perché non lo sopprimono? A quanto pare, non assume neurolettici né calmanti e/o inibitori della libido, no, psicofarmaci che ne castrino… l’aggressività. Cosicché, sul pullman in cui viene alloggiato, non incontra Nicolas Cage di Con Air (un aeroplano, comunque), eh eh. Al che, assieme all’allegra, invero tristissima, compagnia di suoi “colleghi” affetti da incurabile mental illness, non si reca a Fatima per chiedere il miracolo alla Vergine Maria ma assalisce qualcuno, il quale viene strozzato ma, un attimo prima di crepare, urlò alla Lino Banfi un Madonna dell’Incoroneeeta! (sì, vi giuro su Gesù, la scena suddetta non si vede ma avvenne così, fidatevi, ah ah). Riprecipitiamo nell’incubo. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), l’unica babysitter sopravvissuta alla strage e alla carneficina compiute da Myers, è cambiata, nell’aspetto fisico e interiore, in seguito alle cicatrici emotive subite e per il trauma patito a causa di Myers? Sì, anche se è cambiata fisicamente semplicemente perché prima era la Lee Curtis di Un pesce di nome Wanda (due cosce da paura) e di Una poltrona per due (un seno “tremendous”) e ora è indubbiamente stagionata poiché il tempo passa e dunque non è più la gnocca d’una volta, ah ah.
In compenso, la nipote non è la sua controfigura di Perfect, è bellina ma è ancora acerba e ha da farsi… molti ragazzi ma io le farei da assistente “sociale” non solo in Ognissanti. Cristo santo!
Nick Castle, uno dei pochi actors ad avere una filmografia più limitata dei pochi nanosecondi in cui The Shape, nel film originario di Carpenter, appare in viso, attore che ha pressoché solo lavorato con John, nel porco, no, parchetto del manicomio, viene inquadrato solo di spalle e appare mentalmente messo a pecora più di Luigi Di Maio in questi giorni in cui ha dato le dimissioni da Impegno Civico (presto chiederà il reddito di cittadinanza, ah ah), viene peraltro “doppiato” nelle scene in cui, con tuta da metalmeccanico in cassaintegrazione incazzato a morte, colpisce e accoltella con rabbia da comunista frustrato dinanzi alla vittoria di Giorgia Meloni, forse da Sylvester Stallone coi muscoli di Rambo ibernato alla Demolition Man.
Lo sceriffo della contea non è Brian Dennehy, bensì Will Patton. Uno che, in Mothman Prophecies, era affetto da disturbo delirante paranoide o forse era un genio incompreso e un veggente migliore di chi affermò che, alle scorse italiane elezioni politiche, la Sinistra avrebbe vinto a mani basse, mentre qui apparentemente muore ma poi risorgerà come Rifondazione…
Ora, a parte le cazzate, il film ha dei difetti rimarchevoli ed evidenti. Innanzitutto, dinanzi ai morti trucidati, coloro che assistono ai loro cadaveri e ai loro insanguinati, tumefatti corpi macellati, non rimangono agghiacciati e atterriti ma solo vagamente turbati. Pur rimanendo senza parole, pare che mentalmente pensino e (non) dicano: che culo, non è successo a me. Sì, erano bravi ragazzi ma forse anche no, forse erano degli stronzetti incoscienti e, in fondo, ha fatto bene Myers a eliminarli con un taglio netto prima del futuro loro orribile che avrebbero avuto. Si sarebbero ridotti a riguardare Scary Movie e basta, si sarebbero sposati e, malgrado si fossero giurati amore eterno, nonostante dopo poco dal matrimonio, dopo al massimo una decade, non più si amassero, non avrebbero chiesto il divorzio perché dovevano allev(i)are un figlio ora puberale che non smanetta dinanzi a Carmen Electra ma gioca a far il cyberbullo su YouTube. Prendendo vigliaccamente di mira e per il popò quelli più cazzoni di lui. Per esorcizzare i lor incubi peggiori. In questo film, c’è solo un ragazzo a posto col cervello, il povero “sfigato” che corteggia pateticamente Allyson in quanto era stato alla festa con lei e il suo ex ragazzo, divenuto ex dopo tal festa andata a puttane, surriscaldato dirimpetto a quel giro di gnocche spaventose da lui nemmeno avvicinate, pensò malamente di poter almeno dar lei un bacio ma, oltre a ricevere un devastante due di picche raggelante da quest’ultima, fu presto “inchiappettato” da Myers. Io l’avrei salvato. Sostanzialmente, anziché sdraiarsi a terra come un disgraziato impacciato, incontrando subitaneamente Myers, avrebbe dovuto inseguire Allyson, afferrarla da dietro, al buio, dapprima sussurrarle, alla Travis Bickle/De Niro di Taxi Driver, un secco e potente… lei è come tutti gli altri!, poi accarezzarle il collo e cantarle Love Me Tender alla Sailor/Nic Cage di Cuore selvaggio.
Lei, probabilmente, l’avrebbe coglionato ancora di più o forse, chissà, esterrefatta di fronte a qualcosa di così spiazzante ed eroticamente tanto suadente quanto brillante, gli avrebbe detto, orgogliosa ed eccitata, bagnatissima: – Prima fottiamo Myers, poi scopiamo come Carpenter con Adrienne Barbeau ai tempi di 1997: Fuga da New York. Detto questo, David Gordon Green non è uno spostato, non è sposato, non è gay, a differenza del suo amico Luca Guadagnino, per cui s’è prestato a uno splendido cammeo in Bones and All, non m’interessano i suoi gusti sessuali ma il suo Cinema eccome. È uno con le palle. Non teme di essere accoltellato da spettatori e Critica, nel pre-finale di questo Halloween cita espressamente Il silenzio degli innocenti anche se Laurie Strode non usa gli infrarossi, nemmeno gli occhiali nella cameretta scura, si diverte, sperimenta, sbaglia tantissimo eppur parimenti azzecca delle scene meravigliose, non è lezioso o artefatto, è un regista naturale che non vuole vincere l’Oscar, forse più avanti, può darsi pure che lo vincerà, è del ’75, cioè ne ha ancora di strada da fare, a differenza di molti falliti che, dopo averlo stroncato per Halloween Ends, lo hanno addirittura intimato a suicidarsi.
Per costoro, ignobili impostori, predispongo immantinente un trattamento sanitario obbligatorio.

HALLOWEEN ENDS, recensione



Ebbene, oggi disamineremo, brevemente ma speriamo esaustivamente, Halloween Ends, uscito sui nostri schermi lo scorso 13 Ottobre e ultimo, definitivo capitolo della trilogia inaugurata nel 2018 da David Gordon Green (Joe) che, col suo Halloween e l’immediatamente successivo Halloween Kills, resuscitò dalle ceneri e al contempo rinverdì i fasti del mito orrifico concernenti lo spauracchio e temibile, raccapricciante babau celeberrimo di nome Michael Myers, creatura mostruosamente invincibile creata dalla fantasia del geniale John Carpenter (patrocinatore di questa saga-“reboot” e sequel sui generis rigenerante il nostro aberrante, rivivificato beniamino assai particolare, a suo modo carismaticamente immarcescibile e, in senso tout–court, immortale) nel lontano 1978 col suo eterno capolavoro del brivido e del terrore intitolato, giustappunto, Halloween – La notte delle streghe con protagonista assoluta una giovanissima ed esordiente, perlomeno in un lungometraggio, Jamie Lee Curtis. La quale, naturalmente, ancora una volta, ivi riprende il suo famoso ruolo che la consacrò, quello di Laurie Strode. Sceneggiato dallo stesso Gordon Green assieme ai valenti Paul Brad Logan, Chris Bernier & Danny McBride, della durata corposa, forse leggermente prolissa eppur appassionante, di un’ora e cinquantuno minuti netti, Halloween Ends è stato accolto in maniera controversa e fredda dall’intellighenzia critica, non soddisfacendo i più, rimasti sostanzialmente insoddisfatti per questo film finale su cui, probabilmente, s’aspettavano qualcosa di migliore e maggiormente memorabile. Ora, puntualizzando subito che Halloween Ends non è un capolavoro, infatti, a seguire ne sottolineeremo le pecche e ne rimarcheremo gli evidenti difetti (non molti, però, a esser sinceri), altresì è una pellicola notevole per molteplici aspetti che parimenti evidenzieremo e loderemo ampiamente e senza fronzoli. Dunque, possiamo tranquillamente e subitaneamente affermare fieramente, perfino stoicamente, che siamo assai discordi rispetto agli unanimi giudizi, al momento imperanti e ingrati, impietosi e a nostro avviso troppo severi, espressi generalmente e negativamente in merito a tale ottimo opus di Gordon Green.
Trama: Durante la notte, ovviamente, di Halloween dell’anno 2019, l’inesperto, imbranato, timido adolescente e studente Corey Cunningham (un eccellente e inquietante Rohan Campbell), viene ospitato nella lussuosa magione della ricca ed elegante signora Allen (Candice Rose) e di suo marito (Jack Marshall) per accudire e far da babysitter al loro figlio di nome Jeremy. Quello che per Corey sembrava un lavoretto da soldi facili, purtroppo, rappresenterà invece, paurosamente, l’inizio del suo atroce incubo e del suo calvario esistenziale poiché, a causa d’una amarissima fatalità tragica del destino, in maniera tremendamente involontaria, ucciderà Jeremy. Il quale, giocando a nascondino con Corey, precipiterà, per colpa d’una mossa, potremmo dire, inaspettata di Corey, giù dalla tromba delle scale, schiantandosi sul pavimento e crepando all’istante, affogato e avvolto dal suo macabro lago di sangue funereo. Al che, con una veloce serpentina dell’intreccio e un repentino passo in avanti narrativo, veniamo immersi in quel dell’immaginaria Haddonfield dell’Illinois (inesistente realmente ma vera cinematograficamente, da non confondere con l’omonima e non fittizia Haddonfield del New Jersey), fantasmatica e spettrale, sebbene all’apparenza pacifica e fin troppo morigerata, cittadina d’un plumbeo e misterioso, sepolcrale e mortifero entroterra statunitense languidamente ancestrale, ove, nella sua appartata abitazione, risiede Laurie che sta scrivendo un libro di memorie sugli avvenimenti occorsile, una sorta di biopic psicologico sulle sue esperienze in veste di miracolata sopravvissuta da Michael Myers. Laurie vive in compagnia della nipote Allyson Nelson (l’avvenente Andi Matichak). Quest’ultima, infermiera, al servizio d’un capo dottore bavoso e viscido, s’innamorerà del redivivo Corey e ne sarà presto ricambiata. Adesso, Corey lavora nel cantiere di suo padre con cui vive insieme a sua madre psicolabile e, malgrado fosse stato scagionato da ogni accusa a riguardo del suo omicidio colposo, sì, del suo assassinio accidentale nei confronti del povero Jeremy, è infinitamente e tristemente perseguitato dai suoi demoni interiori e all’unisono stigmatizzato e additato come freak psicopatico dagli abitanti del luogo, perseguitato inoltre e oltremodo da bastardi bulli che, impunemente, lo tormentano nottetempo, insistentemente a getto continuo, appena si presenta loro l’occasione per infamarlo, deriderlo e umiliarlo.
Cosa succederà e come andrà a finire?
Corey, invero chi è? Nasconde una scura ed oscura personalità malvagia ed infida? È il ragazzo innocente e incolpevole che può apparire allo spettatore compassionevole e sensibile oppure il male, propagatogli psicologicamente da un’abietta e miserevole comunità ipocrita, s’è lentamente e irreversibilmente inconsciamente impossessato di lui così tanto da far sì che in lui sia avvenuto un perverso processo d’identificazione in Michael Myers?
Myers, soprattutto, è morto oppure il suo spettro aleggia in maniera mefistofelica e respira, sinuosamente minaccioso, nella tetraggine infernale delle fogne periferiche più lerce e diaboliche?
Teso, perfino emozionalmente romantico e poi mellifluo, nient’affatto banale, specialmente nella prima ora, bellissima e spiazzante, con atmosfere notturne degne di nota e una superba fotografia chiaroscurale di Michael Simmonds, con una Lee Curtis invecchiata ma magnetica e un Campbell straordinario nei suoi inaspettati cambi di registro recitativo da un momento all’altro, Halloween Ends non è assolutamente deludente. Anzi, tutt’altro, avvince spesso e per certi versi è stupefacente. Spaventa e incanta, gioca su sottili ambiguità sofisticate e risulta, a tratti, addirittura una notevole e non convenzionale, standardizzata riflessione sul male, perdonate il gioco di parole, niente male.
Gordon Green oramai conosce benissimo i tempi thrilling e anche quelli sentimentali, se ne sa destreggiare con abilità e quel sapido mestiere sanamente “furbo” da regista esperto ed egregio.
Forse, Halloween Ends esagera nel finale, divenendo dozzinale e mancando di pathos, scegliendo la strada più comoda, scioccamente splatter e slasher in modo sciattamente truculento in modo poco fine, arrivando alle soluzioni più scontate, ribaltando e rinnegando dunque gli ottimi presupposti iniziali che erano, come detto, più intelligentemente impregnati di complessità.
Nel cast, ancora una volta un bravo e commovente Will Patton (The Mothman Prophecies) nei panni di Frank Hawkins, inarrendevole, attempato corteggiatore, un po’ patetico un po’ troppo sanamente umano, di Laurie/Lee Curtis.
di Stefano Falotico
LINEA MORTALE, recensione



Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento con la rubrica Racconti di Cinema, disamineremo Linea mortale (Flatliners), opus del 1990 firmata dal compianto Joel Schumacher (8mm- Delitto a luci rosse, Ragazzi perduti). Film della durata consistente, avvincente, sebbene altalenante, ammaliante e al contempo non esente da marcati difetti rilevanti, Linea mortale, a prescindere dal fatto, alquanto evidente e insindacabile, che non è di certo un capolavoro, altresì non è tantomeno una pellicola perfettamente compiuta e nella sua interezza impeccabile, può essere però tranquillamente annoverata e reputata una delle migliori opere di Schumacher e, a tutt’oggi, cioè a distanza di oltre un trentennio dalla sua uscita e distribuzione nelle sale cinematografiche, mantiene intatta, immutabilmente inscalfibile, la nomea, meritata, di cult movie generazione piuttosto indiscutibile e inossidabile. In quanto, al di là delle sue pecche, da noi prossimamente enunciate, e d’alcune vistose, ingenue grossolanità, a dispetto della sua hollywoodiana convenzionalità, tipica, negativamente, del Cinema mainstream degli anni novanta, Linea mortale possiede ed emana un fascino tutto suo che è impossibile negare. Da un’intrigante sceneggiatura originale, a suo modo geniale, di Peter Filardi (writer di grandi speranze, dotato d’acume e idee brillanti, poi inspiegabilmente scomparso quasi nel nulla di punto in bianco), Linea mortale fu principalmente prodotto nientepopodimeno che da Michael Douglas, il quale raramente ha sbagliato nel corso della sua carriera, parallela a quella di stimato attore, come lungimirante producer dall’ottimo fiuto e splendide intuizioni finanziarie, malgrado in quest’ultimo campo si sia cimentato poche volte, tutte però, ribadiamo, azzeccate. Basti pensare a Qualcuno volò sul nido del cuculo che gli fruttò l’Oscar, giustappunto come produttore nel lontano ‘75, prima di quello da lui successivamente vinto, come interprete, per Wall Street, oppure allo strepitoso Face/Off, da lui fortemente patrocinato.
Saremmo però inclementi se trascurassimo e ivi non citassimo, doverosamente, anche Scott Rudin, altro primario artefice produttivo di Linea mortale. Specificato opportunamente ciò, passiamo or alla trama, da noi qui assai sintetizzatavi per non rovinarvene le sorprese nel caso apparteneste a coloro che non hanno mai visto tale film: un gruppo di ambiziosi e incoscienti, forse semplicemente coraggiosi, studenti di Medicina, capitanati da un Viktor Frankenstein ante litteram, ovvero Nelson Wright (incarnato da un Kiefer Sutherland carismatico, doppiato da Francesco Pannofino), decidono di sfidare la morte, lanciandosi impavidamente in un esperimento rivoluzionario non poco rischioso che consiste nell’assumere sostanze letali, lentamente morendo e poi, grazie a sofisticate apparecchiature d’avanguardia, rinascendo quasi miracolosamente al fine di poter comunicarsi reciprocamente le rispettive esperienze post mortem. L’esperimento funzionerà, cosicché qualcuno vorrà andare oltre, non solo nell’aldilà… Vale a dire che l’indotta morte diverrà una scommessa fatale e forse non molto morale. Sì, eticamente lapidaria…
Funzionale e curata, seppur leziosa e patinata, fotografia suggestiva di Jan de Bont (esatto, il futuro regista di Speed e il cinematographer di Basic Instinct), una buona compagine di giovani attori affiatati, in gran sintonia recitativa, fra cui una fascinosa e fulgida Julia Roberts nel suo primo film immediatamente successivo a Pretty Woman, William Baldwin, Kimberly Scott, Kevin Bacon e Oliver Platt per un film, come sopra dettovi, irrisolto, superficiale in molti sui punti eppur godibilmente eccentrico, ricolmo di sussultanti, sfaccettate e maestose trovate architettateci e congegnate con insolita maestria da parte d’uno Schumacher sorprendente il quale però, pur inoltrandosi con ammirabile ingegno in territori metafisici e ancestrali assai stimolanti, non approfondisce sufficientemente la materia narrataci e visivamente da lui visionariamente mostrataci con indubbi, bei guizzi pindarici dalla notevole tecnica, affogando e approdando, retoricamente e in modo semplicistico, in un finale dolciastro e furbetto, molto fastidioso e indigesto. Musiche di James Newton Howard. Ne è stato realizzato, nel 2017, uno scialbo remake dall’omonimo titolo (da noi, per differenziarlo dall’originale, reso in Flatliners – Linea mortale) per la regia di Niels Arden Oplev con lo stesso Sutherland in un ruolo minore ma centrale.


FLATLINERS, Julia Roberts, 1990

FLATLINERS, Julia Roberts, William Baldwin, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Kevin Bacon, 1990, (c)Columbia Pictures

FLATLINERS, William Baldwin, Julia Roberts, 1990, (c)Columbia Pictures
di Stefano Falotico
POLTERGEIST – Demoniache presenze, recensione


Ebbene oggi, in concomitanza con la pregiata uscita in Blu–ray 4K dell’imperdibile e intramontabile cult assoluto Poltergeist, sottotitolato per il mercato italiano con demoniache presenze, giustappunto, lo disamineremo dettagliatamente.
Opus rilevante di Tobe Hooper (Non aprite quella porta), della durata consistente di un’ora e cinquantaquattro minuti, all’epoca vietata ai minori di 14 anni, sceneggiata da Mark Victor & Michael Grais, soprattutto da Steven Spielberg, principale suo fautore e finanziatore primario.
Secondo la concisa, stavolta pertinente, sinossi estratta e trascrittavi ivi letteralmente da IMDb:
Carol Anne, la più piccola dei bambini Freeling, sembra entrare in contatto con degli esseri di un altro piano dimensionale attraverso una frequenza televisiva. Presto queste presenze inizieranno a manifestarsi in maniera più evidente, terrorizzando la famiglia.
Carol Anne è interpretata dalla giovanissima Heather O’Rourke (come sappiamo, morta nell’88) mentre il pater familias, anzi, il capo famiglia è incarnato nientepopodimeno che dal grande Craig T. Nelson (L’avvocato del diavolo). Sua moglie, Diane, è invece JoBeth Williams. Entrambi straordinari.
Secondo le testuali parole, sotto riportatevi, del valido, sebben un po’ vetusto dizionario dei film Morandini che gli assegna due stellette e mezza su cinque, riaccennandovene la trama, questo il suo giudizio che ci trova sostanzialmente concordi: In casa di una famiglia di Cueste Verde (Arizona) arrivano, passando per il televisore, spiriti aggressivi, provenienti dal cimitero demolito per costruire il quartiere. Macchina della paura con lo zampino di S. Spielberg, produttore e sceneggiatore: se era un bisbiglio, questo è un urlo. I brividi sono disposti in scala crescente, ma l’ultima fase, la più catastrofica, non è la migliore.
Poltergeist di Tobe Hooper, senz’ombra di dubbio, rivisto e quindi rivalutato oggi più oculatamente, al di là del clamore che suscitò e del suo intatto, indiscutibile fascino e del suo forte valore “seminale”, inteso ovviamente in senso cinematografico per come ingenerò innumerevoli, più o meno riusciti (non è questa la sede per parlarne in modo approfondito e specifico) epigoni e film similari dalle tematiche analoghe, è una pellicola forse troppo lunga e spesso soporifera, tranne naturalmente nei momenti di massima tensione e in quelli immediatamente antecedenti ad essi nel divampare, a carburazione lenta e ottimamente calibrata, della suspense vibrante. Un film ove l’influsso spielberghiano è onnipresente e si avverte marcatamente dal primo all’ultimo minuto, inappellabilmente. Tant’è vero che circola ancora la voce secondo la quale Spielberg avrebbe diretto molte scene al posto dello stesso Hooper, non accreditandosene come regista ma comparendo, come sopra ben dettovi, solamente annoverato come screenwriter e producer. Diceria maligna però mai veramente acclarata, perciò risibile e assai falsa.
Poltergeist s’avvale d’una straordinaria fotografia chiaroscurale e d’atmosfera, firmata da un Matthew F. Leonetti molto ispirato e funziona egregiamente in alcune circostanze e meno in altre, viaggiando cioè a fasi alterne e perdendosi in un ritmo traballante e altalenante. In alcuni frangenti, effettivamente inquieta e perturba, angoscia e lascia perfino atterriti, specialmente ipnotizza per lo strepitoso utilizzo degli effetti speciali, a volte volutamente artigianali e rozzi eppur allo stesso tempo assai efficaci, distillati con misura e congegnati con bravura, e per la superba capacità di Hooper nel saperci trasmettere ansia e palpabile terrore pur girando quasi esclusivamente in spazi prevalentemente chiusi e soffocanti, claustrofobicamente morbosi. Sovente, però, pare non saper scegliere quale strada precisa imboccare, se quella del fine thriller psicologico o quella dell’horror perfino truculento, smarrendosi fra parentesi talvolta dozzinali, sciatte e banali, poi rispiccando il volo con alcune trovate geniali e stilisticamente feroci.
Indimenticabile Beatrice Straight nei panni della dottoressa Lesh, “medium” sui generis e “psicologa” dell’occulto e dei fenomeni paranormali. Azzeccate, sebbene non eccelse, musiche di Jerry Goldsmith (Spiriti nelle tenebre).




di Stefano Falotico
RAGAZZI PERDUTI (The Lost Boys), recensione
Ebbene oggi, in occasione della sua uscita in Blu-ray 4K per il mercato italiano, disamineremo Ragazzi perduti (The Lost Boys), pellicola dell’87 diretta dal compianto e controverso, altalenante Joel Schumacher (Un giorno di ordinaria follia, 8mm – Delitto a luci rosse).

Ragazzi perduti, un po’ inaspettatamente, considerando il basso budget impiegatovi per realizzarlo, ai tempi della sua uscita nelle sale cinematografiche, riscosse un considerevole successo, velocemente ascendendo, peraltro, a cult movie generazionale. Aggiungiamo, però noi, leggermente immeritato. In quanto, a prescindere dalla lusinghiera media recensoria che a tutt’oggi viene riportata sul sito aggregatore metacritic.com (equivalente al 63% di opinioni favorevoli) e a dispetto delle ragioni affettive che se ne possano nutrire in merito, legate principalmente al fatto che, per molti ragazzi, appena imberbi e pubescenti che lo videro e amarono quando, giustappunto, fu distribuito, può rappresentare un bel ricordo adolescenziale, Ragazzi perduti non è oggettivamente, rivisto col senno di poi e giudicato obiettivamente, un granché. Per tale nostra affermazione, abbastanza apodittica e assai sincera, non ce ne vogliano i suoi fan ancora numerosi e agguerriti…
Film della snella durata di un’ora e trentasette minuti netti, sceneggiato da Jeffrey Boam (La zona morta, Salto nel buio, Indiana Jones e l’ultima crociata) in collaborazione con Jan Fischer & James Jeremias, autori del soggetto, Ragazzi perduti è un horror decisamente atipico, strampalato e, a suo modo, terribilmente originale, con molti elementi grotteschi e perfino farseschi da commedia degli anni ottanta.
Trama:
Lucy Emerson (Dianne Wiest, Il corriere – The Mule), disoccupata, si trasferisce a Santa Carla, amena cittadina della California, assieme ai due figli, il minore Sam (Corey Haim) e il più grande Michael (Jason Patric, Sleepers). In questo posto, all’apparenza innocuo e balneare, una strana congrega di adolescenti vampiri punk, diciamo, caratterialmente variopinti e dalle abitudini non poco particolari, adoratori di Jim Morrison e dei rituali più eccentrici e balzani, capeggiati dal sinistro, luciferino e perfino pacchiano David (Kiefer Sutherland), sconvolgeranno la normalità della famiglia Emerson, specialmente di Michael, nel frattempo innamoratosi della ragazza di David, ovvero la fascinosa e misteriosa Star (Jami Gertz)?
Film d’orrore, come detto, sui generis, con alcune interessanti variazioni sul tema del vampiro che non staremo qui a specificarvi e rivelarvele nel caso foste fra coloro della nuova generazione che non l’hanno mai visto, Ragazzi perduti è un discreto teen movie tipicamente legato agli eighties, cioè agli anni ottanta, con una prima parte intrigante e assai d’atmosfera, lisergico al punto giusto e finanche godibile sul piano dell’intrattenimento più spicciolo, in quanto scorrevole e sanamente sciocco.
Joel Schumacher, inoltre, s’è sempre avvalso di ottimi direttori della fotografia e, infatti, qui è il grande Michael Chapman (Taxi Driver) a regalarci le cose migliori e non pochi squarci visionari del tutto notevoli. Eccellente anche la colonna sonora di Thomas Newman.
Detto ciò, però va altresì ammesso che, come scritto inizialmente, Ragazzi perduti, al di là del suo cast di giovanissime promesse (non mantenute), ai cui nomi già elencati, ovviamente aggiungiamo l’inseparabile ex amico, omonimo e partner dello scomparso Haim, cioè Corey Feldman (I Goonies di Richard Donner, produttore principale di Ragazzi perduti), il quale aveva peraltro già lavorato con Sutherland in Stand by Me – Ricordo di un’estate, in assenza, in tal caso, stranamente di Haim, è un film che appare datato e sopravvalutato, sebbene, ribadiamo, assolutamente guardabile tranquillamente.
di Stefano Falotico