IL BACIO DELLA DONNA RAGNO, recensione



Ebbene oggi, per i nostri racconti di Cinema, a distanza di circa una settimana dalla scomparsa e dipartita di William Hurt, deceduto, ahinoi, nel giorno del 13 Marzo scorso, disamineremo Il bacio della donna ragno. Film per il quale vinse meritatamente l’Oscar in virtù della sua splendida prova recitativa assai intensa e recitata magnificamente. Aggiudicandosi anche il prestigioso premio di miglior interprete maschile al Festival di Cannes. Sconfiggendo, fra gli altri, durante la Notte delle Stelle degli Academy Awards, i ben quotati e parimenti eccezionali Harrison Ford (alla sua prima, storica e stranamente unica nomination della sua stellare carriera) di Witness e il superbo Jack Nicholson de L’onore dei Prizzi. Agguantando inoltre, il primato, potremmo dire epocale e importante, di essere stato il primissimo attore nella storia del Cinema a vincere la succitata statuetta dorata, incarnando il personaggio d’un omosessuale.
Il bacio della donna ragno (Kiss of the Spider Woman) è una pellicola della durata di due ore nette, diretta dal compianto Héctor Babenco (Giocando nei campi del signore), sceneggiata da Leonard Schrader che adattò, molto liberamente, il romanzo omonimo di Manuel Puig, interpretato mirabilmente, come poc’anzi dettovi, da un Hurt ispiratissimo e da un altrettanto sorprendente Raúl Juliá, oltre che da una sensuale, conturbante e avvenente Sônia Braga. Quest’ultima campeggiante, stilizzata e misteriosamente fascinosa, nell’avvolgente poster internazionale a sua volta estremamente seducente e ammantato, diciamo, d’atmosfera caldamente onirica. Enunceremo per voi la trama, estrapolandola dal dizionario Morandini (a cui apporremo, fra parentesi, i nomi degli attori e una nostra precisa osservazione), in quanto, oltre che pertinente, nella sua secca sinteticità sibillina e nel suo corretto giudizio, brevissimo ma centrato appieno e corrispondente in toto con la nostra opinione a riguardo, condensa esattamente il senso dell’opus di Babenco, non sciupandovi, con spoiler inutili, le belle sorprese emozionanti e commoventi che, nell’arco della sua narrazione, sfaccettata e intrecciata meravigliosamente, incontrerete frequentemente, rimanendone estasiati e magnetizzati. Poiché Il bacio della donna ragno, pur essendo oramai un film dell’85, dunque di quasi quarant’anni fa, non è affatto datato, anzi, profuma d’estatica celluloide nostalgicamente stupenda e adamantina nella sua forma più nitida: «In un carcere brasiliano, Molina (Hurt), omosessuale condannato per corruzione di minorenne, è in cella con Valentin (Julia, così accreditato nei titoli di testa, come d’altronde anche la Braga, senza quindi accenti particolari), politico ribelle. Si vorrebbe usare il primo per avere informazioni dal secondo. Intanto gli racconta i film che hanno deliziato la sua giovinezza. Tra i due si produce uno scambio. Il lato debole del film è la visualizzazione dei racconti (con S. Braga); la sua forza nel rapporto tra i due personaggi, nel clima di morbida ambiguità che si crea tra loro, nella valentia dei due interpreti».
Discordiamo però col Morandini in merito al fatto che le suggestive digressioni in cui si visualizzano le scene dei film, in particolar modo di quello centrale, esposteci dal personaggio incarnato da Hurt e rivolte al suo compagno di cella, rappresentino una debolezza strutturale dell’opera da noi qui presa in questione e analisi. Sono invece soavemente delicate e volutamente naïf, cioè ricercatamente artificiose secondo l’accezione migliore. Incantate, deliziose e sanamente “ingenue”, assai poetiche e di finissimo gusto estetico e non solo. La Braga interpreta tre personaggi, Leni Lamaison, ovvero la diva à la Rita Hayworth del film immaginifico, forsanche immaginario, raccontatoci da Molina, Marta, l’amante perduta per sempre e soltanto poi vagheggiata (?) di Valentin, e la donna ragno del titolo. Che altri non è forse se non Marta stessa in versione filmica meta-cinematografica, fantasiosamente idealizzata.
Malgrado qualche eccesso didascalico nell’ultima mezz’ora e alcune forzate, però al contempo inevitabili prevedibilità nello snodarsi del rapporto empatico che pian piano s’innescherà fra Molina e Valentin per via delle loro amicali, intime confidenze personali che a loro volta genereranno nei loro cuori e nelle loro sensibili anime perfino qualcosa in più, Il bacio della donna ragno rimane a nostro avviso un capolavoro. Per certi versi, assai simile e analogamente speculare al celeberrimo La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen. Film che, per pura coincidenza, uscì nello stesso anno.



di Stefano Falotico
MR. BROOKS, recensione
 Ebbene, a distanza di un giorno, ahinoi, dalla triste scomparsa inaspettata del grande William Hurt, celebrato attore premio Oscar (meritatissimo) per Il bacio della donna ragno di Héctor Babenco e protagonista, oltre che di svariate pellicole del suo mentore e fidato amico Lawrence Kasdan (il grande freddo), di Figli di un dio minore, abbiamo pensato bene di ripescare dal cilindro, potremmo dire, della nostra memoria d’incalliti cinefili appassionati e irriducibili, una pellicola con lui, interprete magistrale assieme a un Kevin Costner (qui, anche in veste di produttore in prima linea) in forma smagliante, ovvero Mr. Brooks.
Ebbene, a distanza di un giorno, ahinoi, dalla triste scomparsa inaspettata del grande William Hurt, celebrato attore premio Oscar (meritatissimo) per Il bacio della donna ragno di Héctor Babenco e protagonista, oltre che di svariate pellicole del suo mentore e fidato amico Lawrence Kasdan (il grande freddo), di Figli di un dio minore, abbiamo pensato bene di ripescare dal cilindro, potremmo dire, della nostra memoria d’incalliti cinefili appassionati e irriducibili, una pellicola con lui, interprete magistrale assieme a un Kevin Costner (qui, anche in veste di produttore in prima linea) in forma smagliante, ovvero Mr. Brooks.
Mr. Brooks è un ottimo thriller psicologico del 2007, diretto da Bruce A. Evans. Il quale, inoltre, lo sceneggiò personalmente, unendo le forze con Raynold Gideon.
Evans, regista non particolarmente famoso ma writer di straordinaria classe e finezza di penna (suoi, infatti, gli script del magnifico Starman di John Carpenter e di Stand by Me – Ricordi di un’estate) che vinse, in tal caso, con questa sua pregiata, particolare opus, diciamo, anomala e al contempo assai interessante, ricolma di risvolti tanto inquietanti e morbosi quanto intellettivamente stimolanti e suggestivi, la sua cinematografica scommessa. Dirigendo, giustappunto, tale suo Mr. Brooks con indubbia personalità e da fuoriclasse, infondendogli vita propria ed egregia maestria da puro encomio mirabile.
Detto ciò, Mr. Brooks, film della durata di due ore nette mai annoianti, bensì fascinosamente avvincenti, non è di certo un capolavoro né un grande film ma allo stesso tempo, ribadiamo, è una pellicola importante di cui specialmente il sottoscritto serba una notevole impressione fin dalla sua prima visione avvenuta ai tempi della sua uscita nelle sale.
E rappresenta, ricollegandoci ad Hurt, una tappa significativa all’interno della sua invidiabile carriera e del suo altalenante excursus attoriale d’assoluta rilevanza che però, come sappiamo, dopo il forte exploit degli anni ottanta, per cui annoveriamo fra le sue interpretazioni di rilievo naturalmente Gosford Park, nel corso degli anni subì improvvise e piuttosto inspiegabili battute d’arresto alquanto strane.
Al che, Hurt, dopo esser salito agli onori delle cronache anche, ovviamente, con Dentro la notizia, patì un’estemporanea débâcle e un’assurda, lenta ma progressiva emarginazione dall’Hollywood che, come si suol dire, conta. Pur lavorando a getto continuo, ecco che, nei nineties, Hurt andò irrazionalmente incontro a numerosi fallimenti sonori (pensiamo, per esempio, a Lost in Space) non soltanto per colpa sua, intendiamoci bene, risalendo poi, un po’ tardivamente, soltanto la china in virtù d’alcune sue prove da “caratterista” di risma, quali A.I.- Intelligenza artificiale di Steven Spielberg, Into the Wild di Sean Penn e il sottovalutato, perfino quasi misconosciuto The Good Shepherd – L’ombra del potere di Robert De Niro.
Tornando invece a Mr. Brooks, eccone a grandi linee, per non sciuparvi le sorprese se non l’avete mai visto, la trama, essenzialmente da noi condensatavi sinteticamente ma ritratta nei suoi punti imprescindibili e più salienti, irrinunciabili:
Earl Brooks (Costner) è un uomo di successo, peraltro recentemente insignito di un’onorificenza ragguardevole da uomo dell’anno, sì, una sorta di premio da cittadino onorario, assegnatagli dalla città di Portland. Luogo in cui si svolge la vicenda. Earl, però, non è forse l’uomo moralmente integerrimo e perfetto che potrebbe sembrare. Probabilmente, nasconde una doppia personalità pericolosa che si riflette nel suo immaginario alter ego di nome Marshall (Hurt). Quest’ultimo, suo braccio destro fittizio e “influencer” personale glacialmente speciale dei suoi assassinii da recidivo, giammai curato killer mentalmente non poco disturbato. Al che, accadono agghiaccianti omicidi inspiegati e su di essi comincia a indagarvi una signora molto in gamba, con le palle e bellissima, la detective Tracy Atwood (un’inedita Demi Moore dallo sguardo severo ma sempre avvenente e sexy oltre l’immaginabile). Come andrà a finire? Chi è, in verità, nella sua totale psicologica nudità, il sig. Brooks?
Film dai molti pregi, congegnato narrativamente in modo sofisticato, Mr. Brooks, film costato soltanto venti milioni di dollari, cifra alquanto bassa per gli standard e i consueti, ben più onerosi, budget hollywoodiani, ottenne un discreto successo al botteghino e, pur non sfracellando il box–office internazionale, incassò a livello mondiale circa tre volte di più rispetto ai soldi spesi per realizzarlo. Dunque, può essere tranquillamente considerato un buon successo commerciale.
L’accoglienza della Critica fu alquanto parimenti soddisfacente, sebbene non entusiasmante. E Mr. Brooks, ripetiamo, nonostante non risulti affatto un film indimenticabile o perfetto, si lascia vedere che è una bellezza, soprattutto per merito dei suoi due affiatati e bravissimi protagonisti, Costner & Hurt per l’appunto.
I quali, entrambi giostrandosi eccellentemente fra istrionismi carismatici e giochi recitativi bilanciati, diventano un tutt’uno, in ogni senso, col character principale.
Un’altra superba prova, quindi, per Hurt.
Infine, se volessimo divertirci e riflettere con parallelismi meta-cinematografici, il personaggio di Brooks è accostabile, per via di molte somiglianze, al Tom Stall/Viggo Mortensen di A History of Violence, firmato da David Cronenberg.
In cui Hurt, inutile dirlo ma lo diciamo lo stesso, duettò genialmente nel prefinale con Mortensen, agguantando la sua ultima nomination agli Oscar, stavolta però come best supporting actor.
Un bel film, una grave perdita quella di Hurt. Un grande attore di rara sensibilità e bravura recitativa veramente da fuoriclasse.
Mitico William!

di Stefano Falotico
BULLET TRAIN with BRAD PITT, Trailer
A LUGLIO SOLO AL CINEMA. Bullet Train è un thriller d’azione folle e divertente del regista di Deadpool 2, David Leitch. Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Bullet train, tratto dal romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, da luglio solo al cinema.
IL BACIO DELLA PANTERA, recensione

Ebbene, in occasione della sua pregiata uscita in Blu-ray a colori definiti e accesi, recensiremo per l’occasione Il bacio della pantera (Cat People), ovvero lo scomodo, all’epoca assai osteggiato e non poco, ingiustamente criticato e snobbato film di Paul Schrader, vietato ai minori di anni 14, della durata consistente di un’ora e cinquantotto minuti assai corposi, diciamo visivamente succulenti e non privi, certamente, di materiale trasgressivo e fortemente piccante, eversivo e scandaloso.
Il bacio della pantera, distribuito nelle sale nell’82 è un rifacimento molto sui generis e assolutamente personale, rielaborato in chiave allusivamente molto più morbosamente erotica e a sfondo perversamente incestuoso, al contempo perturbante e fascinoso, della famosa pellicola omonima di Jacques Tourneur del 1942. Concettualmente, come appena sopra dettovi, personalizzata secondo l’ottica e la cinematografica poetica schraderiana. Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver, rinomato regista apprezzato appena reduce da due opere notevolmente dalla Critica stimate, ovvero First Reformed e soprattutto Il collezionista di carte con Oscar Isaac.
Il quale, con tale suo Il bacio della pantera, insospettabilmente prodotto, fra gli altri, da nientepopodimeno che Jerry Bruckheimer, un nome apparentemente agli antipodi e antiteticamente, diametralmente opposto rispetto all’autore de Lo spacciatore e del writer di Toro scatenato, andò incontro a duri giudizi recensori piuttosto impietosi e negativamente lapidari. Oggi come oggi, Il bacio della pantera, che riscontra un’ottima media sul sito aggregatore metacritic.com, equivalente esattamente al 62% di opinioni se non eccelse o grandemente lusinghiere, perlomeno positive, è stato ampiamente rivalutato ma sono in tanti, anche presso l’intellighenzia, a non essere concordi nel giudicarlo una pellicola importante.
Tant’è vero che, così come testualmente peraltro riportato da Wikipedia (da estratto sottostante), questo remake di Schrader, inoltre quasi mai citato dai suoi cultori, estimatori e maggiori aficionado, i quali per l’appunto continuano a reputarlo un film minore all’interno della sua vasta filmografia alta, stratificata, complessa e tematicamente variegata, è tutt’ora visto come un film incapace di poter rivaleggiare, qualitativamente parlando, col capostipite originale:
«Incoraggiata, forse, dal revival del fantahorror classico sancito dal successo commerciale di An American Werewolf in London, la Universal commissiona al regista Paul Schrader l’impegnativo compito di rileggere in chiave contemporanea il celebre The Cat People firmato da Tourneur e sceneggiato da DeWitt Bodeen nel 1942. L’operazione promette bene per il cast impiegato e per il budget consistente, ma l’esito è discutibile. Il film non regge il confronto con la raffinata pellicola che lo ispira: la sceneggiatura di Alan Ormsby – a tratti confusa – aggiunge personaggi superflui senza riuscire a caratterizzarli nello spessore psicologico e, piegandosi gratuitamente alle regole dello spettacolo, punta esplicitamente sull’impostazione erotica e scabrosa. Le interpretazioni non sono impeccabili (ma innegabile è la presenza scenica della Kinski). I meriti principali dell’opera vanno cercati in qualche originale intuizione (in particolare, le scene di apertura e il finale) e nella qualità degli effetti speciali e della fotografia».
Trama, enunciatavi in poche righe esaustive e sintetiche per non rovinarvi, se non l’avete ancora mai visto, le potenti sorprese inquietanti: Irina Gallier (Nastassja Kinski) è una giovanissima, bellissima donna che, all’aeroporto di New Orleans, incontra finalmente e fatalmente suo fratello Paul (Malcolm McDowell). Che non vede da quando ha quattro anni. Irina, avvenente oltre ogni dire ma dalla venustà angelicata emanante infinita dolcezza adamantina profumata di torbida levità suadentemente sensuale, è vergine, sì, illibata. Suo fratello le confida maliziosamente e segretamente che sia lei che lui sono dannati da una macabra e terribile, animalesca, potremmo dire metaforicamente, maledizione ancestrale e arcana delle più bestiali, in senso lato e non. Ovvero, quando s’innamorano, si trasformano in pantere.
Anzi, bando alle sottigliezze romantiche, tale metamorfosi avviene quando, per ragioni primigenie e misteriose, si eccitano a livello puramente, carnalmente sessuale più primordiale e sinceramente umano. Irrefrenabile e incontenibilmente, impulsivamente selvaggio. Anzi, selvatico…
Intanto, una pantera fugge dallo zoo, il cui sovrintendente è l’ambiguo Oliver Yates (John Heard). Irina, attualmente disoccupata, conosce Oliver che la assume, forse infatuandosene…
Il bacio della pantera, rivisto oggi, appare senza dubbio datato e, malgrado le torpide atmosfere di morte mescolate a un tetro, mortifero, spettralmente languido erotismo soffuso di sicuro impatto psico-emotivo, in quanto agisce a livello inconscio, scatenandoci d’istinto delle sensazioni provocanti, lungo la sua lunga durata annoia estenuantemente e risulta estremamente prevedibile in più parti fra di loro scollate e disomogenee, perfino mal dirette e sciattamente orchestrate. Risultando disorganico, premeditatamente orrifico nell’esplosione di scene di violenza gratuita, come nella tremenda, raccapricciante scena del morso letale della pantera in gabbia che mostruosamente stacca il braccio a un custode dinanzi agli occhi bellissimi dalle iridi magneticamente cangevoli ma, in tale frangente agghiacciante, allucinati e inorriditi, impietriti della scioccata Irina/Kinski. La cui espressione del suo viso stupendo repentinamente viene rattrappita in una smorfia di terrore abnorme. Il bacio della pantera funziona sul versante prettamente viscerale, dimostrandosi invece quasi penoso e dozzinale nella sua parte specialmente centrale e soprattutto palesandosi ai nostri occhi di spettatori, giustappunto, adulti e smaliziati, ingenuamente ed esageratamente ricolmo di nauseanti, tristi e troppo chiaramente esplicitate allusioni sessuali che dopo un po’ inevitabilmente stancano e stomacano in modo indigeribile e funesto. Voleva essere un pugno allo stomaco ma appare soltanto un pugno agli occhi, figurativamente parlando, scagliato volgarmente verso il buon gusto, sconfinando nel truculento sanguinoso più grottesco che è un triste affronto alla nostra tollerabilità. E sinceramente, tutto ciò, da un regista dotato di enorme acume e finissima sensibilità come Paul Schrader, non è minimamente accettabile. La bella, secca e classica fotografia chiaroscurale, in perfetta linea col clima sudaticcio e malsano della vicenda narrataci e mostrataci da Schrader, è evocativa e magistralmente firmata da un ispirato, specie nelle scene notturne, John Bailey (Qualcosa è cambiato).
Malcolm McDowell, al solito, risulta una scelta azzeccata e vincente per interpretare il repellente personaggio del fratello di Irina. Nei folli lineamenti, infatti, della sua faccia eternamente incastonata nell’immaginario collettivo da disturbato Alex di Arancia meccanica, è impresso iconicamente il ritratto fisionomico dell’uomo psicologicamente tanto instabile quanto interiormente fragile e dunque capace, da un istante all’altro, di poter compiere scellerate nefandezze anche sessualmente malate.
Discrete le musiche di Giorgio Moroder (Scarface) e notevole la canzone dei titoli di testa cantata da David Bowie e da lui scritta, intitolata Cat People (Putting Out Fire). Ovviamente però, il punto di forza de Il bacio della pantera è l’adorabile Nastassja Kinski, stordente e accecante ipnoticamente, Poiché, in particolar modo, nella seconda ora del film, si scatena in esuberanti, strepitosi e inarrivabili nudi abbondanti da incorniciare indelebilmente e marmoreamente nella storia, nudi sfavillanti da immediato, virile innamoramento e folgorazione godibilmente contemplativa di noi attoniti, ammirati e da lei indotti in stato piacevolmente catatonico. Essendo qui, Nastassja, allo zenit della sua femminilità immane e incredibile, lussuriosamente esagerata. Nudi parsimoniosi nei quali la sua beltà acerba eppur seducente in maniera sconfinata, meravigliosamente, risplende in tutta la sua armonica, magnificenza irresistibilità impressionante, paradisiaca e superbamente graziosa. Illuminandoci di soavità lucente e d’idilliaco incanto venerante, non solamente in forma platonica, la sua Venere incarnata con sex appeal travolgente e scultoreo infinitamente. Una donna favolosa, grandiosamente deliziosa e, in tal caso, nient’affatto pruriginosa a svelarsi in tutta la sua carica erotica impetuosa e per noi ardimentosa. Insomma, un capolavoro di donna ma il film è, sostanzialmente, ben poca cosa.
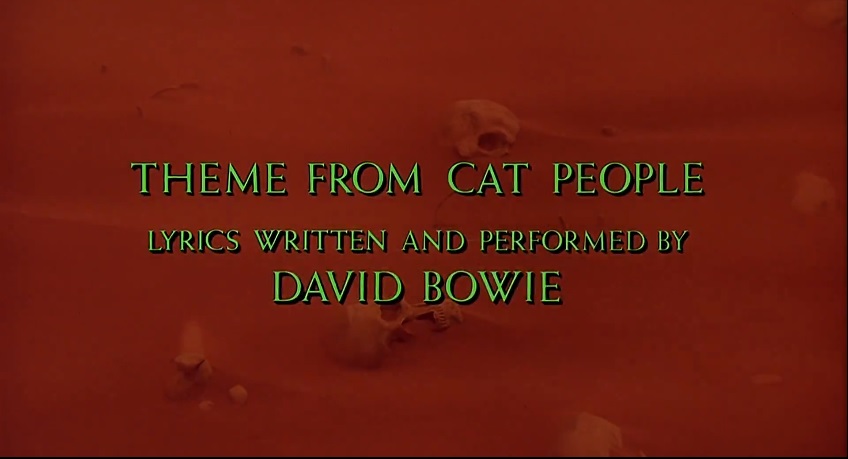
di Stefano Falotico
CAPE FEAR – IL PROMONTORIO DELLA PAURA, un cofanetto Blu-ray imperdibile e da collezione

Ebbene, in concomitanza con l’uscita, in cofanetto e in contemporanea, di entrambe le versioni in Blu-ray di Cape Fear (questo il titolo originale sia dell’originale che del suo remake che tratteremo seguentemente nella nostra breve disamina e tratteggeremo nei punti recensori più salienti, speriamo esaustivi, sottotitolato Il promontorio della paura, che altri non è se non il titolo italiano anche del capostipite), giustappunto, raffronteremo e compareremo il rispettivo film di J. Lee Thompson (I cannoni di Navarone) del 1962 e la versione “modernizzata” firmata da Martin Scorsese (The Irishman) del 1991. Opera, quest’ultima, già ampiamente espostavi nella sottostante recensione qui affissavi.
Tutt’e due le pellicole, ovviamente dalla trama similare, sebbene nel suo rifacimento scorsesiano decisamente rielaborata con non poche licenze autoriali ben differenti dalla pellicola di Thompson, presentano su per giù tale vicenda narrataci e da noi prossimamente enunciata. Lineare, narrativamente molto semplice, incentrata su una storia atroce e infermabile di vendetta furiosa.
Sia ne Il promontorio della paura di Thompson che nel Cape Fear di Scorsese, i nomi e cognomi dei due protagonisti, vicendevolmente antagonisti, sono identici, ovvero Max Cady & Sam Bowden, interpretati da Robert Mitchum e Gregory Peck (i quali, per il film di Scorsese, torneranno in piccoli cammei centrali e in ruoli, in un certo senso, antitetici). Fra parentesi, inseriremo i nomi degli attori di ambedue le pellicole che hanno, per l’appunto, incarnato lo stesso character o, che dir si voglia, personaggio cinematografico assai iconico:
Max Cady (Mitchum e Robert De Niro) è un galeotto dal fisico taurino, palestrato e dalla scorza più tosta e granitica d’un marmo inscalfibile, dotato di straordinaria possanza fisica e soprattutto incattivitosi spietatamente, appena uscito di prigione dopo aver scontato una dura, aberrante condanna esiziale per stupro commesso ai danni d’una donna innocente. Riagguantata la libertà, anziché godersela e vivere riabilitato e spensieratamente appagato nel mondo, ostinatamente e terroristicamente insegue un solo pericoloso e funereo obiettivo implacabile, mostruoso o forse addirittura, paradossalmente, sacrosanto. Perlomeno, secondo il suo punto di vista moralmente ambiguo o, chissà, terribilmente giusto e biblicamente punitivo. Poiché, nonostante sia libero, ritiene di essere stato derubato dei suoi anni migliori, ingiustamente e impunemente…
Cosicché, mosso da bellicosi pensieri di rabbia incontenibile, dà oscenamente filo da torcere continuo al suo ex legale Samuel Bowden (Peck e Nick Nolte), colpevole imperdonabile, a suo dire, di averlo difeso male durante la difesa in tribunale, in quanto gravemente responsabile arbitrariamente d’aver violato un principio assolutamente importante della Costituzione statunitense, cioè il Sesto Emendamento, secondo cui qualsiasi cittadino, macchiatosi o meno del reato per cui è giudicato e processato, ha comunque diritto insindacabile di potersi e doversi avvalere di un equo, probo e imparziale avvocato che, per nessuna ragione al mondo, nemmeno di natura etica, a prescindere dall’accertamento futuro dell’eventuale colpevolezza dell’indagato, deve contravvenire laidamente o per ragioni disoneste al segreto professionale.
Mentre e a dispetto di ciò, secondo Max, Bowden avrebbe volontariamente omesso un fascicolo d’assoluta rilevanza in termini giuridico-penalistici che sarebbe stato decisivo non tanto per dargli l’assoluzione, questa, sì, alquanto improbabile date le sue comunque ammesse e coscienti colpe incontrovertibili da lui stesso sinceramente dichiarate con sana contezza, quanto per ridurgli la pena drasticamente, favorendolo non poco ed evitandogli una prigionia troppo lunga e sproporzionata, a suo avviso, in proporzione al crimine commesso. In quanto si trattava d’un fatale documento contenente particolari determinanti ai fini processuali che avrebbero nettamente smorzato il triste gravame alla base del capo d’imputazione emessogli contro troppo duramente.
Al che Cady, irredimibile e soprattutto instancabilmente accecato dalla sua furibonda eppur al contempo furba voglia di vendetta inestinguibile, come detto, inesorabilmente, inizia a terrificare sia Bowden che sua moglie e sua figlia. Attenzione, in tal caso, ovviamente i cognomi delle donne di Samuel rimangono invariati ma, se nella versione di Thompson, si chiamano Peggy (Polly Bergen) e Nancy (Lori Martin), in quella di Scorsese, divengono Leigh (Jessica Lange) e Danielle (Juliette Lewis).
Naturalmente, Cady agisce in modo accorto, sadico, sì, ma scrupoloso al fine di non finire in carcere di nuovo. Cioè, da pazzo lucido, opera contro Bowden in maniera viscidamente subdola e psicologica, scrupolosamente attentissimo a non sconfinare, coi suoi atteggiamenti persecutori, nell’illegalità, conseguentemente in modo tale da non poter essere assurdamente accusato, legalmente parlando, di qualcosa di criminoso e penalmente punibile.
Ebbene, se Il promontorio della paura è un buon thriller/noir di genere piuttosto convenzionale per quanto elegantemente diretto ed egregiamente fotografato, con toni vividi e lividi, dal bravissimo Sam Leavitt, Cape Fear, nelle mani di Scorsese (subentrato alla regia dopo l’iniziale, forte interessamento di Spielberg, rimastone poi fuori ma restatone produttore, dedicatosi a Schindler’s List che, a sua volta e viceversa, aveva attratto Scorsese, per un interscambio registico-amicale veramente affascinante così come noi già vi spiegammo precedentemente), partendo dal materiale originario dell’originale succitato, diviene un film metaforico, sempre connotato da scure e avvincenti, inquietanti tinte thrilling profumate d’entertainment purissimo, apparentemente senza pretese ideologiche pedanti o moralistiche, però corroborate al contempo d’atmosfere e d’una riconoscibilissima poetica perennemente, indissolubilmente allineata all’inconfondibile sguardo e ai classici stilemi scorsesiani, improntati, come sappiamo, sulla variazione tematica, quasi à la Paul Schrader (Taxi Driver docet) dell’afflizione, della redenzione, dell’ineluttabile e duale conflitto, eternamente invincibile, della nostra contradditoria, ipocrita condizione umana condizionata (perdonate il voluto gioco di parole, potremmo dire, ricercatamente mellifluo e allusivo), a livello istintivamente comportamentale, da una farisea natura educativa d’imprinting ineludibile, trasmessoci inconsciamente e in forma falsamente catechistica, religiosamente conflittuale, forse perfino morbosa, ipocrita e perciò, in termini di trasparente eticità nuda e cruda, primordialmente e orridamente sbagliata poiché coerentemente inattuabile, solipsistica e utopistica.
Quindi, il Cape Fear, ponendosi a un livello concettuale-interpretativo ben più alto, filosoficamente intendendoci, rispetto al suo originale progenitore thompsoniano, assurge a pellicola, se non qualitativamente superiore, perlomeno interpretabile sotto maggiori, fascinose e molteplici chiavi di lettura culturalmente più affascinatrici e stimolanti.
Inducendoci a riflessioni non banali né scontate su chi sia, fra Bowden & Cady, il vero mostro e il vero, squilibrato, psicopatico colpevole ignominioso e, nella sua iniqua e inquinata, avvelenata anima forse traviata e insalvabile, profondamente ferito e malato in modo malsano e perverso in forma irreversibile delle più umanamente terribili e penose. Lo sono entrambi? Può essere…
A voi, come si suol dire, spettatori, l’ardua sentenza e il vostro personale verdetto inappellabile e lapidario.
Curiosità: per Il promontorio della paura, le musiche sono di Bernard Herrmann. Il cui ultimo lavoro, come compositore di colonne sonore, è curiosamente avvenuto con Scorsese per Taxi Driver. Suo enorme ammiratore.
di Stefano Falotico
ASSASSINIO SUL NILO (Death on the Nile), recensione


Ebbene, stavolta, libero da legami editoriali, tralasciando il bon ton e il politically correct, spero di potermi sbizzarrire, in tale review alla Falotico purissimo, senz’orpelli e regole redazionali, giornalistiche e via dicendo, nella mia disamina di tale opera di Kenneth Branagh, a mio avviso immensamente sottovalutata, incompresa e, secondo me, ribadisco, straordinaria. Dopo avermi già ammaliato, incantato e fortemente intrattenuto col suo sperimentale, innovativo, postmodernista Assassinio sull’Orient Express, dopo Dave Gahan a colonna sonora d’un trailer eccezionale, coraggioso e fuori da ogni vetusto canone oramai appartenente a un fin troppo classico e vecchiotto passato superato, ecco che la quintessenza del Bardo da lui molto amato, mr. Shakespeare per antonomasia dopo Laurence Olivier, Ian McKellen e Orson Welles, cioè Kenneth Branagh, presente anche nel primo “film-documentaristico” di Al Pacino (un altro gigione splendido di William Shakespeare, uno dei pochissimi italoamericani a conoscere l’autore de Il mercante di Venezia meglio del suo Shylock, eh eh, per la regia di Michael Radford, ovvero il regista-interprete di Riccardo III – Un uomo, un re, Looking for Richard), cioè nientepopodimeno che il sig. e sir interprete e director del suo stupendo, integrale Hamlet, ritorna sul luogo del delitto, no, in territorio Agatha Christie, sostenendo quanto segue nelle sue recenti interviste:
1) «Si tratta di un tipo di film molto cupo, sensuale e inquietante. Di certo è un film che porta avanti il tema del viaggio, che ci conduce in luoghi differenti, grandi ed emozionanti. Tuttavia la storia metterà a disagio in modi che la gente capirà, perché tratta amore, possesso, lussuria, gelosia ed emozioni primordiali che si mettono in mezzo tra le persone».
2) «Penso che ci siano ottime possibilità di farlo. Con decine di libri e racconti, c’è molto materiale e lei stessa ha mescolato spesso i suoi personaggi. Si ha la sensazione di un vero e proprio universo, un po’ come quello di Dickens. Un mondo nel quale vivono vari personaggi. Quindi credo che quest’ipotesi abbia delle possibilità».
Traendo le sottostanti frasi pronunciate da Branagh da Wikipedia che ha tradotto il suo inglese d.o.c., posso qui dire che spero vivamente che Branagh continui a incarnare il suo superbo Hercule Poirot.
Perché il suo Poirot non è Peter Ustinov e non vuole neppure esserlo o forse non esserlo in maniera amletica, ah ah. Cosicché, senza riferirvi la trama di Assassinio sul Nilo, ricalcata piuttosto fedelmente eppur con qualche inevitabile licenza dalla signora dei gialli per antonomasia, che ve lo ridico a fare, Agatha Christie, incorrendo in molti rimandi per via del Covid e del fattaccio scabroso accaduto ad Armie Hammer, alias Simon Doyle con tanto di fotografia di Patrick Doyle, allestendo perfino una storia alla Arhur Conan Doyle, sì, quello del mastino dei Baskerville, con aria ieratica, aplomb imperturbabile simile allo Sean Connery/Guglielmo da Baskerville de Il nome della Rosa di Annaud da Umberto Eco celeberrimo, Kenneth Branagh firma un capolavoro, checché ne dicano i suoi detrattori e buona parte della Critica imbecille e miope, prevenuta e testarda.
Un adattamento geniale di Michael Green a sua volta adattato dallo stesso Branagh al suo mimetismo cineastico e attoriale senza pari. Branagh, nei panni di Poirot, ci sguazza, giganteggia, emoziona e, in alcuni frangenti commoventi, ricorda anche Lino Banfi de Il commissario Lo Gatto. Perché piange in modo toccante eppur pudico, parimenti a Lino di fronte a Maurizio Micheli, quando confessa il dolore per la sua donna perduta alla base, potremmo dire, della sua (non) scelta di attorniarsi soltanto di libri e indagini, perfino di introspezioni alla sua anima e non soltanto riguardanti le sue detection fra i bui anfratti degli orrori umani che celano tanti scheletri nell’armadio.
Un uomo con un dono, come Matt Damon di Hereafter, adoratore di Charles Dickens, un uomo meraviglioso dai modo raffinati e il fiuto di un cane da tartufo. Magistrale in fatto di galanteria, osservatore speciale a cui non sfugge nulla.
E già dapprincipio, quando osserva Doyle/Hammer e la superba, incantevole Jacqueline de Bellefort/Emma Mackey che ballano come se stessero in pista praticamente scopando, comprende che Gal Gadot/Linnet Ridgeway-Doyle, per colpo di fulmine imponderabile, sì, si è alla sveltina, no, molto alla svelta innamorata davvero di lui ma lui sta invece già furbescamente danzando con lei non per far piangere la sua vera lei, bensì per essere l’Amedeo Minghi di Ballando con le stelle. Cioè, uno poco credibile con Samanta Togni.
Poirot/Branagh ha un solo vero amico, Tom Bateman/Bouc. Uno che crede davvero all’amore anche se la madre, interpretata da Annette Bening/Euphemia, cioè l’unica donna al mondo ad aver calmato Warren Beatty, sposandolo, cioè un uomo che ha trombato più donne in una sola notte di Ercole e ha fatto l’amore con donne più belle di Cleopatra, vuole proteggerlo dallo stesso dolore che ora prova Poirot.
Sì, perché il grande amore può donarti felicità enorme ma, se lo perdi, per un motivo o per l’altro, a prescindere dalla sua morte, forse solo per corna, puoi trasformarti in Paul Giamatti nel finale de La versione di Barney.
Gal Gadot veste come Cleopatra in questo film e sarà veramente presto Cleopatra. Russell Brand fa la parte del medico, incredibile! E, onestamente, Gal Gadot è una donna bellissima ma Emma Mackey è forse l’unica donna che riesce a essere, perlomeno in tale pellicola, più sexy di lei e di Samanta Togni.
Ed è più brava dell’attrice preferita da Branagh, cioè Judi Dench. Presente in Assassinio sull’Orient Express e, ovviamente, qui no, solo per motivi da elementare Watson.
Al che Poirot diviene Sherlock Holmes con l’animo puro di Nicholas Rowe di Piramide di paura e la potenza di Ramses II, il più grande faraone egizio di sempre.
Mario Puzo, autore de Il padrino, disse che De Niro, l’unico attore capace di essere grande come Marlon Brando e Don Vito Corleone, non sa recitare Shakespeare e non può fare la commedia.
In Frankenstein di Mary Shelley, prodotto da Francis Ford Coppola, Branagh scelse De Niro per essere suo figlio, la creatura. La sua nemesi.
Branagh, osteggiato da tutti, un uomo che non è figlio di un principe e che ha origini umili e “tristi”.
Che racconta la sua infanzia in Belfast. E ritorna a essere in pole position per l’Oscar. Un gigante!
Finisco così, con la classica mia freddura.
– Ciao, mamma, ti presento Stefano – dice un mio amico.
– Ah, piacere. Cosa fa nella vita? Usa straccio e ramazza? Ed è un coglione come tutti? – risponde e domanda lei.
– No, Stefano fa lo scrittore ed è il più grande scrittore del mondo – replica suo figlio.
– Ah, simpatico. A quando il Nobel? Ah ah! Comunque, presto sarà Pasqua. Dopo i pensierini di Natale di Stefanino, avremo una bella sorpresa nell’ovetto Kinder? Ah ah.
– Mamma, non sto scherzando. È veramente il più grande scrittore del mondo e ha ora la stessa forza fisica di De Niro in Frankenstein.
– Allora, è una tragedia.
– Purtroppo, sì. O forse no. Quando vuole, Stefano diventa Gary Odlman di Dracula di Bram Stoker:
Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.
Morale: nessuno aveva voluto credermi ma sono Matthew McConaughey di Interstellar.
Vi è un mistero immane nella vita, si chiamano occhi. Da essi, capisci se una persona mente, se è triste o felice, se è innamorata o è spenta. E ora sentite i miei occhi? State sentendo questa forza, lo so.
Sono gli stessi occhi di Oldman/Vlad, sono gli stessi occhi di Branagh/Poirot in questo film bellissimo, romantico, sensazionale.
Poiché, così come disse Marlon Brando, non è tanto difficile, alla fin fine, imparare un lungo testo a memoria, il difficile è recitare con lo sguardo.
Dunque, se nella vita recitate, o siete Branagh, De Niro o Brando, oppure la vedo molto dura per voi.
Perché, in tre secondi netti, io ho capito tutto, guardandovi.
D’altronde, ho tanti difetti come tutti ma i miei occhi e la mia voce non si discutono.
Quasi capolavoro. Emozionante, qua e là volutamente sciatto ma ci sta. Branagh non vuole girare Arte. E la dovreste finire con questa parola che ficcate dappertutto a sproposito. Vuole intrattenerci, emozionarci, inquietarci e ipnotizzarci. E ci riesce perché è un genio. Se dite che non è così, forza, andate a pulire i piatti, piattole.


di Stefano Falotico
TERRA DI CONFINE – OPEN RANGE, recensione

In occasione della sua uscita in Blu-ray 4K, oggi recensiamo lo splendido, ahinoi, ultimo film per la regia di Kevin Costner, cioè Open Range. Almeno, per il momento.
Terra di confine – Open Range, film del 2003, purtroppo alquanto sottovalutato ai tempi della sua distribuzione nelle sale. Poiché gli incassi non furono soddisfacenti e molta Critica sbadata, superficiale e arrogante oltre l’indicibile più incomprensibile, la stessa Critica che oggi, quasi unanimemente, contrariamente a quanto pomposamente affermò con prosopopea disarmante e tramite giudizi severamente impietosi, l’ha rivalutato appieno, dopo averlo apertamente snobbato e liquidandolo in fretta e furia, supponentemente, definendolo sbrigativamente un mediocre western facilmente dimenticabile.
Niente di più falso e assurdo. In quanto, il bel Kevin Costner, di Open Range anche ottimo protagonista dalla recitazione ineccepibile e carismatica, dalla presenza scenica spiccata, dopo il trionfo planetario e oscarizzato del suo superbo, inarrivabile e innovativo Balla coi lupi, insignito di sette pregiatissime e assai meritate statuette dorate insindacabili e sacrosante, dopo il suo L’uomo del giorno dopo, ambizioso e anch’esso da ristimare notevolmente, eppur per molti, ancora una volta, da accantonare e obliare prestamente, aggiungiamo noi in modo sesquipedalmente erroneo, si presentò alle platee del mondo con tale Open Range, per l’appunto.
Scontentando, come già dettovi e or rimarcatovi, la maggioranza della gente e dei critici. I quali presero una cantonata di proporzioni ciclopiche poiché Open Range è un capolavoro. Un epico e al contempo intimista, particolare e assai personale western dalle tonalità crepuscolari e soavemente malinconiche, impregnato di romanticismo struggente, un’opera di raro pregio e suadente bellezza, rifulgente di mirabile sofisticatezza omaggiante perfino il classicismo dei migliori John Ford di sempre.
Della durata di due ore e venti minuti circa, Terra di confine – Open Range, su sceneggiatura di Craig Storper, è tratto dalla novella, inedita in Italia, The Open Range Men di Laurain Paine.
Trama, molto sintetizzata:
Siamo nel Montana del 1882. L’aitante cowboy Charley White (Kevin Costner), il corpulento Mose (Abraham Benrubi), il giovanissimo Button (Diego Luna) e l’anziano eppur ancora gagliardo Gelsomino Spearman, detto Boss (Robert Duvall), sono quattro mandriani che, lungo le verdeggianti praterie sconfinate dell’America, conducono il gregge regolarmente al pascolo.
Qualcuno, non staremo a dirvi chi, in assenza di Charley e Boss, è stato ammazzato vigliaccamente e il bestiame derubato. Al che comincerà la caccia spietata all’uomo o ai banditi che hanno commesso il vile, imperdonabile affronto. Fra inevitabili colpi di scena e non pochi tradimenti violenti…
Intanto, nel succedersi incalzante degli avvenimenti, prima della risoluzione a fuoco del finale della resa dei conti con tanto di sparatoria mozzafiato e al cardiopalma, entra in gioco anche l’amore di Charley per la sensuale, avvenente, matura Sue Barlow (Annette Bening). E i loro cuori s’infiammano di passione dolcemente armonica.
Nel cast, fra gli altri, Michael Gambon e James Russo.
Fotografia elegantissima di J. Michael Muro per un anomalo western romantico al massimo, d’altissima scuola registica, sopraffino e sia diretto che interpretato da Costner in modo carismaticamente divino.
Imperdibile, straordinario, fuori dal tempo, Cinema puro nella sua essenza più adamantina, emozionante dal primo all’ultimo minuto, di gran classe e da vedere se non l’avete mai visto per la prima volta oppure da rivedere assolutamente quanto prima.
Secondo me, capolavoro. O quasi. Se non vi sta bene, lasciatevi cavalcare dalle vostre donne. Comunque, più che uomini cowboy e da cowgirl, siete messi a pecora. Sembrate delle povere pecor(in)e smarrite come quelle che vengono, in tale film, fottute. Ah ah. E non fate i santarellini.
di Stefano Falotico
IL GATTO A NOVE CODE, recensione

Ebbene, in occasione dell’uscita in sala di Occhiali neri e in concomitanza con le relative uscite in Blu-ray delle pellicole sotto citatevi e da noi precedentemente analizzate, continuiamo e terminiamo qui la nostra breve retrospettiva concernente quattro film importantissimi di Dario Argento. Perciò, dopo Tenebre, Phenomena e il suo esordio registico, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo, arriviamo e momentaneamente concludiamo qui il nostro argentiano viaggio filmografico-recensorio con Il gatto a nove code (The Cat o’ Nine Tails).
Cioè, la sua seconda prova dietro la macchina da presa, avvenuta esattamente nel ‘71. L’anno immediatamente successivo a quello in cui avvenne, per l’appunto, il suo esordio sopra appena elencatovi e detto.
Il gatto a nove code, film della durata di circa centododici minuti corposi e netti.
Il gatto a nove code, ai tempi della sua release in Italia, soddisfò ampiamente le aspettative e ottenne il successo sperato. Ripagando appieno i desideri dei produttori. Gli incassi, infatti, furono molto alti, perlomeno per gli standard e canoni dell’epoca. Inizialmente, però, Argento, malgrado la straordinaria accoglienza sia da parte degli spettatori che dell’intellighenzia critica, riguardante L’uccello dalle piume di cristallo, incontrò non poche difficoltà finanziare al fine di poter realizzare tale sua seconda regia. Fu grazie agli americani della National General, rimasti incantati nei riguardi de L’uccello dalle piume di cristallo, che poté portare a compimento Il gatto a nove code. Film da lui, peraltro, interamente sceneggiato, oltre che ovviamente diretto, a partire da un soggetto originale scritto con le collaborazioni di Luigi Collo e Dardano Sacchetti. E l’apporto, non accreditato, di Bryan Edgar Wallace.
Il gatto a nove code, aggiungiamo, non è soltanto la seconda opus di Argento, in termini cronologici inerenti il suo excursus cineastico, bensì è anche, naturalmente e logicamente, pleonastico ma opportuno ribadirlo, dopo L’uccello dalle piume di cristallo, il secondo suo film appartenente alla cosiddetta Trilogia degli Animali.
Trama e breve giudizio in merito del Morandini dizionario dei film, a cui aggiungeremo fra parentesi i nomi dei personaggi e dei loro interpreti principali:
«Fatti misteriosi accadono in un centro scientifico dove si studiano la genetica e l’ereditarietà. Alle indagini partecipano un giornalista (Carlo Giordani/James Franciscus) e un enigmista cieco (Franco Amò/Karl Malden). Quattro morti violente prima di identificare l’assassino. 2° film di Argento. Molti difetti nella struttura narrativa, ma la contrapposizione tra l’occhio abnorme dell’assassino e la cecità dell’investigatore e la lunga sequenza del cimitero sono le testimonianze di un talento onirico-nevrotico».
Naturalmente, è molto più complicata e variegata la vicenda e articolata, in modo labirintico, la storia da Argento narrataci, per l’appunto diramataci nella fitta rete d’inganni sottili e perfidi, di losche doppie piste e doppiogiochisti, di raggiri e persino d’inseguimenti automobilistici spericolati e desueti per i canoni di regia argentiani. In cui un ruolo centrale è affidato alla seduttiva e attraente Anna Terzi/Catherine Spaak.
Musiche, al solito pertinenti, evocative e di profonda atmosfera suggestiva, nient’affatto sdolcinate, a differenza invece di quanto scioccamente affermato e tristemente equivocato invece nel dizionario Mereghetti, dopo L’uccello dalle piume di cristallo, di Ennio Morricone. Che poi Argento avrebbe “tradito”, affidandosi ai Goblin.
Montato dal fido ed esperto, valido Franco Fraticelli, fotografato meravigliosamente dal compianto Erico Menczer (Sbatti il mostro in prima pagina).
Bellamente tetro, ricolmo brillantemente di argute battute che stemperano sapidamente la tensione e risultano corrosive, taglienti, più pungenti delle lame utilizzate dall’assassino ricercato, ricercatissimo nei particolari, è però stranamente il film che, per stessa ammissione di Argento, lui ama meno, a torto e a nostro avviso. In quanto, sebbene imperfetto, dal finale leggermente fiacco e in molte sue parti incompiuto, disomogeneo e meno emotivamente impattante, per l’appunto compatto, rispetto ad altre opere più potenti di Argento, Il gatto a nove code emana straordinariamente, irripetibilmente il suo ammaliante fascino godibilmente malsano, trattando e ben sviluppando tematiche di matrice lombrosiana e di natura investigativa a riguardo che non passeranno mai di moda. Mindhunter docet. Cosicché, Il gatto a nove code divenne, all’istante, un importante modello d’ispirazione per altre pellicole, non solo argentiane, a venire, divenne forse perfino involontariamente una fascinosa storia di detection non priva di elementi perturbanti ancor oggi capaci di emozionarci e inconsciamente disturbarci con finezza qualitativa del tutto non trascurabile.

©girella/Lapresse
archivio storico
spettacolo
anni ’60
Catherine Spaak
Nella foto: Catherine Spaak, l’attrice francese, fotografata in un salotto
di Stefano Falotico
PHENOMENA, recensione

Ebbene, con l’uscita in sala della nuova opus di Dario Argento, cioè Occhiali neri, ne abbiamo approfittato per disaminare alcune opere del maestro suddetto, inoltre uscite recentemente in home video. Per un tuffo meandrico, in senso metaforico, speriamo fascinoso, all’interno degli anfratti affascinanti, perturbanti, soavemente ammalianti del suo Cinema fantastico tout–court, immaginifico, spesso contestato, ultimamente, ahinoi, bistrattato e scarsamente considerato, più e più volte, negli ultimi anni, tristemente soprattutto nelle ultime due decadi, con faciloneria disarmante, scioccamente snobbato e frettolosamente liquidato con irrispettosa superficialità, osiamo dire, nauseante.
Cosicché, dopo le nostre disamine di Tenebre (1982) e del suo apoteotico, brillante esordio registico a tutt’oggi insuperabile ed estasiante, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo (1970), è or il turno di Phenomena, horror sovrannaturale che, in forma generalista e dizionaristica, viene ascritto alla cosiddetta Trilogia degli Animali argentiana.
Phenomena è una pellicola del 1985 della durata di due ore circa, minuto più minuto meno, brevemente accorciata per il mercato internazionale ove è nota anche col titolo Creepers.
Sceneggiata dallo stesso Argento, oltre che naturalmente da lui diretta, assieme a Franco Ferrini a partire da un soggetto originale scritto con quest’ultimo a quattro mani.
Ferrini, fra gli sceneggiatori del mastodontico ed epico C’era una volta in America di Sergio Leone, per cui peraltro Dario Argento fu tra i writer di C’era una volta il West (non scordiamolo mai perché di rilevante importanza imprescindibile all’interno della sua carriera impari e precocemente già molto avanti).
Ferrini, autore anche di Occhiali neri.
Come sappiamo, una delle protagoniste del film appena menzionatovi di Sergio Leone, fu nientepopodimeno che Jennifer Connelly. Perlomeno, nella parte sua iniziale nei panni della giovane Deborah. Che, nel corso della narrazione e nell’avanzamento della sua età, fu incarnata poi da Elizabeth McGovern.
Connelly, al massimo qui della sua avvenenza adolescenziale e all’apice del suo splendore magnetico veramente eclatante, la quale interpreta una giovanissima ragazza omonima, cioè Jennifer. Jennifer Corvino, italoamericana e figlia del fittizio, famoso attore Paul Corvino. Da non confondere col realmente esistente Paul Sorvino.
Secondo il valente dizionario Morandini, eccone la piccola sinossi esaustiva e le sue lucide, sebbene leggermente opinabili considerazioni in merito: «Jennifer (Connelly), in Svizzera per studiare, si trova coinvolta in misteriosi assassinii di ragazzine dai quali esce incolume grazie al suo rapporto parapsicologico con gli insetti e all’aiuto di un entomologo paralitico (Donald Pleasence). Sulla scia di Suspiria (1977), la natura ha un posto importante nel 9° film di D. Argento: il vento (phön), l’acqua, gli animali (lo scimpanzé vendicatore), soprattutto gli insetti per i quali il regista mette in opera acrobatiche tecniche di ripresa, contrapposti al degrado degli umani con il punto più basso toccato dal mostruoso figlio di Mrs. Bruckner (make–up dell’ottimo Sergio Stivaletti). Il programmatico disinteresse per la logica narrativa esplode nel delirio truculento dell’ultima mezz’ora con 4 o 5 finali infilati l’uno nell’altro, ulteriore dimostrazione di un narcisismo esibizionistico quasi disperato».
Non concordiamo, a dir il vero, molto col giudizio recensorio espresso da Morandini, il quale assegnò due stellette e mezzo (su una scala da una a cinque) al film di Argento, contestandone, come avete appena sopra letto, i troppi forzati colpi di scena finali, secondo lui allestiti a mo’ di matriosca con esagerati, non necessari twist e da lui reputati noiosamente ripetitivi.
Però aggiungiamo altresì che Phenomena non è quel grande film di cui i fan di Argento si riempiono la bocca, incensandolo incessantemente di lodi sperticate, incapaci di esserne obiettivi per via della loro miope, ottusa, manifesta adorazione e infermabile idolatria nostalgica per l’Argento loro beniamino, specialmente delle sue pellicole del passato.
Phenomena è un film che, oggettivamente, rivisto oggi e col senno di poi, appare indubbiamente datato, risulta in molti punti quasi addirittura trash ma è terribilmente amabile in quanto simpaticamente naïf.
A partire da una Dalila Di Lazzaro altezzosa e dallo sguardo perennemente severo, ben poco credibile nei panni della direttrice dell’istituto collegiale nelle cui estreme vicinanze il maniaco-mostro semina morte, panico e terrore a tutt’andare e senza soluzione continuità alcuna.
Puntellato dall’incalzante, inquietante colonna sonora, a modulazioni assai elettroniche, degli onnipresenti Goblin, presenze fisse, in quegli anni, nel Cinema di Argento, Phenomena abbonda anche, nella sua soundtrack, di tracce importanti degli Iron Maiden e dei Motörhead.
Onestamente, a volte la musica è, sebbene funzionale quando puntualmente utilizzata per alimentare e aumentare la suspense delle scene topiche a maggior tasso di suggestione emotiva e paura indottaci, al contempo troppo invadente e per l’appunto insistita sin allo sfinimento tedioso. Quasi fosse stata introdotta persistentemente per dilatare a iosa e colmare molte scene forse superflue o un po’ monotone.
La Connelly, per quanto già talentuosa e brava, in alcuni frangenti pare spaesata, ancora troppo acerba e incerta, non soltanto a causa sua poiché la sua qua e là titubante recitazione non appieno convincente non è sempre ben diretta con mano ferma, decisa e rigida.
Detto ciò, Phenomena mantiene intatti molti pregi innegabili ed evidenti.
Pregevole è infatti la fotografia di Romano Albani. Qui alla sua seconda collaborazione con Argento dopo Inferno. Venne smentito però il facile detto non c’è due senza tre. In quanto, Albani e Argento, dopo le prime due esperienze collaborative, non incrociarono più i loro destini professionali-artistici.
Montaggio di Franco Fraticelli (Dellamorte Dellamore).
Nel cast, Daria Nicolodi, Federica Mastroianni, Michele Soavi e Patrick Bauchau.

di Stefano Falotico













