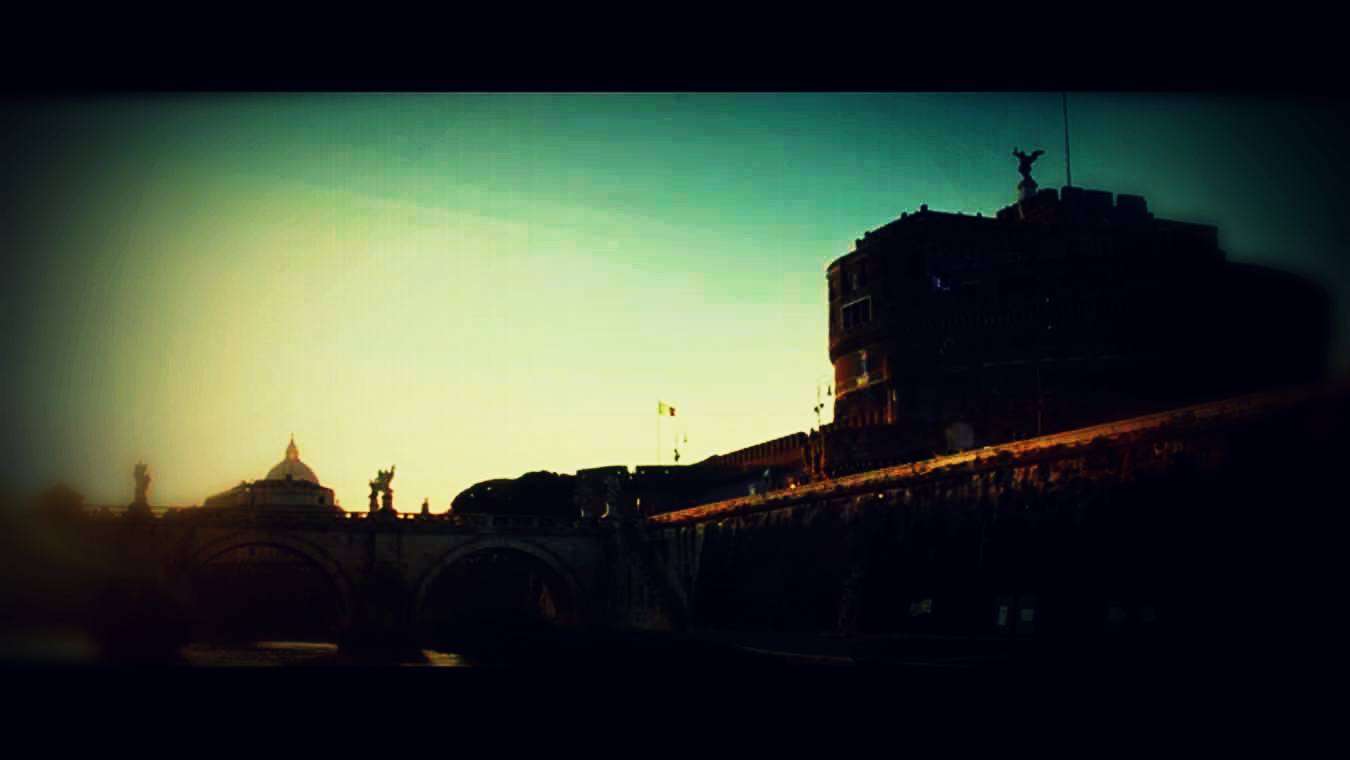“La grande bellezza”, recensione
La grande bellezza è un film enorme e grandioso anche solo per la maniera suadente e meravigliosa con cui sfugge allo sguardo di chi lo guarda, proprio come una donna così avvenente da togliere il fiato ma con addosso un’aura di segretissima ritrosità. Per il modo in cui si sottrae, mellifluo e sornione, alle globali e facili letture di senso, come un gatto furbissimo, di quelli che hanno i baffi lunghi e ondeggianti. Un film bello ma non feroce come ce lo si aspetterebbe, con quello stesso vago sentore di indulgenza che si respirava ne Il divo, anche se qui la tonalità del racconto è a tratti meno stilizzata e più solenne (che musiche, in un continuo malickiano levare…), asservita a un’incessante danza pagana.
È un film senz’altro da rivedere, non facile, da ripensare per molto tempo ancora. Ma è pur vero che nella seconda parte il talento di Sorrentino pare come sedersi, in attesa di un’epifania definitiva che non arriva mai, inseguendo con la percussione dello stile la (sua) grande bellezza ma dando al contempo l’idea di non riuscire mai completamente a raggiungerla. Sorrentino si rintana (luminosamente, eh) nei propri misteri, da meraviglioso rabdomante qual è. Nel finale riflette sull’essenzialità (ed è emblematico che lo faccia, proprio lui…), come suggerendo che se la religiosità è povera e pauperista, l’arte invece, se è vera arte, non può che essere profana, (e quindi) opulente. Alla fine, dopotutto, “è solo un trucco”, nella vita, nel cinema, nel (loro) racconto. Però la sensazione è che la frase di Jep Gambardella – stavolta – valga anche per Sorrentino: “È così brutto essere bravi. A forza di essere bravi, si diventa abili”.
Davide Stanzione